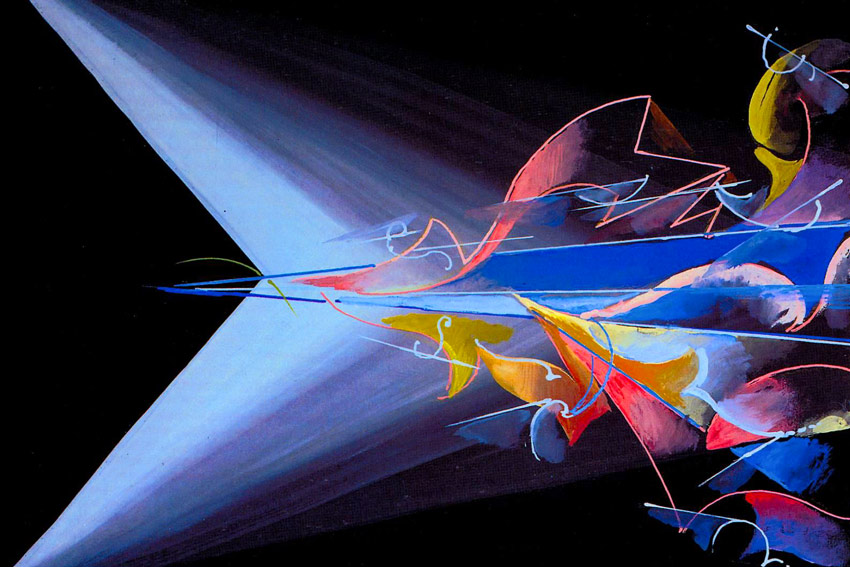Quando abbiamo deciso di dedicare una rubrica alla filosofia, la scelta del nome è caduta su “dia-logos”: non è un caso. Il dialogo non è soltanto l’origine storica della filosofia, basti pensare ai dialoghi di Platone, ma ne costituisce l’essenza. Anzi, possiamo proprio dire che il dialogo costituisca la logica stessa del filosofare.
Il dialogo nasce infatti dal confronto di posizioni differenti. Nel dialogo si pongono delle tesi, che vengono poi poste a critica, e dunque confutate. Abbiamo dunque un’opposizione, un fronteggiarsi di due pensieri, due discorsi, due entità: A e non-A; B e non B, e così via, dove “non-A” e “non-B” sono la confutazione di A e B. La confutazione, però – quando il dialogo è proficuo – non è sterile e fine a se stessa, ma apre a una revisione, a una ri-flessione, che permette di riformulare la tesi su nuove basi.
Il momento negativo, dunque, è fondamentale per il progredire della conoscenza. Tuttavia, ha trovato piena legittimità filosofica solo in tempi tutto sommato recenti. La branca della filosofia nata dal dialogo, la “dialettica”, ebbe infatti alterne vicende nel corso dei secoli, venendo spesso relegata a “scienza dell’apparente”. La ragione di questo deriva dal fatto che il contrapporsi di due discorsi, uno che afferma una tesi e l’altro che la nega, è una contraddizione: abbiamo davanti due possibili verità, e non sappiamo quale scegliere. Non è un caso che proprio su questo problema sia nata la tragedia greca: il sentimento “tragico” si manifesta proprio quando ci troviamo davanti due ragioni, due modi di intendere il mondo antitetici, e non siamo capaci di scegliere.
Per gran parte della filosofia antica, e soprattutto per Aristotele, il mondo non può essere contraddittorio: come può una cosa essere vera e falsa insieme? Essere se stessa e al contempo un’altra cosa? Se possiamo giungere a una verità, questa non può essere contraddittoria. Quindi la contraddizione dev’essere per forza soltanto un’apparenza, una “scorza” del reale: qualcosa di superficiale, superato il quale possiamo giungere alla “vera” conoscenza.
Questa è in estrema sintesi l’idea aristotelica di verità, basata sui famosi tre principi della logica: il principio di identità, per cui A è uguale ad A («A = A»), il principio di non contraddizione, per cui A non può essere uguale a A e nello stesso tempo diversa da A (non «A = A» e «A = non-A») e principio del terzo escluso, per cui o è vera A o e vera la sua negazione («o A o non-A»).

Il termine dialettica è sopravvissuto nel corso dei secoli e ha avuto anche un’accezione positiva: nel medioevo erano definiti “dialettici” coloro che pensavano si potesse raggiungere la conoscenza per via di ragione e non per via di fede; la dialettica era una delle scienze del trivio, che si occupava del discutere e del parlare in modo logico e corretto. Ma, nello stesso tempo, è sopravvissuta l’idea aristotelica per cui la dialettica fosse un sapere dell’apparenza, che si occupa della superficie della realtà e non della verità profonda, che invece è patrimonio dell’analitica, cioè la logica.
Ancora Kant è debitore di questa idea, e infatti chiama “dialettica” la sezione della Critica della ragion pura dedicata a ciò che egli chiama «illusione trascendentale»: l’inevitabile tendenza della ragione umana a occuparsi di oggetti di cui non può avere alcuna esperienza e su cui perciò può formulare a buon diritto giudizi antitetici.
Questi oggetti sono notoriamente tre: Dio, l’anima e il mondo come infinità. E per ciascuno di essi Kant procede a una disamina delle posizioni irriducibilmente opposte e inconciliabili: di Dio è possibile affermare con egual certezza che esiste e che non esiste; del soggetto che è un «ente sussistente per se stesso» (una sostanza) e che perciò esiste l’anima, e al tempo stesso che non lo è e che quindi l’anima non esiste; e infine del mondo che esso è infinito ed eterno ma anche che è finito nel tempo e nello spazio. Allo stesso tempo, però, in questo modo lega il termine alla definizione dei limiti del conoscibile, “l’isola della conoscenza” di cui parlavamo in questo articolo.
Entriamo più nel merito della questione. Aristotele, nella Logica, si preoccupa di classificare i giudizi, cioè le frasi (o meglio, la relazione tra un soggetto e un predicato), e lo fa in base a quattro categorie: quantità, qualità, modalità e relazione.
Kant fa un passo ulteriore: per lui queste categorie non riguardano semplicemente i giudizi, cioè le espressioni linguistiche, ma sono innanzitutto forme del pensiero o, per usare le sue parole, dell’intelletto. In altre parole, l’intelletto può operare solo attraverso queste quattro categorie.
Il ragionamento di Kant era più o meno questo. Ogni nostro giudizio («A è B», «D è F»…) è possibile perché noi classifichiamo, in modo spontaneo, il materiale datoci dall’esperienza. Le suddette categorie dell’intelletto sono il modo con cui classifichiamo la realtà: sono le “scatole”, per così dire, in cui mettiamo ciò di cui abbiamo esperienza. E dunque, come per inscatolare degli oggetti dobbiamo prima avere delle scatole, così anche le categorie sono delle forme a priori della conoscenza: sono innate, prescindono dalla nostra esperienza, e dunque sono necessarie e universali.

La questione in realtà pone una serie di problemi ulteriori, tra cui una domanda che viene sollevata soprattutto dagli autori che vennero dopo Kant: perché proprio queste categorie e non altre?
Già con Fichte infatti ci si rese conto che Kant non riuscì affatto a spiegare perché l’intelletto opera con quelle categorie e non altre. Le ha trovate, diciamo così, da Aristotele e le ha prese per buone, ma probabilmente se Aristotele ne avesse elencate altre, avrebbe assunto quelle. O se Aristotele ne avesse aggiunta un’altra, magari Kant avrebbe parlato di cinque forme a priori della conoscenza e non di quattro.
Ci si rese conto, dunque, che le premesse di Kant erano troppo arbitrarie, e doveva essere ripensata. Per farlo, però, era necessario dimostrare tutto daccapo. L’intero edificio delle scienze, dei suoi metodi e dei suoi contenuti. La logica materiale di Kant per resistere a se stessa doveva farsi ontologia e metafisica. Dimostrare l’intrinseca necessità del mondo com’esso è fatto: ecco la parola d’ordine del post-kantismo.
E così Fichte, poi Schelling ed Hegel, iniziano a porre l’accento su una questione che Kant ha perso di vista: la dialettica, intesa come “momento negativo“, come atto della negazione. Fichte inizia quindi a ragionare sul concetto identità, cioè come facciamo a dire che A sia uguale ad A, e imposta la questione attraverso tre principi, o meglio, tre momenti: 1) «L’Io pone se stesso»; 2) «L’Io oppone a sé un non-Io» e 3) «L’Io oppone, in sé, ad un io finito un non-io finito».
Fichte sta in un certo senso riprendendo i tre principi aristotelici, ma in realtà cambia sensibilmente la questione: innanzitutto non si tratta di tre principi separati, ma tre fasi dello stesso processo, e poi il contenuto dei tre enunciati è molto diverso.
C’è una prima fase, che è quella dell’identità, dove diciamo che A è uguale ad A; c’è poi una seconda fase, in cui diciamo che se A è A, allora significa che A non è qualcos’altro, e cioè che A è non-A; infine, abbiamo un momento di sintesi di questi due fasi, in cui non si deve scegliere tra A e non-A, come nel terzo principio aristotelico, ma A e non-A stanno insieme: l’io è immediatamente io e non-io.

Fichte in questo modo fa sì che la contraddizione non sia un problema da espungere la realtà, ma parte della realtà stessa: non possiamo definire qualcosa senza nello stesso tempo fare riferimento a qualcosa d’altro; se diciamo che A è A, questo significa che A non è B, non è C, non è D. E dunque A ha già in sé un momento negativo, un’opposizione, una contraddizione. La contraddizione diventa un modo di essere del mondo. Anzi, il modo.
Il ribaltamento è radicale. Se fino ad allora l’essenza della realtà era considerata lineare e la contraddizione era mera apparenza soggettiva, ora la prospettiva è opposta: la contraddizione non solo è parte della realtà, ma ne diviene il fondamento, addirittura il motore. Non è infatti possibile affermare qualcosa senza negare il suo opposto, né è possibile considerare qualcosa senza considerarne anche la sua negazione. Già Spinoza aveva scritto in una lettera: «la determinazione non appartiene alla cosa secondo il suo essere; al contrario essa è il suo non essere», che Hegel poi riprenderà nel motto «Omnis determinatio, negatio est», ogni determinazione è una negazione.
La realtà, quindi, appare non come un insieme monolitico e coerente, ma come una rete di opposizioni, di mutue esclusioni: il senso tragico del mondo greco riaffiora nella filosofia, ma riaffiora non più come problema insolubile, ma come un processo che perviene a una risoluzione, a un momento di sintesi. Sarà proprio sul significato di questa “sintesi” che si giocheranno sia la differenza tra Fichte, Schelling ed Hegel, sia la filosofia post-hegeliana, e in particolare la risposta che darà Marx.
Infatti tenere insieme le contraddizioni è meno semplice di quanto possa apparire, e porta con sé una serie di problemi filosofici che verranno affrontati lungo l’Ottocento e per parte del Novecento.
Nonostante oggi la filosofia dialettica sia poco frequentata, è invece di enorme importanza: lo studio della realtà come contraddizione ha permesso di spiegare, per esempio, alcuni aspetti del funzionamento della scienza (a questo proposito è da citare il contributo di Imre Lakatos). Ha poi avuto, con il marxismo, delle importanti ripercussioni politiche: è da qui, infatti, che nasce l’idea che la filosofia non sia semplicemente un modo di studiare la realtà, intesa come un oggetto che sta fermo davanti a noi, ma un modo per interagire con essa, e dunque per modificarla. In altre parole, che la filosofia abbia a che fare con la forma della società, con le nostre convinzioni riguardo ad essa. È da qui che si inizia a capire, insomma, che la verità ha a che fare non solo con l’analisi, ma anche con l’esercizio del potere.