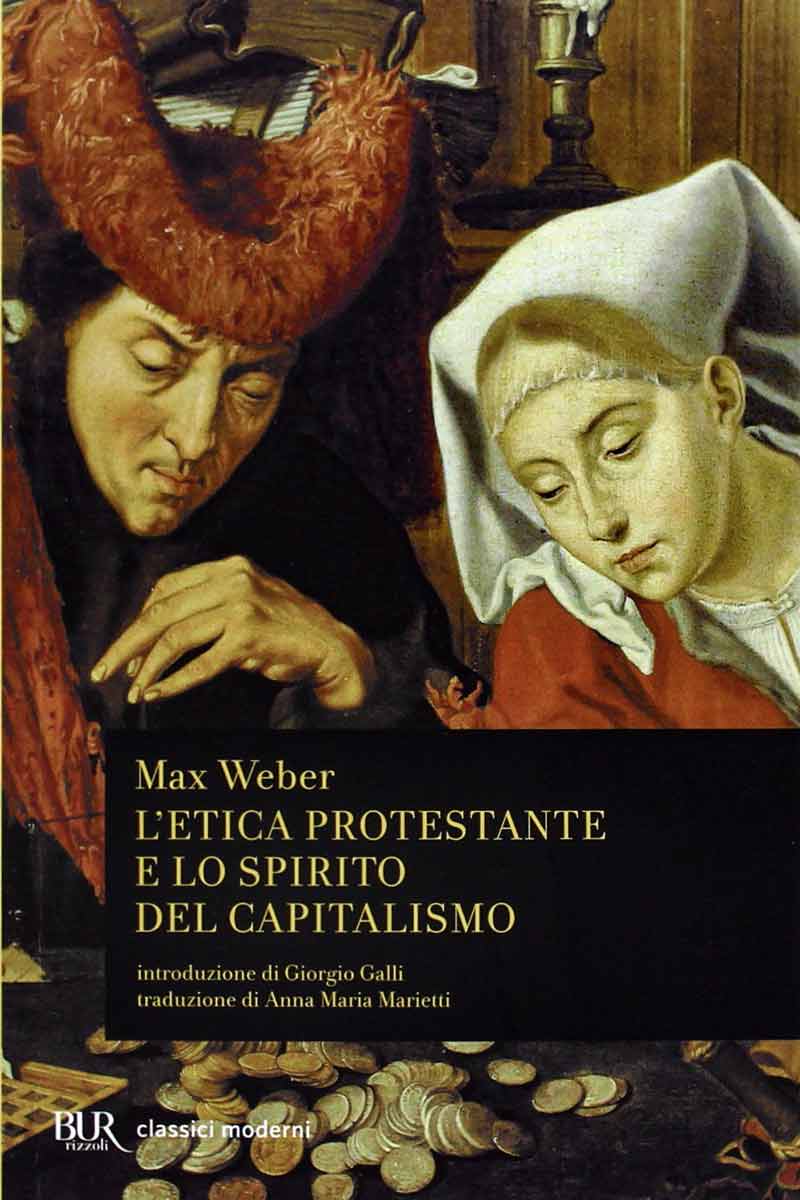Il positivismo sembrava avere le idee molto chiare: a guidare i mutamenti del mondo sono leggi universali e necessarie, che ne costituiscono la trama invisibile, la struttura impalpabile. Noi, particelle di un tutto costrette a guardare il mondo da un punto di vista limitato, possiamo conoscere, ri-conoscere queste leggi, grazie all’osservazione e all’induzione. Questa conoscenza è sì imperfetta, sempre migliorabile, ma l’unica garanzia per piegare il mondo ai nostri fini. Così facendo, l’umanità progredirà verso un avvenire luminoso.
Questo diceva il positivismo, signore delle scienze e della filosofia per quasi cento anni. Signore della filosofia, ma non sovrano assoluto.
Infatti il positivismo non accontentava proprio tutti. Sembrava funzionare perfettamente con le scienze dure, ma con il sapere cosiddetto umanistico le cose non andavano così bene. Se la base del sapere positivistico è l’universalità e la possibilità di generalizzare, allora la storia rischiava di essere ridotta, nella migliore delle ipotesi, a una serie di calcoli statistici. All’universalità della legge andava contrapposta la singolarità dell’evento. Nacque così un’altra corrente filosofica, L’Historismus, che era il campione di questa esigenza di separazione: scienze della natura e scienze dello spirito coabitavano, non convivevano.
Ora però è necessario parlare di chi raccolse le esigenze di queste correnti contrapposte, e provò a superarle.
Questo qualcuno era Max Weber. Quand’era in vita venne considerato perlopiù uno storico e un economista, ma i suoi studi spaziano in notevoli direzioni, e oggi è considerato, assieme ad Émile Durkheim, il padre della sociologia moderna. La sua domanda principale era infatti come comprendere razionalmente l’essere umano.
Gli esseri umani, infatti, sono un oggetto di studio molto particolare: come abbiamo detto, infatti, la nostra specie nel suo agire non opera in modo costante e generalizzabile. Inoltre, se possiamo conoscere qualcosa sull’uomo, ciò è possibile solo grazie all’uomo stesso. Non si tratta più di conoscere un oggetto esterno, ma di conoscere noi stessi, e questo ci priva di quell’obiettività che secondo i positivisti sarebbe necessaria al ricercatore e allo scienziato. Non possiamo essere neutri, insomma.
A Weber spettava il compito di risolvere questo impasse, e conciliare quella che era la necessità positivistica di spiegare i fenomeni attraverso delle leggi, delle costanti, e l’attenzione dell’Historismus per la specificità umana, per il singolo evento.
La strategia che mise in atto, che stupisce ancora oggi per l’eleganza concettuale, fu un sofisticato gioco di ridefinizione delle possibilità e dei limiti della conoscenza. Proviamo a tracciarne uno schizzo a partire da un concetto a cui abbiamo accennato poco fa: la neutralità. Può il ricercatore essere neutro?

La risposta, in senso assoluto, è no. Neanche i positivisti credevano davvero a una totale neutralità da parte dello scienziato, del soggetto conoscente. Quello che però ritenevano assolutamente necessario che questa soggettività venisse ridotta il più possibile. Ogni scostamento dalla neutralità sarebbe arbitrarietà, e dunque impossibiltà di capire il mondo come esso è davvero.
Gli storicisti, al contrario, rivendicano proprio la parzialità della visione umana. «Umano è piuttosto esser parziali», scrisse Droysen (uno dei massimi pensatori del movimento dell’Historismus) nella sua monumentale Istorica. Per gli storicisti non esiste un mondo “come è davvero”, per il sempice fatto che un mondo così, una realtà così esterna, non è pensabile dall’essere umano. Qualsiasi cosa possiamo dire, fare, pensare della realtà la pensiamo dal nostro punto di vista. Uscire dal punto di vista umano non è indice di oggettività, ma di una simulazione di oggettività: non conosciamo le cose per come “esse sono realmente” ma come “esse sarebbero se noi non esistessimo”, e dunque questo si tradurrebbe in una finzione ancora più finta della conoscenza soggettiva.
Weber, in tutto ciò, come la pensa?
Si potrebbe dire che Weber parteggi per gli storicisti, ma sarebbe impreciso. Weber fa molto di più: afferma che la parzialità è condizione di possibilità di una qualsiasi conoscenza. La parzialità è quello che chiama (prendendo in prestito l’espressione dal suo maestro, Heinrich Rickert) il “riferimento ai valori” del ricercatore, in cui “valori” significa sia valori etici, estetici, culturali in generale, sia i fini stessi della ricerca e gli strumenti di cui si dota il ricercatore.
La parzialità dell’uomo infatti non è solo dovuta all’impossibilità di una visione neutrale, ma anche dalle domande che si pone il ricercatore e dai fini che il ricercatore si pone. A seconda di come il ricercatore interroga la realtà, riceverà risposte diverse. Il fine dunque influenza notevolmente la nostra ricerca, ma non è possibile fare a meno di un fine, né di presupposti.
Senza darsi un fine, senza un corollario di conoscenze e credenze preacquisite, senza un contesto culturale e sociale che faccia da retroterra, nessuno potrebbe condurre una ricerca.
Ogni termine, ogni nozione, ogni concetto che usiamo, infatti, rimanda ad un sistema di conoscenze, ad una “intuizione del mondo” complessiva, propria della società nella quale siamo inseriti e che assorbiamo fin dalla nascita. Senza tutto questo, cioè senza un punto di partenza e uno di arrivo, non c’è ricerca: ci sono dati vuoti, che nessuno potrebbe interpretare, di cui nessuno potrebbe servirsi.
La radicalità weberiana nel far proprio questo assunto è tale da non renderlo confinato a semplice presupposto del ragionamento. In ogni passaggio della metodologia weberiana si riverbera il problema della parzialità dello sguardo del ricercatore.
A partire da quello che forse è la nozione che ha avuto maggior fortuna nella sua produzione: l’idealtipo. Cos’è l’idealtipo?
Lasciamo la parola al nostro:
«Concetti come “individualismo”, “imperialismo”, “feudalesimo”, “mercantilismo”, ecc. sono “convenzionali”, [così come] le innumerevoli formazioni concettuali di tipo analogo, per mezzo delle quali cerchiamo di concepire e di comprendere la realtà[1]».
“Convenzionale”, precisiamolo, non significa qui arbitrario, ma determinato da quel “riferimento a valori” cui si faceva cenno prima. Cioè, propriamente, riferito a delle convenzioni, a quel retroterra che è base di partenza per ogni ricercatore.
Ora, cosa ci sta dicendo Weber? Ci sta dicendo che quando ci proponiamo di dare un senso a ciò che ci circonda, noi utilizziamo (prendendoli in prestito o coniandoli ex novo) dei concetti in grado di costituire una mappa dell’esistente. Questa mappa è la teoria. Teoria storica, teoria sociologica o psicologica. (Persino teoria fisica o chimica, ma non allarghiamo il campo e soprattutto evitiamo di far dire a Weber cose che non ha mai detto…).
Ma così come una mappa non è ciò che descrive, la teoria non è la realtà. Così come la mappa, con le sue macchie di colore sulla carta, le sue righe, i suoi segni convenzionali, serve a noi per capire quale strada prendere, la teoria ci serve orientarci. È un modello, né più né meno.
Modello che non esaurirà mai l’intera realtà, ma che permette di “illuminarne” certi aspetti e non altri, a seconda di quello che ci interessa.
Come tentare di conciliare questa sorta di ipersoggettivismo con l’esigenza di produrre un sapere oggettivo lo vedremo nei prossimi articoli. Per il momento torniamo al problema della comprensione razionale dell’uomo.
Quest’espressione, “comprensione razionale dell’uomo”, è ambigua. Può indicare la necessità di fondare un sapere razionale sull’essere umano, ma può anche voler dire che bisogna comprendere la razionalità dell’uomo.
In Weber le due interpretazioni vanno sempre di pari passo. Egli è convinto da un lato che un sapere che non sia razionale sia semplicemente l’assunzione di una serie di dogmi non dimostrabili (cioè sia fede e non scienza), e dall’altro che l’unico modo per poter comprendere scientificamente l’essere umano sia individuare la razionalità delle sue azioni.
Anche Weber però era perferttamente consapevole che gli individui non agiscono sempre in maniera razionale. Si profila perciò l’esigenza, per il nostro, di definire cosa intendere per “razionalità delle azioni” dell’uomo. Anche la razionalità è un “idealtipo”, parte della mappa che dobbiamo costruire.
In un certo senso si può dire che Weber operi una risemantizzazione di questo concetto, tenendo separate due forme di razionalità: la razionalità secondo il fine (Zweckrationalität) e secondo il valore (Wertrationalität). La distinzione è importante.
Mentre la Wertrationalität è la categoria che serve per rispondere alla domanda «è razionale l’obiettivo che Tizio si è proposto?», la Zweckrationalität si interroga più specificamente sui mezzi di cui l’agente è dotato per raggiungere il proprio obiettivo. E se un giudizio sulla Wertrationalität rimane comunque legittimo, la scienza dell’uomo non può che limitarsi a ragionare sulla Zweckrationalität, pena confondere dei giudizi di valore con i giudizi conoscitivi.
Facciamo un esempio. Supponiamo di dover giudicare il nazismo. Tranne i nazisti, tutti concordano nel ritenere il fine di sterminare gli ebrei, i popoli romaní, gli omosessuali, le minoranze e gli oppositori politici un fine aberrante e da rifiutare. Sul piano della Wertrationalität i nazisti hanno agito in maniera assolutamente irrazionale. È possibile, anzi necessario, dare un giudizio di valore e dire che i nazisti sono wertirrational.
Purtroppo però i mezzi che hanno adottato sono stati tragicamente razionali ed efficienti e non possiamo che concludere che i nazisti hanno agito in maniera estremamente zweckrational. Questo è un giudizio conoscitivo perché implica un’indagine storica di questi mezzi: il complesso concentrazionario dei lager, il sistema di trasporto, le camere a gas, i forni crematori, persino l’organizzazione sociale interna ed esterna ai campi.
Con questa distinzione, la razionalità smette di essere una caratteristica delle sole leggi universali, come pretendevano i positivisti. Anche la comprensione può a buon diritto esser detta “razionale” e così fondare una scienza. Una scienza che certo non guarda alla fisica come modello, ma che è capace di autogiustificare le proprie pretese conoscitive. Una scienza particolare in grado di produrre un sapere universale. Era nata così la sociologia.