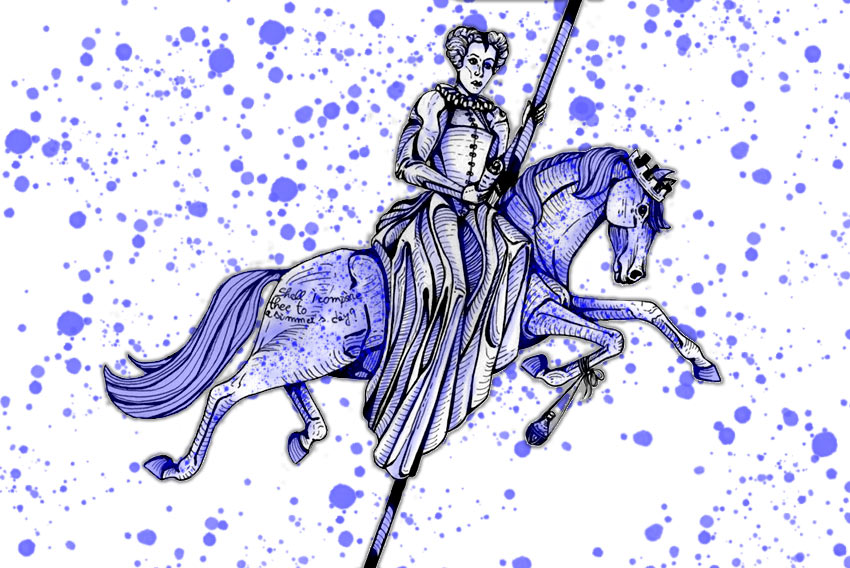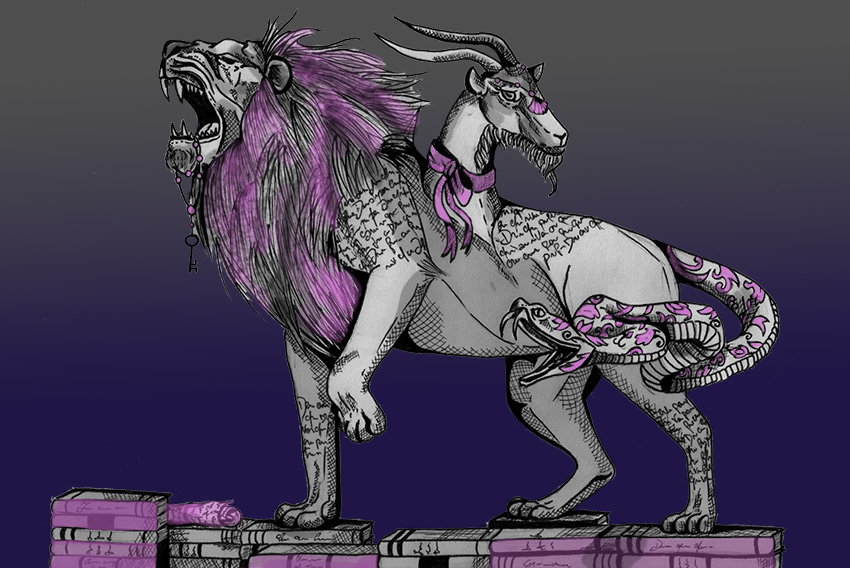La prima opera storica del mondo occidentale, si sa, sono le Ἱστορίαι (Historiai) di Erodoto. Già il nome è una dichiarazione programmatica: ἱστορίαι in greco significa “ricerche” e quella di Erodoto è in effetti l’esposizione sistematica delle sue ricerche.
Il nome, traslato in latino, ha nel tempo mutato significato. La “storia” è diventata l’insieme dei fatti del passato, ma “storia” è anche la crociana “storiografia” e più in generale il racconto in quanto tale.
Di più. Il significato è talmente cambiato che con “storia” si può intendere persino una bugia, una menzogna oppure – e i confini semantici qui si fanno particolarmente incerti – un’invenzione. «Non raccontarmi storie!», «Sì, come no! Questa è una storia bella e buona!», «Papà, mi racconti una storia?»… gli esempi si possono moltiplicare.
L’interrogativo sorge spontaneamente: com’è possibile che una stessa parola indichi il racconto sui generis, il racconto del vero e il racconto del falso? Che sia l’unione dei contrari e di qualcosa che si situa altrove rispetto ai due opposti?
Per rispondere proviamo a farci un’altra domanda, che apparentemente non c’entra nulla con quanto detto finora, ma che forse può invece indirizzarci sulla via della risposta: può l’arte avere una funzione politica?
La risposta, secondo me, non può che essere contraddittoria: sì e no.
L’arte ha una funzione politica perché inerisce a noi, al nostro vissuto, al modo in cui viviamo i rapporti con gli altri. Media il mondo attraverso l’immaginazione e la creatività (attraverso il fantastico) e il risultato di quest’esperienza ci muove a una riconfigurazione del nostro vissuto, un nuovo sguardo, più maturo, consapevole.
L’arte però non è propaganda, ed è pericoloso se lo diventa. Irregimentata in forme vuote, sempre uguali a loro stesse, piegata ad uno scopo immediatamente didattico, perde la sua capacità mediatoria e perde così il suo senso.
L’arte è quindi impolitica e politica al tempo stesso. Racconta il vero e il falso: più in generale, racconta. E torniamo così alla storia e alle storie: all’unione dei contrari e di qualcosa che non è né l’uno né l’altro.
Nel 1969 Dario Fo e Franca Rame scrivevano Mistero buffo. Un’opera teatrale composta di più parti, sconnesse tra loro, intercambiabili, sostituibili, ma tutte con uno stesso filo rosso: la vita di Gesù Cristo secondo la “tradizione” dei vangeli apocrifi (ché se son apocrifi di tradizione non si può parlare) e nella cultura popolare. È una grandiosa opera di riappropriazione ed elevazione di un patrimonio che altrimenti sarebbe andato disperso, oltre a offrire allo spettatore l’occasione per passare due, tre ore di gustosissime risate.
Dall’8 al 20 ottobre, in occasione del cinquantesimo anniversario della prima messinscena, Mario Pirovano lo ha rappresentato al Piccolo Teatro Grassi. È sempre difficile confrontarsi con un’opera così “personale” (nel senso che è tagliata su misura dell’attore), tuttavia il risultato è eccelso. Non solo per le indubbie capacità attoriali di Pirovano, ma soprattutto per lo spessore del testo e per la sua capacità plastica di farsi impolitico e politico al tempo stesso, di essere appunto arte.
L’opera è composta da vari episodi: “Il primo miracolo di Gesù bambino” – in cui un settenne Gesù Cristo trasforma un bambino prepotente, il figlio del padrone della città, in una statua di terracotta –, “La fame di Zanni” – che narra dal punto di vista di un contadino la tragica carestia del XV secolo nei territori continentali della Serenissima –, “Bonifacio VIII” – in cui il papa simoniaco viene preso a pedate da Gesù Cristo sceso in terra –, e così via. Tutti narrati rigorosamente in grammelot.
Ogni episodio è preceduto da un preambolo, un prologo che aiuta lo spettatore a contestualizzare ciò che verrà di lì a poco narrato. E se il grammelot permette di esondare dagli argini del linguaggio “normale” (nel senso di “regolato dalla norma, dalla regola”), creando così un senso comprensibile da tutti (nessuno parla il grammelot ma tutti lo capiscono), l’opera di contestualizzazione traduce il passato nella lingua del presente, lo cala in una data contingenza.
Il buon esito dello spettacolo è frutto di questa doppia tensione: universalistica da un lato e dall’altro particolaristica. Il buon esito dello spettacolo, ma anche l’esito politico dello spettacolo, e più in generale dell’opera d’arte, la quale è radicata nel contesto specifico in cui sorge, riflette tale contesto (da re-flecto: mi piego indietro, prendo le distanze e nel fare questo me ne approprio) ma trascende il momento in cui questa viene composta e riesce a parlare a un pubblico anche a distanza di millenni.
Nel caso di Mistero buffo poi l’universalità non è garantita solo dal grammelot, che però ne è un elemento simbolico importante. È soprattutto la scelta di raccontare la storia attraverso delle storie (perdonate il calembour), la scelta di volgersi al passato per comprendere il presente.
Dal già citato Bonifacio con il suo uso propagandistico della religione alla rivalsa che il piccolo figlio di Dio si prende su chi impara fin dalla culla il linguaggio del sopruso proprio delle classi dominanti, alla violenza che il padrone – ogni padrone! – esercita sui suoi subalterni raccontata nella storia del contadino diventato giullare, ogni episodio in realtà dice qualcosa sul mondo in cui viviamo e lo fa con il riso dolceamaro di chi narra giullarescamente la tragedia.
Prima di concludere, due parole sull’ultima che abbiamo citato, sulla nascita del giullare[1]. Messa in scena da Pirovano, in realtà non si trova in quasi nessun’altra rappresentazione di Mistero buffo. Al centro del racconto infatti c’è lo stupro che il padrone compie ai danni della moglie del contadino protagonista. Stupro di cui sarà vittima Franca Rame nel 1973, quando alcuni fascisti decisero di punirla per la sua militanza nelle file del movimento antagonista degli anni ‘60 e ‘70.
La violenza sessuale è al centro dell’episodio, ma senza il corollario retorico e fastidioso che di solito accompagna i racconti di questi fatti tragici, né, tanto meno, con una volontà pruriginosa.
No, piuttosto ne è il centro perché è il perno di una trama che si risolve prima con la distruzione dei legami affettivi (la moglie sconvolta dallo shock fugge nel bosco e i figli della coppia, che avevano assistito al fatto si lasciano morire d’inedia), poi il tentativo di suicidio da parte del contadino e infine con l’arrivo di Gesù che dà in dono all’uomo la “giullarità”, la capacità, come detto prima, di raccontar tragedie con il sorriso, producendo così una catarsi ma anche risvegliando la consapevolezza in chi ascolta che i responsabili per i mali del mondo hanno nome e cognome e si possono affrontare e sconfiggere.
E così il cerchio si chiude. La ricerca sul passato, il racconto della storia, in vista del futuro (un “futuro ottativo”, pregno di possibilità), media la comprensione del presente.
L’opera d’arte si fa propriamente opera politica. Non propaganda, non frase ad effetto usa e getta, ma conoscenza del mondo e sua trasformazione.