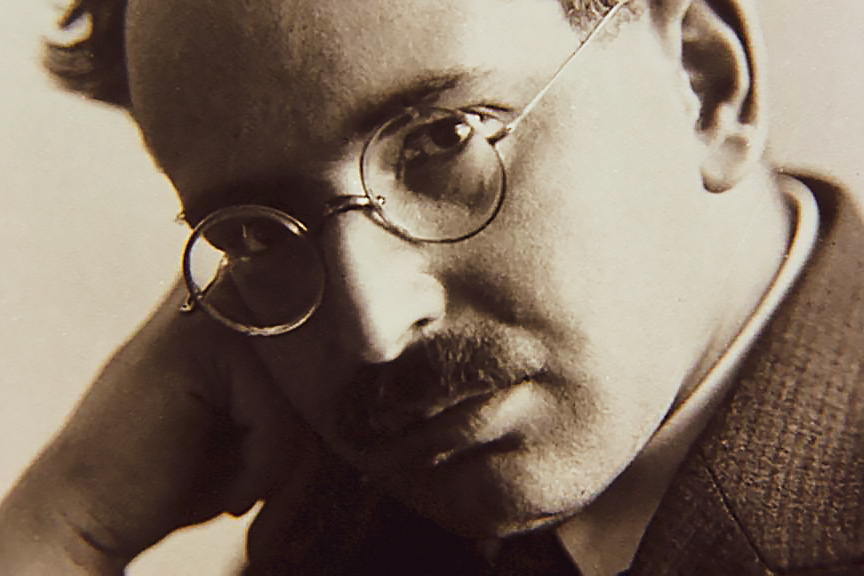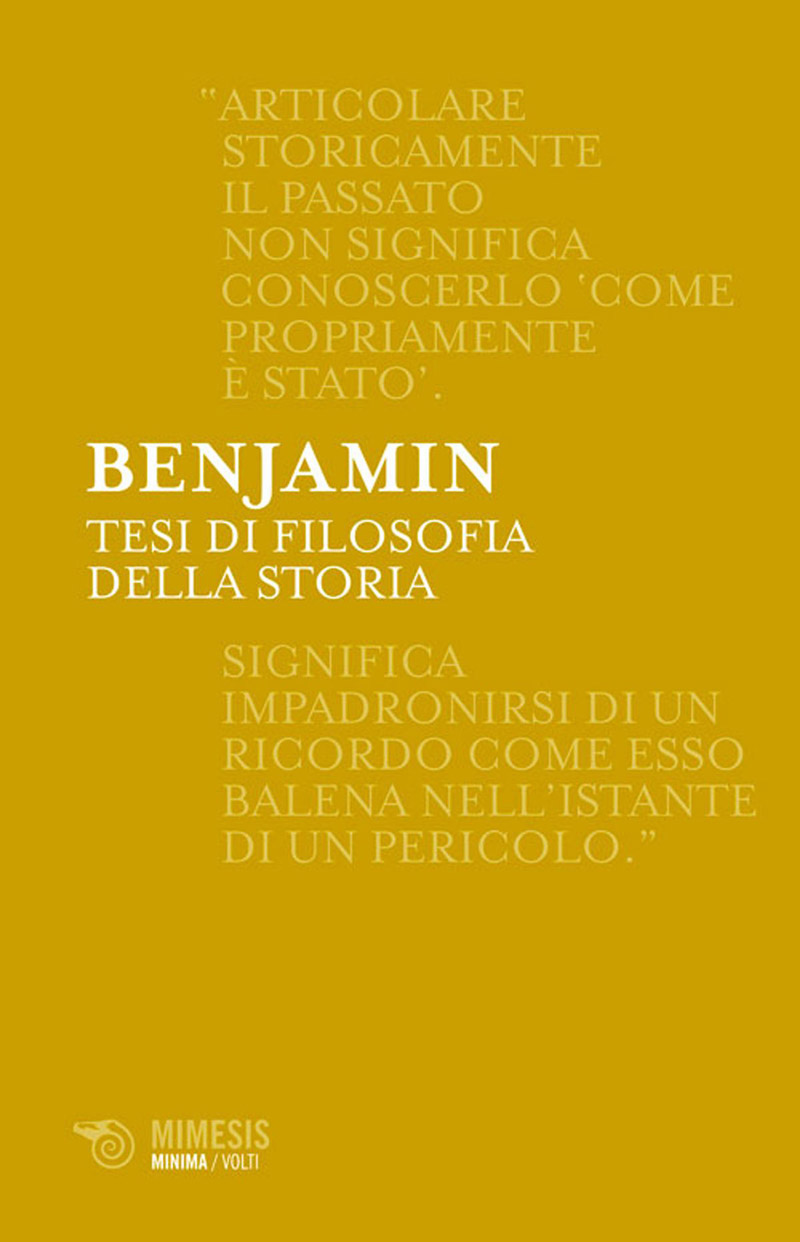La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è costruito dal tempo omogeneo e vuoto, ma da quello riempito dell’adesso[1].
Così scriveva Walter Benjamin nelle note oggi raccolte sotto il titolo Sul concetto di storia, e conosciute anche come Tesi sulla filosofia della storia.
Siamo alla fine degli anni Trenta. Il nazismo ha vinto in Germania da alcuni anni e si prepara alla guerra. La patria della filosofia classica tedesca, la patria di Goethe e di Hölderlin, nonché del movimento operaio, e di Karl Marx, si è consegnata al partito dei sedicenti Übermenschen, e allo sterminio di tutti coloro che non appartengono alla razza superiore, la razza ariana.
A un progetto politico così aberrante nessuno seppe opporre alcun tipo di argine: non lo fecero gli operai, non lo fecero i contadini delle campagne e gli artigiani delle borgate; né tantomeno lo fecero gli industriali, i piccoli e grandi imprenditori della Germania di allora. Nemmeno nel resto d’Europa vi era speranza: in Italia il fascismo governava da quasi vent’anni, e in Spagna il generale Francisco Franco si appresta a trionfare sulle forze repubblicane.
Chi aspirava a un mondo diverso, a idee di uguaglianza e giustizia, puntava gli occhi alla recente Unione Sovietica, dove però in quegli stessi anni si stava verificando una vera e propria controrivoluzione mascherata, in cui i dirigenti rivoluzionari venivano presi casa per casa, condannati e uccisi. Nemmeno l’ex comandante in capo dell’armata rossa, Lev Trotsky, si sarebbe salvato. Il potere di Stalin e la sua burocrazia si erano così impadroniti della rivoluzione d’ottobre, dei suoi ideali e dei suoi (già precari) successi. Come se non bastasse, di lì a poco avrebbero siglato un patto di non belligeranza proprio con il Terzo Reich, con quei nazisti che perseguitavano i militanti socialisti e comunisti in Germania. Con quei nazisti che rappresentavano tutto l’opposto di ciò che diceva di essere l’Urss.
È questo il mondo che appare quando Walter Benjamin scrive a Parigi le sue note, riflettendo sull’avanzamento inarrestabile di questa barbarie, di un mondo che sembra incanalato lungo binari predefiniti, inamovibile, la cui rotta sembra impossbile da modificare.
Benjamin, però, si rifiuta di accettare una realtà finalistica, in cui ogni aspetto della realtà è stabilito da un’arcana meccanica, da leggi che appaiono immutabili, su cui noi esseri umani non abbiamo alcuna presa. Benjamin sa che addossare tutte le responsabilità dello sviluppo storico a questa meccanica, per quanto si cerchi di renderla laica e scientifica, è un modo molto antico e problematico di porre il problema. Come il turco meccanico, quell’automa costruito a fine ottocento, che pareva uno scacchista perfetto ma in realtà nascondeva al suo interno un maestro di scacchi in carne ed ossa, così anche la concezione meccanicista della storia nasconde all’interno la teologia, l’idea di un Dio invisibile che muove le pedine del mondo. Dato che quell’idea è «piccola e brutta, e non ama farsi vedere in giro», come scrive, allora si deve travestire da materialismo storico, da scienza della storia.
Walter Benjamin procede per immagini, per metafore. Il suo stile è particolarissimo, denso: in poche righe concentra anni di riflessioni. Bisogna soffermarsi su questo per capire il suo stile. Le sue non sono tanto delle argomentazioni, quanto delle tesi, degli accenni che, però, nella loro brevità, riescono a mettere a fuoco i problemi, le questioni cruciali attorno al modo di intendere la storia e i suoi processi.
«Articolare storicamente il passato – scrive nella VI tesi – non significa riconoscerlo “come è stato veramente”. Significa impadronirsi del ricordo che lampeggia nell’attimo del pericolo[2]». La ricostruzione storica, l’idea di creare un modello asettico della realtà, tipica della storiografia pre-novecentesca, si sfarina sotto le sue parole. Al contrario, è la storia per l’uomo a interessare Benjamin: la storia come costruzione umana, che può essere usata, che l’uomo può impugnare per far luce sul suo presente, sull’oggi. Su quel presente che appare così inquietante e incomprensibile.
Il paradosso fu che proprio i socialdemocratici e i comunisti aderirono a un’idea finalistica della storia, convinti che questa avrebbe lavorato per loro, al loro fianco. Che la spirale del progresso avrebbe investito tutte le classi, e quindi il mondo non poteva che andare in una direzione: la società socialista.
La teoria socialdemocratica, e ancor più la prassi, fu determinata da un concetto di progresso che non si atteneva alla realtà, ma aveva una pretesa dogmatica. Il progresso, come si rappresentava nelle teste dei socialdemocratici, era, in primo luogo, un progresso dell’umanità stessa (e non solo delle sue abilità e conoscenze). Era, in secondo luogo, un progresso interminabile (in corrispondenza a una perfettibilità infinita dell’umanità). Esso valeva, in terzo luogo, come un progresso essenzialmente inarrestabile (come quello che descrive spontaneamente un percorso diritto o a spirale). […] L’idea di un progresso del genere umano nella storia è inseparabile dall’idea che la storia proceda percorrendo un tempo omogeneo e vuoto[3].
Il tempo «vuoto e omogeneo», il tempo di Newton, dei positivisti, è un tempo asettico, extra-umano, metafisico. L’uomo dov’è, nel tempo vuoto e omogeneo? Dove sono i suoi sentimenti, le sue necessità, la sua fame? Come può l’uomo impugnarlo e farne uno strumento?
La storia, come diceva già Marx, non fa nulla da sola: sono gli uomini a fare la storia. Uomini che agiscono, si relazionano tra di loro e con il mondo circostante, uomini che vivono, lottano, lavorano. Uomini che con i loro bisogni, con la loro fame, la loro sete, le loro necessità corporee costruiscono mondi in grado di soddisfarle.
Non solo. Il mutamento è il metronomo del tempo e quindi della storia. Il tempo è lo «Spazio dello sviluppo umano[4]». Può rallentare, accelerare, scartare imporvvisamente, o apparentemente arretrare. Il tempo conosce cioè i mutamenti qualitativi propri della società che lo misura. In questo senso il tempo non è liscio, non è omogeneo. I greci avevano tre modi per chiamare il tempo. Il primo era il krònos, per indicare il tempo uguale a se stesso che scorre in avanti, mentre il secondo era l’aiòn, il tempo ciclico delle stagioni, delle ere, che torna sempre uguale a se stesso. Ma poi vi era un terzo modo di chiamare il tempo: il kairòs, il tempo opportuno, il tempo che va colto. Questo tempo che si misura per la sua qualità, e non per la sua quantità, è il tempo di cui parla Benjamin.
Non è la società a mutare perché immersa nel tempo: è il tempo che diviene misura dei cambiamenti della società. È un tempo qualitativo, pregno della prassi sociale, della lotta sociale. L’equazione «tempo = mutamento della società» diventa così «storia = lotta di classe». È questa possibilità dell’uomo di prendere, in ogni momento, le redini della propria storia a far sì che Benjamin possa parlare di rivoluzione in un momento in cui non sembrerebbe razionale nemmeno accennarvi. La capacità di «spazzolare la Storia contropelo[5]» diventa così una virtù fondamentale.
Invece, alla «imprudenza creatrice[6]» della rivoluzione, i partiti operai hanno sostituito la quieta attesa per il futuro e hanno preparato così la propria sconfitta. «Il conformismo – scrive –, che fin dall’inizio è stato di casa nella socialdemocrazia, non è connesso solo con la sua tattica politica, ma anche con le sue idee economiche. Esso è una causa del suo successivo crollo. Non c’è nulla che abbia corrotto i lavoratori tedeschi quanto la persuasione di nuotare con la corrente[7]».
Per uscire dalla crisi l’unica possibilità è reinventare una teoria dell’atto rivoluzionario. Un atto, che al tempo stesso processo, in grado di aprire a un ventaglio di possibilità, di far irrompere il futuro nel presente. Un atto processuale e un processo evenemenziale che Benjamin condensa nella figura ebraica del Messia.
È noto che agli ebrei era vietato investigare il futuro. La Torah e la preghiera li istruiscono invece sulla rammemorazione. Ciò liberava per loro dall’incantesimo il futuro, quel futuro di cui sono succubi quanti cercano responsi presso gli indovini. Ma non perciò il futuro diventò per gli ebrei un tempo omogeneo e vuoto. Poiché in esso ogni secondo era «la piccola porta attraverso la quale poteva entrare il messia[8]».
Infatti la rivoluzione (ma ogni mutamento sociale, si può dire) non arriva mai “nel momento giusto”, nel momento in cui tutte le concatenazioni arrivano alla giusta maturazione, e si collegano magicamente tra loro. Una rivoluzione non è la piatta conseguenza di uno sviluppo predeterminato: è uno strappo, è un atto di forza, qualcosa che nessuno si aspettava prima. Uno spalancare la porta e irrompere sul proscenio. Così si sconvolgono gli equilibri sedimentati dal tempo, e si rende possibile ciò che prima non era nemmeno pensabile.
La lotta di classe, che sta sempre davanti agli occhi dello storico formatosi su Marx, è lotta per cose rozze e materiali, senza delle quali non esistono quelle fini e spirituali. Ciononostante queste ultime partecipano alla lotta di classe diversamente dall’immagine di bottino destinato al vincitore. Vivono nella lotta come fiducia, coraggio, umorismo, astuzia, continutià e nell’arco del tempo agiscono retroattivamente. Esse rimetteranno sempre in questione ogni vittoia già toccata in sorte ai dominatori. Come i fiori rivolgono il loro capo al sole, così in forza di un eliotropismo segreto tutto ciò che è stato si rivolge al sole che sta salendo nel cielo della storia[9].