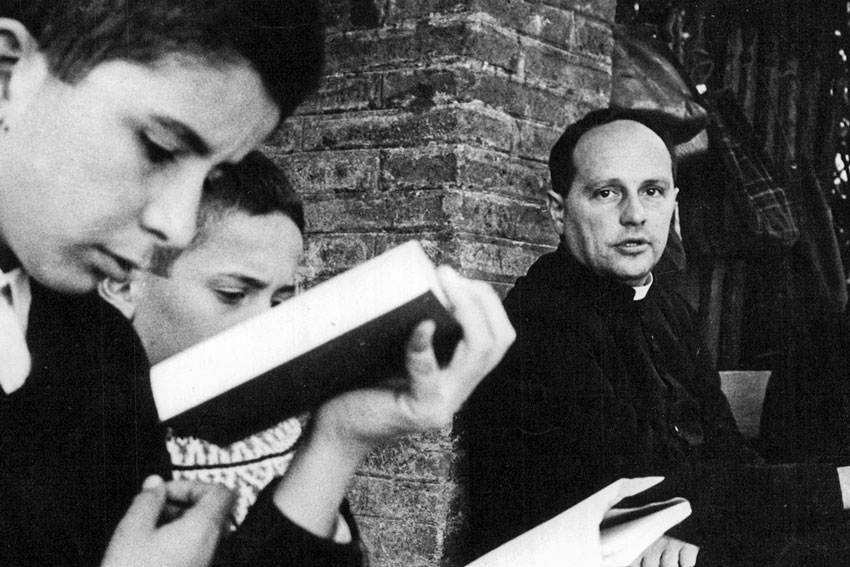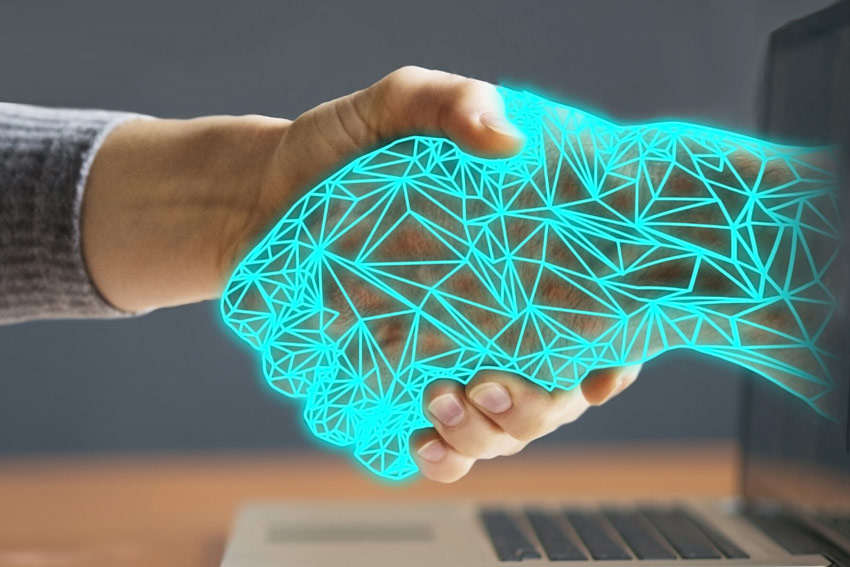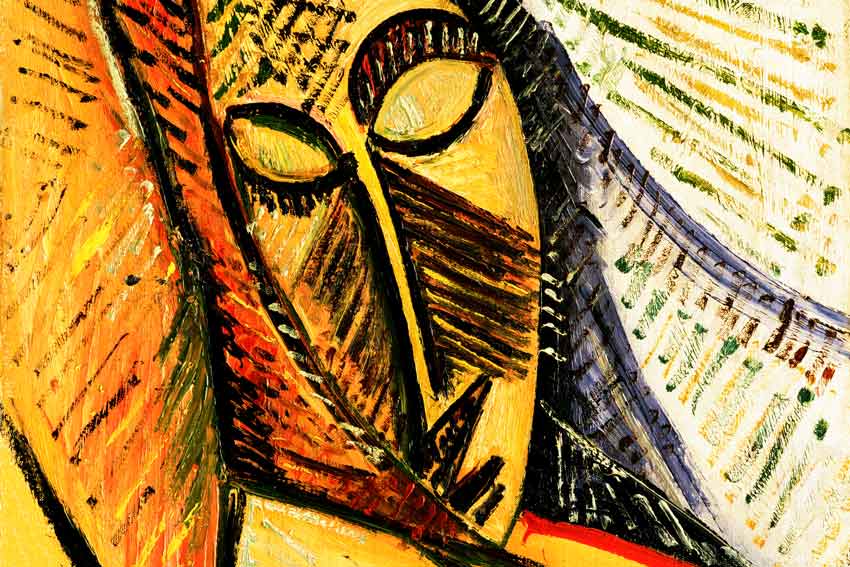Sul fascismo – I
Le crisi non capitano per caso né sono dei momenti in cui la società prende una sbandata imprevista. Le crisi sono il momento in cui i nodi vengono al pettine, in cui le contraddizioni sociali esplodono in forma violenta, in cui «il vecchio muore e il nuovo non può nascere[1]».
Noi viviamo in un periodo di crisi. Non crisi economica, non crisi politica, non crisi culturale: crisi «organica», che contiene tutte queste crisi e le combina in modalità distruttive inedite e imprevedibili. Viviamo in un «interregno, [nel quale] si verificano i fenomeni morbosi più svariati[2]».
Tra questi la riemersione (ah perché? se ne erano mai andati?) di spettri putrescenti e stomachevoli, che sembravano consegnati una volta per tutte all’immondezzaio della storia. I vecchi simboli vengono riesumati, i vecchi nomi presi come numi tutelari, le vecchie parole d’ordine issate come bandiere di un progresso tale solo nominalmente. L’umanità procede in realtà con il volto ritorto verso le reni, come novelli indovini danteschi.
La crisi, dicevamo, non capita mai per caso. Parafrasando Gaber, «la disponibilità a cambiare ogni giorno, la necessità di una morale diversa, la credenza di poter essere vivo e felice solo se lo [sono] anche gli altri» ha ceduto progressivamente il passo al vivere quotidiano, al быт di cui parla Majakovskij nella sua ultima lettera.
La crisi è anche incapacità di pensare una radicale alternativa all’esistente. Con la fine di questo sogno, di questa spinta, resta il cliché, lo squallore della mera sopravvivenza. Tutto è ovvio, immediato, banale, scontato. Nessuna «fatica del concetto». Anzi, nessun concetto, nessuna fatica. Altro che la mussoliniana «superba passione della migliore gioventù italiana»: la morte del concetto è conformismo e il conformismo la uccide, la passione.

Il riferimento a Mussolini non è casuale. Se c’è un termine che, preso in senso ampio e non storicistico, riassume tutto questo è proprio il fascismo. Il fascismo non è solo quello della marcia su Roma o delle parate a braccio teso. La storia – con buona pace di Hegel – non si ripete due volte.
Il fascismo è la scelta di uscire dalla crisi del modo di produzione capitalistico in senso regressivo. È la spinta al cambiamento che viene assorbita e resa inoffensiva per i rapporti sociali esistenti. È questo che si è ripetuto non due, ma più volte nel corso del Novecento. Ed è quello che si sta ripetendo oggi.
Viviamo quindi in una società fascista? No, non nel senso che diamo quando parliamo del Ventennio o della Germania degli anni ‘30. Viviamo in una società che non riesce ad uscire dalle contraddizioni in cui si è invischiata e che, proprio per questo, le riproduce in forme sempre più brutali.
La brutalità dell’indifferenza innanzitutto, che è anche l’accettazione della brutalità come ineluttabile. Non è un gioco di parole. La società in cui viviamo è una società radicalmente violenta. Fondata sulla diseguaglianza, sul dominio, la violenza che esprime non è (solo) quella del crimine “privato”. Per quello bene o male c’è il codice penale. La violenza che esprime è innanzitutto una violenza strutturale, che inerisce all’essenza dei rapporti tra gli esseri umani e dell’essere umano con il mondo.
È la distruzione dell’ambiente, l’esser costretti a fare un lavoro qualunque per vivere, l’esser costretti a migrare per sopravvivere… Accettare questa violenza come inevitabile, perché «il mondo è sempre andato così», è la scusa per non gettare nella spazzatura la bacinella di Pilato.

Il fascismo, espressione parossistica della violenza strutturale, non è la malattia di questa società, ne è il figlio sano. È una delle possibilità che questo mondo cova in seno. Eppure rimane uno spettro remoto, da evocare più come pericolo che come realtà effettuale: «Ma figurati, mica siamo in una società fascista!». Eppure…
Il fascismo non si presenta tutto insieme, non ci si sveglia una mattina costretti a camminare a passo di marcia. È frutto di cambiamenti molecolari, impercettibili. Ad un certo punto, la quantità muta in qualità e ci si accorge che abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, che l’indifferenza è diventata conformismo, che il conformismo è diventato crimine.
Mala tempora currunt sed peiora parantur: corrono tempi malvagi, e se ne preparano di peggiori. Uno dei sintomi più rilevanti è il diffuso disprezzo per la cultura. Lino Banfi all’Unesco, Bolsonaro che manda in pensione il Ministero per la cultura hanno lo stesso significato simbolico dei roghi di libri di nazionalsocialistica memoria. La proiezione, venerdì 8 febbraio, niente meno che su Rai 3 in prima serata di Red Land. Rosso Istria ha una funzione analoga al Triumph des Willens (senza però nemmeno la gloria di una Leni Riefestahl dietro la macchina da presa). La morte del concetto è, se possibile, assoluta…
Proprio oggi, in occasione del cosiddetto Giorno del Ricordo, il Presidente Sergio Mattarella ha parlato di «una paziente e coraggiosa opera di ricerca storiografica, non senza vani e inaccettabili tentativi di delegittimazione, ha fatto piena luce sulla tragedia delle foibe e del successivo esodo». Non possiamo sapere esattamente a quali opere si riferisca la massima autorità dello Stato, ma vorrei ricordare che tanta “ricerca storiografica” sulle Foibe si basa su invenzioni, esagerazioni, deformazioni ideologiche non degne di storici di questo nome, come ricostruito in più articoli dal gruppo di studio Nicoletta Bourbaki.

Evitiamo fraintendimenti. Tra il ‘43 e il ‘45 omicidi sommari, epurazioni, ritorsioni sono avvenuti. La brutalità della guerra – la letteratura post-resistenziale lo insegna – investe anche chi ha combattuto contro il nazifascismo. Ma un fenomeno storico va contestualizzato, e consegnato per quelle che sono le sue dimensioni e per i fatti che possono essere accertati. Non va usato come grimaldello per rimettere in circolazione idee passate e nocive, come purtroppo è avvenuto e sta avvenendo anche grazie a certa ricerca storiografica.
Le parole di Mattarella – se anche non sono in sé e per sé questo grimaldello – riflettono l’odierna situazione culturale, in cui lentamente si sedimenta nel senso comune una narrazione tendenziosa, in più punti storicamente falsa, e che invece viene presentata come oggettiva, come la verità dei fatti, tacciando come “ideologico” o perfino “negazionista” qualsiasi ridimensionamento, qualsiasi voce che tenti di raccontare una storia leggermente diversa.
Nessun rimpianto, ribadisco, per i tempi andati in cui gli intellettuali facevano gli intellettuali e il populace stava zitto ad ascoltare il Verbo. Ma la costruzione mitologica di un passato in cui rifugiarsi, lo stesso che ha prodotto i mostri che dobbiamo fronteggiare oggi, non apporterebbe alcun giovamento ma vorrebbe dire curare un male con la stessa medicina che l’ha provocato.
No, ad un’uscita regressiva dalla crisi bisogna aver la forza di contrapporre una nuova idea di mondo. O, meglio, bisogna avere la forza di contrapporre di nuovo l’idea di un mondo radicalmente diverso da quello esistente. Bisogna rincominciare a parlare di una società nella quale la violenza non sia la cifra caratteristica delle relazioni umane, nella quale ci si possa riappropriare collettivamente dei propri tempi e dei propri spazi.
L’intellettuale, non più schifato né rinchiuso in una torre d’avorio, deve farsi organico, pienamente partecipe del processo di trasformazione. Dev’essere parte di una volontà collettiva: «crearla, suscitarla, estenderla, rafforzarla, organizzarla[3]». La conclusione del detto allora muterebbe, quasi impercettibilmente nel suo contrario: mala tempora currunt sed meliora aedificamus.
Corrono tempi malvagi, ma ne costruiamo di migliori.
Leggi gli altri articoli del ciclo Sul Fascismo
Nota: Il giorno del Ricordo è istituito con la La legge del 2004, che reca come primo firmatario tal Roberto Menia, uomo organico all’MSI, braccio destro di Gianfranco Fini e nel 2015 promotore di una lista comunale a Trieste il cui programma era di «tornare a seminare italianità nell’Europa adriatica» (Il Piccolo)
Per capire meglio con che personaggio abbiamo a che fare, citiamo direttamente dall’articolo-inchiesta pubblicato nel 11-02-2016 sul sito “Giap”:Nell’agosto del 1991 una delegazione del MSI di cui fanno parte Gianfranco Fini, Roberto Menia e Mirko Tremaglia vola a Belgrado per incontrare alcuni esponenti di seconda fila del regime di Milošević e vari esponenti dell’estrema destra serba. La Slovenia ha da poco ottenuto l’indipendenza, e tra Serbia e Croazia è già guerra.
Oggetto dell’incontro è nientemeno che la spartizione della Croazia tra Italia e Serbia. Pare che l’Italia stia prendendo in seria considerazione la possibilità di intervenire militarmente in Istria, a tutela degli interessi nazionali nel campo della pesca e a difesa della minoranza italiana che vive nella regione. […] Fini e Menia sono quelli con cui Violante e Fassino nella seconda metà degli anni Novanta patteggeranno la costruzione della cosiddetta “memoria condivisa”, patteggiamento suggellato poi dall’istituzione del “Giorno del Ricordo” (Giap).
Sull’uso fuorviante dell’aggettivo “negazionista”, applicato all’esodo dalmato-giuliano e alle foibe: Wu Ming, Gli incontrollati fantasi su Norma Cossetto (Giap)