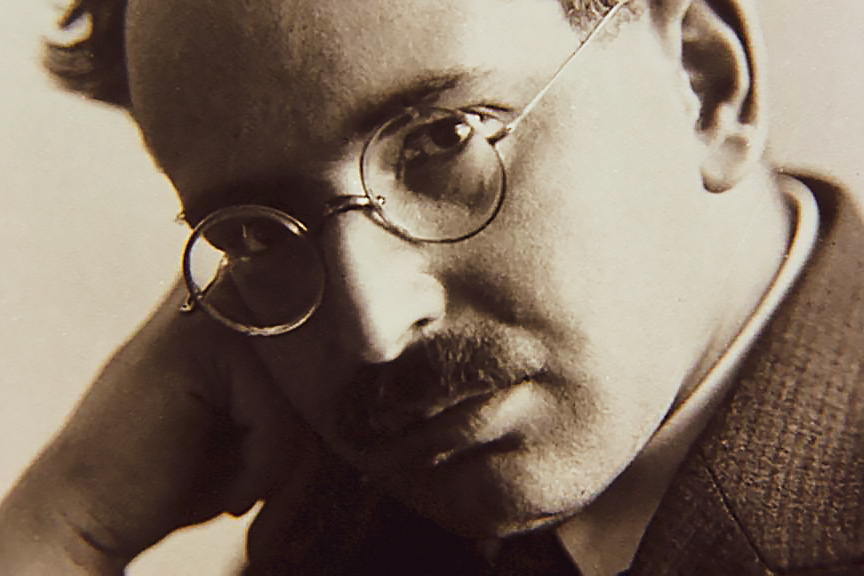Responsabilità, libertà, volontà. Attorno a questi tre concetti si sviluppa, in epoca moderna, ma non solo, la riflessione sulla pena.
Tracciare una storia di quest’ultima, dunque, sembra implicare una storia del dibattito che ha visto confrontarsi in merito diverse scuole di pensiero.
Non ci sarebbe qui però nemmeno lo spazio per affrontare analiticamente un argomento di tale vastità. Ci limiteremo quindi a prendere brevemente in considerazione le posizioni espresse dalle due principali correnti che si sono confrontate tra il Seicento e il Settecento: il determinismo e la teoria del libero arbitrio.
È con Hobbes, e in particolare con il suo Libertà e necessità, che si ha una prima compiuta definizione del determinismo moderno. In questo testo l’autore si confronta con Bramhall, vescovo di Londonderry, che aveva sferrato un attacco, articolato su più fronti, contro le posizioni del filosofo inglese.
È evidente, infatti, che dove c’è necessità dell’azione, non può esserci libertà e dunque volontarietà.
Le leggi sarebbero ingiuste, le «ammonizioni» e le «consultazioni» vane, così come ogni giudizio morale e ogni punizione e ricompensa.
Insomma, sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista giuridico, la posizione deterministica condurrebbe necessariamente a un’aporia irrisolvibile: non ci permette di punire o premiare, biasimare o lodare.
Non solo, questo avrebbe delle conseguenze pericolose sul piano sociale, rompendo quel nesso azione-punizione (o premio) che vincola le persone al rispetto delle norme morali e giuridiche. Sbagli? Fai un’azione immorale? Se tutto è determinato, puoi sempre giustificarti dicendo che non dipendeva da te.
Questa teoria deve perciò essere rifiutata. L’unica posizione legittima è quella che presuppone una volontà assolutamente libera del soggetto agente, condizione di possibilità dell’imputazione morale e giuridica.
Ma, dicevamo in incipit, Libertà e necessità è la pietra di fondazione del determinismo filosofico moderno. Qui Hobbes raccoglie le critiche mossegli da Bramhall e articola un’ampia risposta.

La necessità non ha gli inconvenienti che le vengono imputati. Non si tratta infatti di sostenere una posizione fatalista, secondo cui «se l’effetto deve necessariamente accadere allora accadrà a prescindere dalle sue cause[1]». Tutt’altro!
Si tratta piuttosto di riconoscere l’esistenza di rapporti causali nel mondo, all’interno dei quali la deliberazione dell’agente rientra come uno dei momenti del processo.
In altre parole, poiché ogni effetto ha una causa, ogni azione, in quanto effetto, avrà una serie di cause, più o meno prossime, che la determinano.
E le prescrizioni morali, i consigli, le minacce e in generale ogni elemento che possa concorrere come causa nel determinare la scelta dell’agente sarà da reputare come essenziale per giudicare l’agente stesso e l’azione.
Tra questi elementi vi è chiaramente anche la volontà: momento finale del processo deliberativo.
È quando diamo volontariamente l’assenso ad una certa azione, che diventiamo “imputabili”.
Anzi, come dirà Hume circa un secolo più tardi, è proprio la possibilità di individuare un nesso causale tra i vari elementi del processo deliberativo (compresa la volontà) a darci anche la possibilità di imputare l’azione all’agente, che altrimenti sarebbe come sospesa nel limbo della casualità, e «tutti ammettono che [il caso] non esiste[2]».
Torniamo così all’opposizione posta da Bramhall e da cui abbiamo preso le mosse: o libertà della volontà o necessità dell’azione, non si può ammettere la compresenza di entrambi.
Ragionamento sbagliato, gli obietta Hobbes.
Intanto, libertà e volontà sono entrambe un potere (il potere «di agire o di non agire a seconda di come scegliamo o vogliamo[3]» e il potere che lo spirito ha di dominare una parte dell’uomo, «impegnando quella parte in un’azione particolare o trattenendola da essa[4]».
In secondo luogo, come abbiamo visto prima, la necessità non si identifica con il fato ma con la catena causale.
In terzo luogo, infine, possiamo ammettere una nozione di libertà, nei termini di assenza di costrizioni, senza per questo essere obbligati a rinunciare alla nozione di necessità, che viceversa è utile (se non addirittura indispensabile!) proprio nella valutazione morale o giuridica dell’azione.
Ma le divisioni tra i sostenitori del determinismo e i loro critici non si limitano alla libertà intesa in senso metafisico o meno. A venir coinvolta è anche la teoria della pena, su cui ora appunteremo la nostra attenzione.
Il forte apparato metafisico di cui si fanno portatori i sostenitori del libero arbitrio, permette loro di concepire la pena, e la punizione in generale, in due sensi complementari.
Da una parte, la punizione garantisce il ristabilirsi dell’armonia rotta (non staremo qui ad evidenziare le forti influenze cristiane e platoniche di tale concezione). Dall’altra, ogni azione viene inscritta in una sorta di “libro mastro” individuale, che permette, alla bisogna, di rendicontare (imputare ha esattamente questa radice etimologica: in + puto, “calcolare in, verso, contro”) i meriti e i demeriti.
Una teoria che guarda al passato, all’azione sbagliata del delinquente: come ancora dirà Kant nella Metafisica dei costumi: «se egli ha ucciso deve morire».
In tutt’altra direzione vanno i difensori del determinismo. «Lo scopo istitutivo della legge – ci dice Hobbes – non è quello di affliggere il delinquente per ciò che è passato e non può essere cancellato, bensì di rendere giusti lui e gli altri, che altrimenti non lo sarebbero, e riguarda non l’atto malvagio passato ma il buono futuro[5]». Passo significativo questo almeno per due ragioni.
Innanzitutto per l’idea di pena che viene delineata. La funzione della punizione infatti non è di ristabilire un’armonia, mediante una “ricompensa” equivalente all’atto criminale. Non un astratto «se egli ha ucciso deve morire» quello di Hobbes. Ma una pretesa educativa che la legge assume su di sé, nel momento in cui viene promulgata.
Non si guarda al passato quando si condanna un criminale, ma si guarda al futuro, alle conseguenze sociali che una condanna può avere, non tanto o solo per il singolo condannato, ma per l’intero gruppo sociale che trae una “lezione” dalla condanna del reo.
In secondo luogo per le implicazioni metafisiche: la legge ha una funzione educativa se concorre a determinare la scelta futura del singolo.
Il che significa, come già dicevamo, che a orientare la scelta dell’individuo concorrono una molteplicità di cause; che la volontà non è assolutamente pura, priva di ogni legame con la determinazione naturale.
Sembrerebbe che queste argomentazioni pongano la parola “fine” ad una diatriba che affonda le proprie radici addirittura nell’antica Grecia. La storia della filosofia però ci insegna che le cose non sono mai così semplici.
Nel prossimo articolo vedremo l’affascinante risposta che viene data da Hegel al problema della pena e della libertà del soggetto.