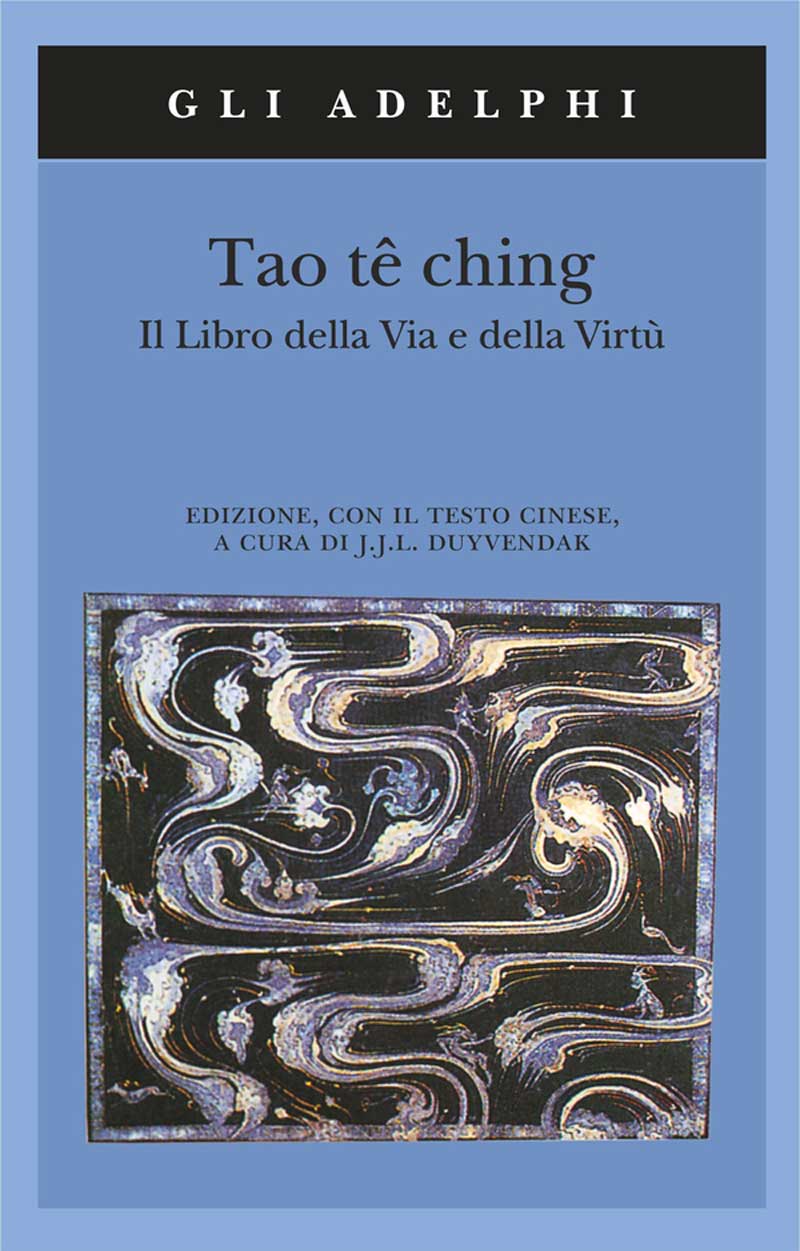Abbiamo sentito parlare tutti del Tao: tutti conosciamo il suo simbolo bipartito, con un punto di bianco nel nero un punto di nero nel bianco. In certi anni il taoismo era quasi una moda, e attirava curiosi e appassionati. Cosa sia però questo Tao ci sfugge abbastanza. Bene e Male? Giorno e Notte? L’attrazione fatale degli opposti?
Per addentrarsi in questo Tao bisogna scomodare un vecchio saggio, la cui esistenza si perde nelle nebbie della Storia e della leggenda: il misterioso Lao Tzu[1] . Sfuggente come Omero, opaco come il più eretico degli ermetici, oscuro quanto Eraclito, è l’autore del maggiore libro sacro taoista, il Tao Tê Ching (o Daodejing, nel sistema di traslitterazione pinyin). Un giro in libreria a sfogliare le varie edizioni di questo libro è vivamente consigliato. Non troverete un’edizione uguale all’altra, due traduzioni che si equivalgano.
Delle tante, due in particolare mostrano approcci molto diversi, se non diametralmente opposti: la prima è la versione italiana di La Voie Rationelle, traduzione dell’opera di Lao Tsu ad opera di Matgioi, un ufficiale francese della legione straniera che visse a cavallo tra Ottocento e Novecento, e che ricoprì vari incarichi nel Tonchino, l’attuale Vietnam del Nord. Fu l’incontro con il capo di un villaggio ad accendere in lui la passione per il taoismo: si convertì, cambiò il suo nome (Albert-Eugène Puyou de Pouvourville) in Matgioi, e si dedicò alla divulgazione del Taoismo in Francia. La sua traduzione prende le mosse dal testo classico del Tao Tê Ching, quello che per secoli è stato letto e commentato in Cina. Il secondo libro su cui posare il nostro sguardo è invece un’edizione Adelphi, che traspone in italiano la versione del filologo olandese J.J.L. Duyvendak, cioè il primo approccio scientifico e “occidentale” al testo.

Ma entriamo nel vivo del discorso:
La via, che è una via, non è la Via. Il nome, che ha un nome, non è un Nome. Senza nome, è l’origine del cielo e della terra; con un nome, è la madre dei Diecimila esseri. Con la facoltà del non sentire, si è vicini a concepirlo; con la facoltà del sentire, si raggiunge la sua forma. Ciò costituisce veramente due cose. Apparendo insieme, il loro nome è facile; a spiegarli insieme, la loro origine è oscura; oscura, questa origine continuamente si oscura. È la Porta dalla quale passa l’innumerabilità degli esseri.
(Matgioi, La via taoista, Melita, 1989, La Spezia p.40)
E capiamo che non si capisce niente.
Andiamo con ordine. Quello che abbiamo appena letto è l’incipit di un testo di cui si conosce pochissimo. Si sa che è stato scritto, tra il VI e il III secolo a.C. Il che, ovviamente, è tutto fuorché una datazione precisa: è come dire che Romeo e Giulietta è stato scritto tra il Quattrocento e il Settecento. Sì, certamente, ma sono successe un po’ di cose in mezzo, insomma.
Non solo: anche l’ordine dei capitoli non è sicurissimo. Anzi, diciamo che non è sicuro per niente. Infatti ogni capitolo era scritto su delle tavolette di legno, che venivano legate le une alle altre. Come si può intuire, bastava poco perché un legaccio si rompesse e una tavoletta finisse al posto sbagliato. Non sappiamo nulla di questo Lao Tsu che si dice l’abbia scritto, e il testo, a differenza per esempio della Bibbia, non è mai stato sottoposto a un’indagine filologica, scientifica, volta alla ricostruzione del testo originale, fino a tempi molto recenti.

È così che, negli anni Venti, Duyvendak si cimenta in quest’opera: offrire al taoismo gli strumenti della scienza occidentale per riportare alla luce il testo di Lao Tsu, purgandolo da tutte le modifiche successive. Già il primo capitolo prende allora una nuova forma:
La Via veramente Via non è una via costante.
I Termini veramente Termini non sono termini costanti.
Il termine Non-essere indica l’inizio del cielo e della terra; il termine Essere indica la Madre delle diecimila cose.
Così, è grazie al costante alternarsi del Non-essere e dell’Essere che si vedranno dell’uno il prodigio, dell’altro i confini.
Questi due, sebbene abbiano un’origine comune, sono designati con termini diversi.
Ciò che essi hanno in comune, io lo chiamo il Mistero, il Mistero Supremo, la porta di tutti i prodigi.(Tao Tê Ching, a cura di J.J.L. Duyvendak, Adelphi, 1975, Milano, p.26)
Sì, si capisce poco lo stesso. Però Duyvendak, oltre ad emendare il testo, lo interpreta filosoficamente, e ce lo rende più chiaro. Quello che nella traduzione di Matgioi («La via, che è una via, non è la Via») ci appariva come un paradosso, o addirittura come l’indicazione di altre vie possibili, qui invece diventa più comprensibile. La via di cui si sta parlando è il Tao, che appunto vuol dire via, percorso, cammino. Questa via, dice il Tao Tê Ching, è una “via-non via”, una via che immediatamente nega se stessa. E dunque è una via incostante, mutevole.
Se leggiamo questa incostanza con gli occhi della filosofia occidentale, ci rendiamo conto che Lao Tsu identifica il Tao con il divenire, con il trascorrere del tempo e il mutare delle cose. I Termini veramente Termini, cioè le parole, non sono costanti. Non vi è costanza né nelle cose, nella realtà, né nel linguaggio. Il linguaggio dunque muta assieme al mutare delle cose. Ecco cosa intende Matgioi quando traduce con «Il nome, che ha un nome, non è un Nome»: la parola ha una sua sostanza, dice qualcosa, ma non è eterna, non è immutabile. È l’incostanza, il fatto che le cose prima sono, poi non sono più e poi tornano ad essere a caratterizzare l’esistenza. È il continuo fluttuare delle cose che intende Lao Tzu: la precarietà e l’incostanza dell’essere.
Questo ricorda molto da vicino il Logos di Eraclito. Anche se per Eraclito il Logos è ragione, mentre il Tao sfugge alla ragione. L’idea greca di un uomo che fa come il bambino di S. Agostino e si mette tutta la realtà nella testa come il mare in un secchiello è lontana dal taoismo: «senza nome è l’origine del cielo e della terra». L’origine della realtà è oscura, criptica, da farsi amica con stratagemmi e magari pratiche magiche e alchemiche. «Non si può determinare il Tao né dandogli un nome né applicandogli una concezione intellettuale umana», scrive l’ufficiale francese.

Infatti, come abbiamo detto, i Nomi stessi, i Termini sono incostanti. Il rapporto tra parole e realtà è centrale in ogni sistema filosofico: come conoscere le cose, se non sappiamo dare loro il giusto nome?
I filosofi cinesi hanno dato vita a un confronto sul rapporto tra le parole e le cose, in un modo non molto diverso dal dibattito occidentale. Anche tra i cinesi è nata una scuola sofistica, per esempio, e anche tra i cinesi vi erano dei filosofi realisti e dei filosofi nominalisti. I primi, come i seguaci di Confucio, ritenevano che a ogni termine corrispondesse in uno e un solo oggetto, e che questo termine “rispecchiasse” possiamo così dire, la cosa a cui si riferiva. Il più importante di questi filosofi era Hsün-tzu. Invece dal taoismo nacque una scuola che si opponeva a questa visione statica: i termini cambiano a seconda delle epoche, delle cose che esprimono, del modo che abbiamo di vedere le cose, e così via. La realtà non è perfetta e ordinata, ma non è nemmeno un caos incomprensibile. Al contrario, è un oscuro caos ordinato.
Se scorriamo il testo, troveremo nel capitolo XXVI[2] un’immagine interessante: «Il pesante è la radice del leggero; la quiete domina l’agitazione». Il continuo permearsi delle cose è ossimorico, contrastante, eppure nulla esiste senza il suo opposto: al di là di come il mondo ci appare c’è un segreto ordine.
Al capitolo X[3] si trova: «l’essere è generato dal non essere». L’essere è generato dal non essere. Dal nostro punto di vista, è una chiara violazione del principio aristotelico di non contraddizione: è un anti-Parmenide. Il contrario di tutto ciò che fino a Kant ed Hegel ha contraddistinto la nostra filosofia. E questo ce lo rende particolarmente interessante.
Se infatti la nostra cultura solo tardivamente si è dovuta arrendere alla contraddittorietà del reale, con pochissime eccezioni tra cui Eraclito, il Taoismo la porta interiormente. La contraddizione è il motore delle cose, è ciò che spinge le cose a diventare altre cose, diverse da come sono oggi: se non ci fosse contraddizione non ci sarebbe movimento. È il vuoto all’interno del vaso a generare il vaso, è la quiete a generare l’agitazione: il pesante nasce dal leggero e il leggero nasce dal pesante.
È l’inizio di un pensiero dialettico, quel pensiero cioè che concepisce la realtà come un continuo crearsi e sciogliersi di contrapposizioni, di contraddittorietà, e che ha trovato il suo apice nella filosofia hegeliana.
Interessante poi vedere come da un lato Duyvendak parli del «costante alternarsi del Non-essere e dell’Essere» Matgioi parla di «sentire»: e lo lega all’uomo. In questo senso l’interpretazione di Matgioi sarebbe ancora più vicina alla filosofia di Eraclito, in cui gnoseologia e ontologia si fondono: il Logos di Eraclito, infatti, è a realtà, la parola e lo stesso uomo che vive la realtà e pensa la parola. L’ipotesi sarebbe avvalorata anche dal fatto che Tao significa “dire”. L’inafferrabilità del reale, dunque, è sia l’inafferrabilità della contraddizione sia la difficoltà dell’uomo di poterla comprendere.
Non solo: questa fusione tra ontologia e gnoseologia si ritrova anche in Hegel, e nel pensiero post-hegeliano, per quanto declinata diversamente, in modo non metafisico: nel suo procedere storico, la realtà è scindibile dal pensiero sulla realtà, ma non dal punto di vista logico. Se guardiamo però alla struttura logica del reale, allora gnoseologia e ontologia coincidono.
Di diverso avviso però Duyvendak, che ci ricorda che nel testo non si trova mai la parola Tao con il significato di “dire”, “affermare”, e come probabilmente chi scrisse il Tao Tê Ching non si ponesse questi problemi. La prova starebbe nell’ambiguità proprio dell’incipit dell’opera. Molti traduttori traducono infatti: «Il Tao che può essere espresso non è l’eterno Tao». Secondo Duyvendak questo sarebbe un errore, perché distingue tra un Tao che può essere detto e un Tao che non può essere detto. Cioè, detto in termini kantiani, tra un Tao fenomenico e un Tao noumenico. Ma in tutto il Tao Tê Ching non si trova mai questa divisione, né si trova un accenno a simili problemi. Semplicemente, ciò che Lao Tsu starebbe dicendo, è che il Tao, la via, non è eterna, non è costante. Che ogni cosa muta, e l’unico significato del reale sta in questo incessante mutamento.
Certo, anche dopo queste spiegazioni il Tao Tê Ching risulta oscuro. Non è, infatti, un testo filosofico. Non vuole spiegare. È un testo oracolare, religioso, a volte più simile a una serie di appunti, a volte più simile a una serie di parole magiche. Anche la struttura del testo, diviso in 81 capitoli, cioè 3 alla quarta, mostra come tutto richiami a un ordine e a un significato sacro. Non è una spiegazione della realtà (sarebbe inutile: non si può spiegare). ma la sua rappresentazione. la sua essenza. Non è nemmeno un testo, alla fine, è quasi una pietra preziosa, un talismano. Qualcosa da seguire per un arcano significato interiore, che però ci sfugge: esattamente come la realtà, alla fine.
E la forza di questo testo forse sta proprio in questo. In così poche pagine, sprigiona un intero universo filosofico, una visione del mondo diversa, affascinante, anticipatrice della nostra filosofia dialettica, e nello stesso tempo oracolare, primigenio, preistorico. Come la filosofia di Eraclito, anche il Tao Tê Ching si sviluppa per accenni, per poche pennellate. Le sue parole non vogliono spiegare la realtà: la vogliono incarnare.
La via è una valle ombrosa. Oltrepassa il fiume, s’inerpica nel bosco. Forse è semplicemente qui, nel suono di un torrente, nel silenzio rumoroso degli alberi, che si può incontrare Lao Tsu.