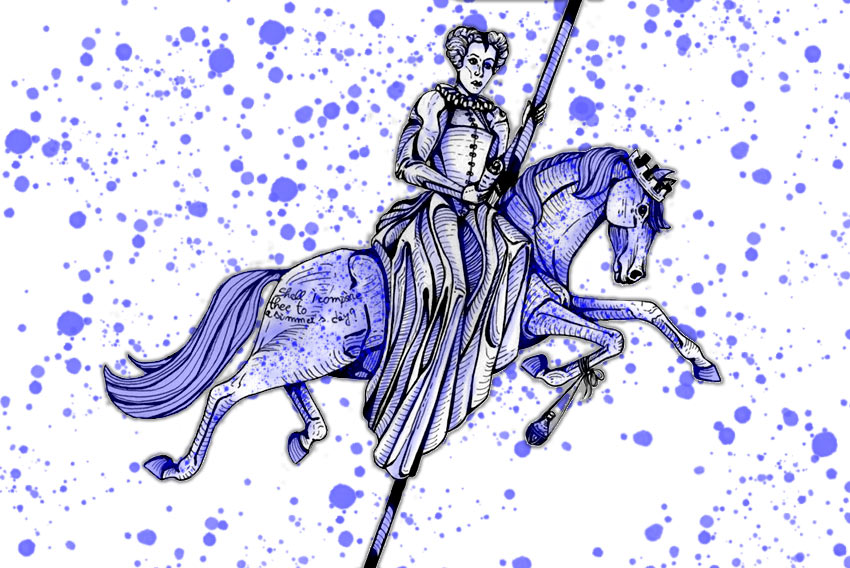Vestono a lutto le galline-umane che accendono il palco (ridotto, vuoto) del Teatro Melato: inizia così Re Chicchinella, l’ultima pièce teatrale di Emma Dante, continuo di una serie di spettacoli ispirati a Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile e preceduto da La scortecata (2015) e da Pupo di Zucchero (2021).
Sul proscenio, un ammasso di tessuto da cui escono la testa poi il corpo del re, e quello scampolo diviene una gonna, unico abito a coprire la sua nudità. A evocarlo sono due servitori, ed è il dialogo tra i tre personaggi a rivelarci la sua condizione: una gallina si è attaccata alle sue viscere e lo divora da dentro, nutrendosi di tutto ciò che mangia. Nel tentativo di liberarsi di questo parassita, il re si sta lasciando deperire, rifiutando qualsiasi forma di nutrimento. Entrano a questo punto le damigelle di corte, creature allegre e frivole, eccessivamente adornate, seguite poco dopo dalla moglie e la figlia del re.
È a queste ultime che il re getta un’accusa: quella di essere disinteressate alla sua salute, e di volerlo convincere a mangiare solo per ricavare dal suo corpo le uova d’oro della gallina.

La corte si configura, in questo lavoro della Dante, come un ampliamento del nucleo familiare: la teatrografia dell’autrice indaga i meccanismi di questo microcosmo sin dai suoi esordi, a partire dalla Trilogia della famiglia siciliana (mPALERMU, Carnezzeria, Vita mia).
La famiglia, per la Dante, è il luogo della sofferenza: i personaggi che la abitano sono asfissiati e limitati dalle loro comunità di origine. Quelle radici che tanto spesso occupano uno spazio centrale nel lavoro della regista palermitana, si fanno vox media: quelle radici che tanto sono simbolo di appartenenza e momentaneo sollievo, sembrano invece essere, quanto mai, l’origine di un male profondo.
Nel contesto di questa pièce, dunque, la condizione alterata e “da cunto” (nella dimensione fantastica di questa “gravidanza” interspecie) del protagonista si offre a una forma di analisi cruda e antitetica della nostra realtà. L’impotenza a reagire di Re Chicchinella – febbrile e autodistruttiva – passa attraverso il rovesciamento dell’idea di paternità e mascolinità canoniche: il corpo gravido di Re Chicchinella ribalta le narrazioni riguardanti genere e potere – non a caso, sono moglie e figlia ad avere in realtà il controllo sulla corte.
Non è un’incursione nuova quella della Dante nello studio del genere. Già La scortecata offriva un ribaltamento dei ruoli: Carolina e Rusinella, protagoniste dell’originale testo di Basile, diventavano nello spettacolo due uomini, in un gioco in cui il maschile era chiamato a interpretare il femminile.

Anche nella sua rendizione dell’Eracle si parlava di genere: la semplice possibilità che la figura di eroe non sia riconosciuta solo come un corpo maschile, ma che essa possa esistere in entrambe le forme, anche come donna, sottolinea come qualunque corpo possa incarnare il mito. Il tema centrale di tali narrazioni è la danza tra maschile e femminile – attraverso il feticcio degli abiti – è la volontà di decostruire ciò che conosciamo, di usare le radici dell’antico (il ricorso al mito, alla fiaba) per parlare di queerness, aggrappandosi ad una cultura – quella meridionale – che tanto estranea alle figure ibride non è.
Legate al genere e alla sua sovversione sono anche le figure delle damigelle in Re Chicchinella: un gruppo di performer, tra cui figurano donne e uomini in numero misto e le cui caratteristiche sessuali secondarie sono esagerate al limite del grottesco, vestite di calze a rete e sottogonne, dai fianchi e i seni pieni.
Ce lo dice anche ne Le pulle, in cui la transessualità e la volontà di porsi come creature a metà tra aner (ἀνήρ) e la gyne (γυνή) sono il tema principale. Le pulle (prostitute, in dialetto palermitano) pregano le loro madonne di cambiare i loro corpi senza ricorrere al dolore del cambiamento medico, evitando loro le ire della chiesa. La fluidità assume quindi un carattere mitico nel momento in cui esso diventa lo spazio dove trovare la libertà dalle definizioni: è qui che prende forma l’ibridazione, che prende respiro dalle costrizioni del binarismo.

È ricorrente nel teatro dantiano, ugualmente, il cibo, perché le scene dal gran portato emotivo hanno sempre come fulcro il consumo: l’assurdo cerchio infernale della famiglia mPALERMU che culmina nella scena in cui Giammarco, il figlio minore, si ingozza con i pasticcini della famiglia e ancora in Maria, secondogenita di cinque sorelle – personaggio che fa da legante ne Le sorelle macaluso – che mangia con rabbia un vassoio di dolci dopo aver rivelato alle sorelle della sua malattia, e così anche il nostro Re, che dopo tutta la mole di cibo osservato, può a stento mangiare un’oliva e una galletta. L’atto del consumo diviene così uno sfogo delle frustrazioni familiari, in cui si cerca conforto, ma non solo: esso diventa anche modo per sostanziare il dolore della perdita.
Alla fine, l’umiliazione data dalla sua condizione e l’impossibilità di fidarsi di chi lo circonda sono fatali per il re, che stramazza al suolo al centro del palco, attorno a lui si costruisce pezzo per pezzo una chiesa improvvisata e la morte del re che diventa non una morte definitiva, ma frangente di passaggio: emerge dalla sua salma la gallina, interrompendo il pianto della corte, che muta nella celebrazione gioiosa di questa nuova nascita.
Il teatro dantiano gioca da sempre coi limiti sottili tra morte e vita, lutto e festa. Il mondo della regista non segue le regole terrene. Vita e morte convivono, anzi, l’opera di Dante è la festa dei morti.
Se l’articolo ti è piaciuto, leggi tutti i nostri contributi sul teatro.
In copertina: Fotografia di Masiar Pasquali, per gentile concessione del Piccolo Teatro di Milano.