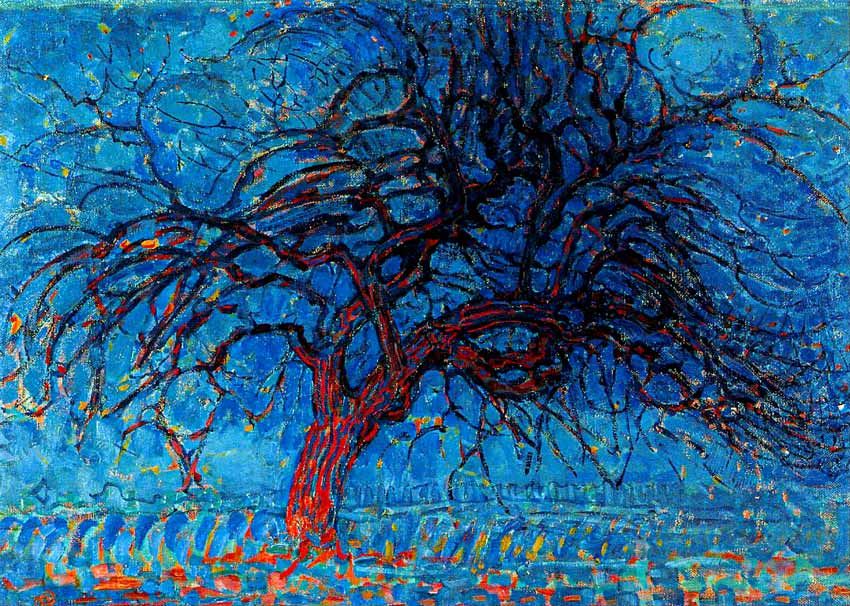«Comprendetemi nella mia posizione solitaria – alcuni mi reputano “bolscevica”, altri “monarchica”, altri, ancora, entrambe le cose, e tutti sbagliano[1]».
Marina Cvetaeva è stata una poetessa vorace, capricciosa, a tratti incomprensibile. Nata nell’ultima decade dell’Ottocento, ha vissuto nella sua giovinezza il periodo più sconcertante della storia russa, in cui una società secolare veniva spazzata via nel giro di una quindicina d’anni. Per la Cvetaeva tutto ciò si traduce in miseria, fame, una vita difficilissima, con due figli e il marito partito volontario nell’armata bianca. È il 1919 quando Marina porta le sue figlie nell’orfanotrofio di un paese fuori Mosca, per dare loro la possibilità di sopravvivere: sarà una scelta fatale. Le due bambine in orfanotrofio si ammalano; la poetessa allora decide di prenderne una con sé, lasciando l’altra all’orfanotrofio. Sarà poprio quella che non ha portato con sé a morire.
Nel ’22, a 29 anni, Marina lascerà la Russia, quando scopre che il marito, è vivo, ed è in Boemia. Da lì si stabilirà, nel ’25, a Parigi, continuando a collaborare con le riviste degli emigrati russi.
Tra i poeti russi della sua epoca, la Cvetaeva è forse quella che più si schiera apertamente contro la rivoluzione bolscevica. Certamente il marito, con cui ebbe un rapporto di grande amore nonostante le tante relazioni extraconiugali e amori fortissimi che Marina coltivò nel corso della sua vita, fu determinante nella sua scelta di campo. Ma, forse, furono proprio le privazioni, la povertà e la difficoltà a incidere sulle sue idee. È difficile tracciare in poche righe un quadro anche solo indicativo della posizione dell’intellettualità russa di fronte a un evento di tale portata. Se gli avanguardisti sposarono immediatamente la causa, vi fu anche, soprattutto fra i poeti, una serie di posizioni più sfumate. Ed è proprio qui, fra poeti come Pasternak e Osip Mandelstam, che Marina Cvetaeva trova riconoscimento.
C’è, in tutti questi poeti, quella stessa preoccupazione, quel sentimento che si vede espresso in Cechov, in Tolstoj, o, forse ancor di più, nelle poesie di Sergej Esenin (che pure si arruolò nell’armata rossa): il senso di un mondo che muore, trascinandosi dietro sì tanto orrore, ma anche una strana, antica, grazia. Al lettore che si trovi di fronte solo il testo più celebre di Marina Cvetaeva, Dopo la Russia, pubblicato nel ‘28, il legame può sembrare meno evidente: in questa raccolta la Cvetaeva racconta il suo esilio, i suoi amori, le sue passioni, ricorrendo spesso a una simbologia classica. Parla di Elena, di Troia, del mito di Ippolito e Fedra; racconta la sua passione, racconta di poeti, scrive poesia sulla poesia, in un moto intimistico, solitario, slegato dalla semplice esistenza, come se l’ordinarietà delle cose non la riguardasse più.

Quell’assoluto che si esprime in Dopo la Russia è il risultato di un lungo percorso di rarefazione, di sintesi. I suoi versi essenziali, scarni, arsi, in origine erano qualcosa di diverso. Per scoprirlo, ci aiuta La principessa guerriera, un poema che vide la luce proprio nel ’22, nel momento in cui Marina iniziava il suo esilio. Per noi italiani è finalmente giunto Sandro Teti Editore che l’ha recentemente pubblicato, per la prima volta nel nostro paese, con la traduzione di Marilena Rea e una sorprendente postfazione di Monica Guerritore.
Il poema appare, per molti aspetti, diverso rispetto alla Marina Cvetaeva più matura: uno stile barocco, polifonico, in cui il tono e la narrazione cambiano continuamente: una trama semplicissima, ma presentata in modo irto, intricato, come uno specchio rotto. La scena si svolge alla corte dello Zar, in un tempo indefinito, che può essere medievale come può essere il giorno prima della rivoluzione. La moglie dello Zar si invaghisce del figliastro, lo Zarevič, che a sua volta è desiderato da una misteriosa principessa guerriera, la Zar-fanciulla. Per toglierlo dalle attenzioni di questa, la moglie dello Zar escogita un incantesimo che addormenterà lo Zarevič ogniqualvolta la principessa si avvicinerà a lui.
L’essenza dell’opera è la stessa di tutta la produzione della Cvetaeva: il desiderio, l’amore inteso come carnale bramosia, come passione cieca, fino addirittura a oggettificare l’altro, facendo sì che si cerchi di concupirlo in ogni modo, con ogni mezzo, e a qualsiasi prezzo. Un desiderio abbagliante, come fu per lei l’amore con la poetessa Sofija Parnok, di quelli che si imprigionano di ogni lato del nostro essere, e che pervade, con declinazioni differenti, tutti i personaggi, meno lo Zarevič, bellissimo ma insulso, innamorato della sua musica ma incapace di un ruolo attivo all’interno della vicenda, pur fungendone da motore immobile.
A proposito del poema, si è osservata l’identificazione di Marina Cvetaeva nel personaggio della principessa guerriera, della fanciulla indomita, indomita com’era lei. Eppure, leggendo il testo, la principessa appare come un personaggio fortissimo ma statico, come poteva esserlo Brunhilde nella tetralogia wagneriana. Il personaggio più interessante, più sfaccettato, polimorfo, è invece quello della matrigna, la moglie dello Zar.
Non sappiamo l’età della donna, ma sappiamo che Zarevič rifiuta di concedersi a lei, considerandola vecchia; nondimeno, riesce a essere avvenente nel corso del poema; è detestata e nello stesso tempo desiderata dal marito e dagli altri personaggi; inganna, ordisce sortilegi, ma lei stessa è ingannata, e prima di tutti è ingannata dalla sua stessa brama. E la stessa Cvaeteva ci ammonisce di non giudicarla, proprio nei passi più grotteschi del poema.

La lettura della Principessa guerriera apparirà complessa anche al lettore avvezzo alla poesia, proprio per la non-linearità dell’esposizione, per il continuo affastellarsi di voci e di scene: in certi momenti non si comprende quale sia il sogno e quale sia la realtà; dove la vicenda sia immaginata e dove invece sia reale. Ma è l’esatto effetto che deve sortire questo poema, che più che un’opera compiuta, è una domanda. Un’urgenza.
Quando compone il poema, Marina Cvetaeva ha perso da poco una delle sue bambine. La guerra civile ha martoriato la Russia in un modo profondo anche per le dure condizioni della Russia pre-sovietica. Nondimeno, Marina Cvetaeva continua a desiderare. Ad amare e a desiderare: è quel desiderio, che passa di personaggio in personaggio, di voce in voce, di poesia in poesia, il filo conduttore della sua vita. E allora scrive un poema-favola sul desiderio.
Un poema-favola che appaia completamente diverso dal mondo, là fuori, che conosce. Una favola che mostri quel tempo fermo e indefinito della società prima della rivoluzione. Ma una favola grottesca. Una favola marcia, in cui quella bellezza e quell’apparente atmosfera idillica siano in ogni momento guastate, torturate, rese inservibili. L’unico personaggio veramente puro, infatti, è la Zar-fanciulla, che sembra non solo non aver niente a che fare con ciò che sarà dopo l’Ottobre, ma nemmeno con l’epoca deli Zar. Un personaggio che pare uscito soltanto dalle fiabe, dal mondo magico degli artisti ottocenteschi russi.
E, alla fine della fiaba, l’apocalisse della rivoluzione, che arriva come un sipario a fare strame di tutte quelle leggende, del grottesco e dell’ingenuo, del favolistico e del tremendo, lasciando solo una selva di dubbi.
Forse è per questo che, in un modo o nell’altro, tutti sbagliavano a considerare le idee di Marina Cvetaeva, a inquadrarle in una definizione. Perché dentro quelle idee, come per Esenin, come per Pasternak, si agita l’affezione del poeta verso quelle cose indefinibili ed effimere, quelle cose banali come un petalo o un amore o una storia di cavalieri antichi. Al punto che, una volta perdute, si può solo inaridire la propria poesia, sceglierne le parole, affinarla fino all’essenziale, in modo da poterle far vivere, se non nell’esistenza, almeno nell’austera purezza di un verso.