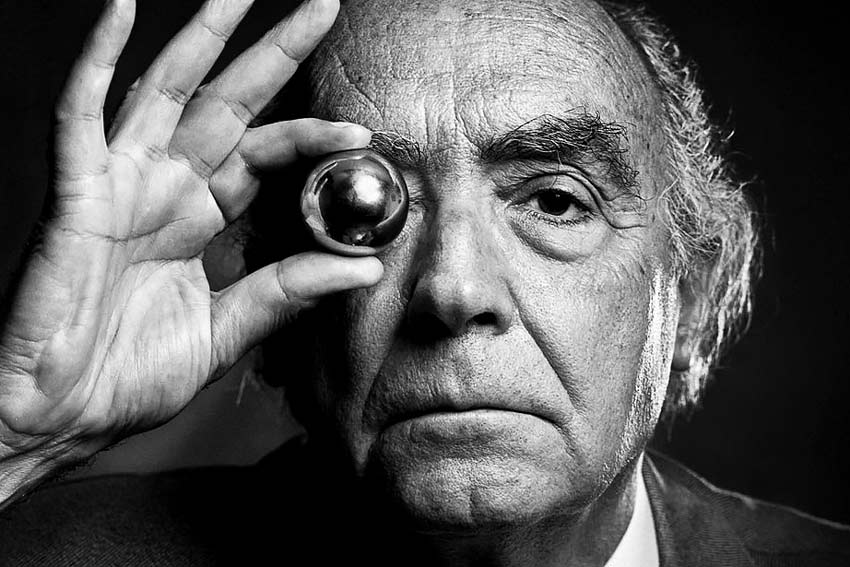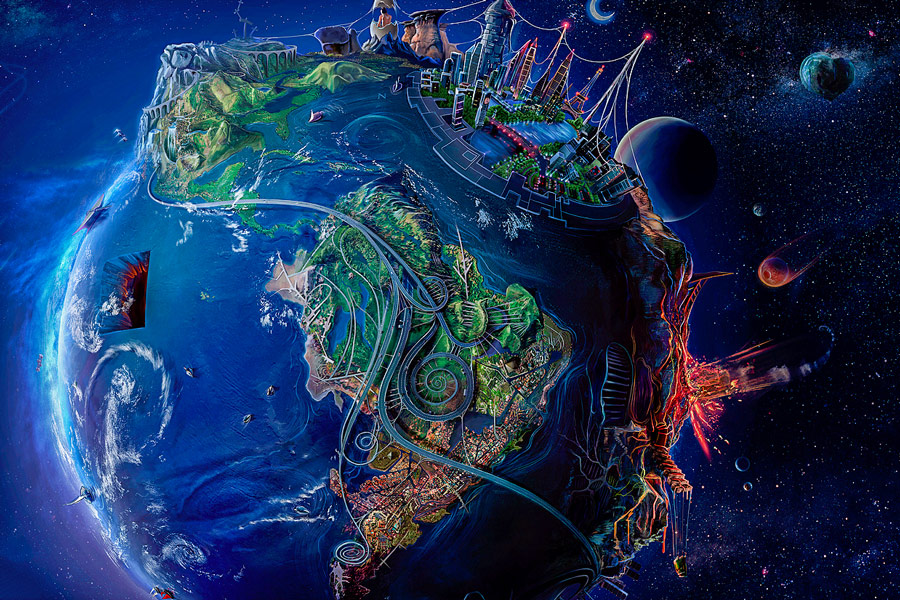Chi cerca il cuore della storia nell’interstizio fra la creazione e il suo autore si sbaglia: conviene invece cercare non nel campo fra lo scritto e lo scrittore, bensì in quello che sta fra lo scritto e il lettore.
Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra[1]
Ho sempre avuto pensieri contrastanti nel considerare la filologia, e in particolare la filologia d’autore. Quando Claudio Giunta, nel lontano 2012, sconsigliava ai giovani di studiare questa disciplina, mi sembrò una bestemmia. Ho poi trascorso gli anni seguenti a chiedermi se non avesse ragione.
Andiamo con ordine, però. Intanto, che cos’è la filologia?
In breve, la filologia è lo studio dei testi antichi. Uno studio che comprende una serie di aspetti. Il primo è la ricostruzione del testo antico: di Dante, per esempio, non ci è arrivata nemmeno una parola scritta di suo pugno, bensì copie di copie delle sue opere, scritte da addetti specializzati, i copisti, che fino all’invenzione della stampa erano le figure che si occupavano della trasmissione dei testi.
Essendo quindi la copiatura fatta interamente a mano, non era raro che si verificassero degli errori, delle incomprensioni, che hanno generato, nel corso dei secoli, testi con differenze anche notevoli. Raccapezzarsi in questo ginepraio di errori è il compito della filologia propriamente detta, l’ecdotica, e si tratta dunque di un lavoro estremamente tecnico, anche se affascinante: «Filologia, lavoro pulito. Come quello del radiologo in medicina. Capire questo a diciotto, vent’anni può salvare dall’estetismo inconsapevole e da varie altre forme di vaghezza» scriveva Vittorio Sereni[2].
Con l’avvicinarsi all’epoca contemporanea, però, l’ecdotica perde di utilità, in quanto, se pensiamo anche solo ai romanzi ottocenteschi, per non parlare di quelli del Novecento, i testi sono ampiamente noti, e non hanno bisogno di una ricostruzione: l’ecdotica, di per sé, è infatti una disciplina archeologica, con dei limiti e un campo di applicazione specifico: senza l’errore umano dato dai copisti, o da tecniche di stampa ancora imperfette, com’era all’inizio dell’età moderna, non vi è necessità di una disciplina come l’ecdotica.
È così che, nel primo Novecento, nasce, tra Francia e Italia, un nuovo tipo di filologia, che prende il nome di filologia genetica, o filologia d’autore, volta a occuparsi della “ricostruzione del testo” in un senso nuovo rispetto a quanto si era fatto fino a quel momento.
Se infatti di un autore moderno si conosce l’opera perché è stata stampata, questa non nasce mai così, dal nulla: nasce da un lungo processo di “generazione”, appunto, in cui una serie di idee, di abbozzi, di “scartafacci”, vengono poi elaborati, e così si arriva a una prima redazione, poi a un’edizione vera e propria e spesso anche a più edizioni, dissimili tra loro. La filologia d’autore si occupa proprio di ricostruire la storia che sta prima e intorno alla pubblicazione di un testo: la sua genesi, e in generale le variazioni che l’autore ha apportato nel corso del tempo.
Vi sono casi, inoltre, di scrittori pubblicati postumi, dove questo problema diventa fondamentale per la costituzione stessa di un testo: casi principi della letteratura italiana sono Il partigiano Johnny di Fenoglio e Petrolio di Pasolini, che sono costituiti esclusivamente da abbozzi e appunti; vi sono però anche casi extraletterari importanti, come Gramsci, o Marx, che è stato profondamente frainteso proprio a causa della natura incompiuta della sua opera.
La filologia d’autore, dunque, ci ricorda che il nostro rapporto con i testi è sempre problematico e relativo: non esiste l’opera assoluta, compiuta, perfetta: esistono tante varianti, tante versioni diverse della stessa opera. L’arte, in questa prospettiva, non è un prodotto, bensì una ricerca: anche quando l’autore è soddisfatto, continua a interrogarsi attraverso altre opere. Ecco perché l’autore ripete.
Pensiamo a Monet, alle serie di ninfee o di cattedrali tutte uguali e tutte diverse; o Joyce, che scrive e riscrive le stesse vicende, ogni volta cercando un modo diverso, un’angolazione differente; a Saba, a Pirandello. Ogni autore ha le sue ossessioni, attraverso le quali l’autore si avvicina a una definizione sempre più precisa del suo mondo di cose. E qui riecheggiano le parole di un importante filologo italiano, Gianfranco Contini, secondo cui lo stile è «il modo che ogni autore ha di conoscere le cose[3]». L’opera è dunque una concrezione sedimentaria che ha uno scopo: la comprensione e l’interpretazione della realtà.
Ecco, ma allora, se la filologia d’autore è così importante, perché diffidarne?
In realtà qualche ragione c’è. O meglio, qualche ragione di diffidare di un orientamento ancora largamente diffuso in questa disciplina, che porta paradossalmente a negare l’entità fluida e dinamica dell’opera.

Infatti, se la filologia d’autore ci ricorda che l’opera non è un unicum, però può ingenerare l’idea che il modo con cui è stata creata un’opera, il processo materiale dell’autore, dica già tutto della sua creatività, e che quindi il senso stesso, il segreto dell’opera stia nella sua genesi, nel modo fisico con cui è stata creata. In altre parole, una volta analizzati tutti gli abbozzi abbiamo già detto tutto quello che c’era da dire sulla vita creativa di un autore, e abbiamo concluso il nostro compito non solo filologico, ma anche critico.
Ecco perché, per gli undici anni successivi all’articolo di Claudio Giunta, mi sono chiesto se in fondo non avesse ragione: il lavoro filologico, ecdotico o genetico che sia, è, in fondo, un lavoro propedeutico alla critica letteraria, ma la diffusione (e la predominanza, almeno per quanto riguarda l’ecdotica) di questa disciplina nelle università, nelle accademie, nei programmi di ricerca e così via porta a suggerire l’opposto, e cioè che la critica letteraria si esaurisca nella filologia. Il binomio “filologia e critica” è tanto usato da risultare logoro, eppure è molto spesso sbilanciato sul primo termine.
In diverse università, per esempio, non esiste nemmeno un corso di teoria narrativa in cui si spieghi come si struttura un romanzo, quali siano le linee narrative base, cosa sia una sottotrama, come si sia evoluta la tecnica narrativa nel tempo, e così via. Tutto questo è demandato alle scuole di scrittura, come Holden o Belleville, tra l’altro private.
E questo porta al grande paradosso per cui nelle aule di Lettere si discetti di autografi, di carte filigranate, di varianti minimali tra una stesura e l’altra e non del significato di un romanzo o di una poesia. Con il risultato che i processi formali vengono indagati in modo fine a se stesso, e non in rapporto al contenuto delle opere, alla loro ragion d’essere, al loro rapporto all’interno di un panorama letterario e artistico complesso.
Le ragioni di questa impostazione accademica sono molte: innanzitutto il fatto che lo studio della letteratura è sempre condotto dal punto di vista di chi legge e non di chi scrive. Sono le scuole di scrittura a chiedersi come rendere bella e appassionante un’opera; l’università non si pone nemmeno il problema.
In secondo luogo, l’approccio storicistico: l’idea che a scuola non si studi la letteratura in sé, la critica letteraria in sé, ma la storia della letteratura, la storia della critica letteraria, e così via, che porta con sé un altro spiacevole equivoco: che si studi la letteratura per gusto archeologico e non per il gusto del presente. Che Dante sia importante non per quello che dice a noi oggi, ma come esempio della mentalità di un’epoca. Cioè, che lo studio della letteratura, in fondo, non sia un occuparsi del presente, ma una curiosità feticistica del passato, come per gli appassionati di filatelia o di numismatica.
A discolpa, però, dello storicismo crociano, è necessario dire che lo studio cronologico permette di relativizzare le discipline (cosa che non avviene, per esempio, con le scienze) e di renderci conto che non esiste un modo “giusto” di intendere la letteratura, o un unico approccio critico alla letteratura, bensì una serie di approcci che si sono succeduti nel tempo. E, infine, bisogna ricordare che Croce non aveva una grande opinione dei filologi.
C’è però un’altra ragione, ben più ardua e profonda, della centralità della filologia negli studi letterari: la sudditanza culturale degli studi umanistici nei confronti del sapere scientifico. A fronte della progressiva marginalizzazione degli studi letterari, si è diffusa a più riprese l’idea che, per colmare il divario, gli studi letterari dovessero diventare essi stessi maggiormente scientifici, e adottare metodi equivalenti a quelli delle scienze. Ed è proprio in questo contesto che si sviluppa la filologia d’autore.
Scrive Giunta, a proposito di un passaggio di Paola Italia sul Diario postumo di Montale, usato come caso di studio per mostrare le potenzialità della filologia d’autore:
Paola Italia più che altro usa questo case study per fare delle considerazioni di buon senso, sempre benvenute. Benvenuta è anche la cautela; solo un po’ inquietante (almeno per me) l’appello alla Scienza: «il metodo di un’expertise attribuzionistica non è scientifico e non lo sarà finché non si potranno introdurre sistemi quantitativi e qualitativi di analisi dell’autografo (spettrografie, analisi all’infrarosso, trattamento delle foto digitali con programmi di gestione delle immagini) che permettano di datare le serie scrittorie e correttorie». A questo traguardo «i progressi tecnologici fanno sperare che manchi davvero poco». Non saprei spiegare bene perché, ma per quel giorno – non così prossimo, mi auguro – spero di essere morto.
(Claudio Giunta, Vale solo la pratica. Sulla filologia d’autore, su Le parole e le cose, 4 agosto 2015)
Non mi auguro la stessa sorte di Claudio Giunta, ma credo di poter concordare sull’inquietudine. Non tanto perché le analisi con strumenti tecnologici mi spaventino, o perché la letteratura debba rimanere appannaggio di un metodo d’indagine naif e istintivo, o perché, come dice il luogo comune “la poesia non si insegna”: perché l’idea di scienza che emerge dalle parole di Paola Italia, e in generale dall’idea di ricerca di molta parte della filologia italiana (si pensi a Gianfranco Contini, che per tutta la vita sosterrà l’idea della filologia come studio di strutture, o a Maria Corti) è un’idea problematica, anche per la scienza stessa.
È l’idea verificazionista della scienza, per cui la scienza “verifica” determinati “fatti”, separandoli dalle “opinioni”, e che dunque la conoscenza non sia altro che un progressivo cammino di avvicinamento, in modo non dissimile da come il poeta o lo scrittore procede nel suo lavoro.
In realtà, nonostante queste idee godano di una certa importanza ancora oggi, da tempo il dibattito epistemologico ha mostrato che il rapporto tra fatti e interpretazioni è tutt’altro che scontato: non possiamo mai separare l’essere umano dalla realtà che studia, né considerare la verità come una “cosa” statica che si raggiunge, che si tocca, come se fosse una pietra preziosa. La verità, invece, è un processo, e dunque è mutevole: cambia con il nostro stesso muoverci.
Un approccio alla filologia d’autore eccessivamente tecnico se da un lato sembra quanto di più serio si possa desiderare per una disciplina scientifica, dall’altro rischia di considerare la verità dell’opera letteraria proprio come un oggetto. Tanta acribia, tanto approfondito dei testi, la loro sistematica datazione, la loro considerazione precisa nei minimi dettagli sono sì certamente importanti dal punto di vista storico, ma rischiano di non dirci nulla riguardo al senso ultimo del fare letteratura. E portano con sé l’idea che l’opera sia, alla fine, un problema, e che dunque sia necessario analizzarla e sezionarla finché non lo si è risolto, e non si è sciolto l’enigma.
Questo metodo finisce così per negare proprio l’intuizione principale della filologia d’autore: che l’opera assoluta non esista. Infatti, se qualsiasi filologo d’autore sa perfettamente che l’opera perfetta non esiste, si riferisce però sempre ad essa come a un fatto materiale. Un fatto materiale che però tende a un obiettivo irraggiungibile, quasi mistico. L’assolutezza si sposta dunque dall’opera come oggetto all’opera come idea, che diviene imprescindibile: è in suo nome che bisogna ricostruire tutta la storia genetica dell’opera; è in suo nome che il privato dell’autore dev’essere scandagliato nel profondo. Per capire non solo l’opera, ma ciò che sta oltre l’opera, l’obiettivo stesso dell’autore, l’indicibile, l’ineffabile.

Peccato che questo “oltre” dell’opera non sia una cosa, non stia dentro il testo, non sia rintracciabile in un’analisi, per quanto minuziosa, dei processi materiali della scrittura: non è sapendo l’ordine preciso con cui Leopardi ha pensato tutte le parole dell’Infinito che capiremo l’Infinito; non è neanche sapendo cosa faceva mentre lo scriveva, o che cosa gli passava per la mente in quel momento. Non possiamo entrare nella mente dell’autore, e ogni tentativo, per quanto si pretenda rigoroso e “scientifico”, è destinato a fallire perché sbaglia il bersaglio.
L’oltre dell’opera è il suo significato: e per comprendere il significato è necessario innanzitutto misurarsi con i concetti che l’autore esprime; è necessario analizzarne le tecniche stilistiche che utilizza, capirne le parentele letterarie, e infine è necessario capire il rapporto tra noi e l’opera: dobbiamo metterci noi stessi nell’opera. Cercare di capire meglio la genesi dell’opera è di certo utile in questo percorso, ma è solo uno dei tanti elementi utili per la nostra interpretazione.
Ciò che invece è fondamentale è la relazione: la relazione tra la letteratura e la realtà, ma anche la relazione tra noi stessi e la letteratura. Se si perdono di vista i legami che intercorrono tra gli oggetti del nostro studio, perdiamo di vista la loro essenza, il loro scopo. Ci rassegniamo alla morte dell’opera; al fatto che, come l’entomologo ottocentesco studiava la farfalla infilzandola e disponendola in una teca di vetro, così anche noi non possiamo che uccidere l’opera mentre la sezioniamo.
Non è un caso che le concezioni che stanno alla base di questa stagione della filologia si siano sviluppate in un’epoca in cui si faceva strada l’idea che la letteratura, in fondo, sia un gioco fine a se stesso, e che sia giusto così, perché la letteratura non serve a niente ed è bella proprio perché non serve a niente.
Invece bisognerebbe dire che se il testo, nella sua analisi profonda, non ci rimanda ad alcunché di emozionale, allora stiamo sbagliando prospettiva. Non ci stiamo mettendo la giusta dose di soggettività che contraddistingue la nostra disciplina: non ci stiamo mettendo i legami, non ci stiamo mettendo ciò che più contraddistingue l’umano, cioè il particolare, il transeunte, l’irripetibile. Se non ci mettiamo dentro noi stessi, l’opera rimarrà muta, una finestra su un cortile vuoto.
Leggi tutti i nostri articoli sulla letteratura
In copertina: Jean Honoré Fragonard, Giovane ragazza che legge, 1776