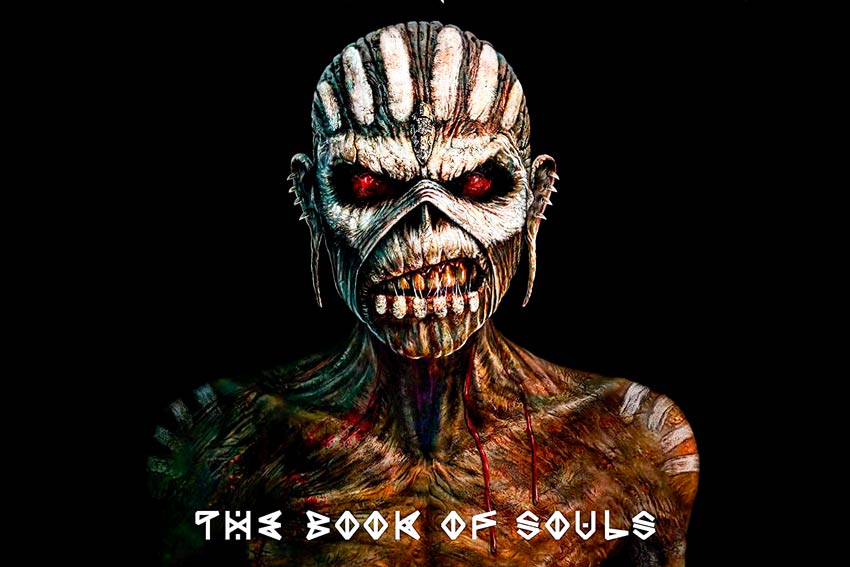Ci sono sempre più versioni di ogni storia che viene raccontata al sorgere del sole, dopo una notte di baldoria tra sigari, canzoni e qualche bicchiere di tequila. Soprattutto qui, nei bar di Plaza Garibaldi, a Città del Messico, un posto così ricco di tradizioni e leggende di origini sconosciute che molto spesso si intrecciano con la vita di alcune persone, che diventano leggenda anch’esse.
Chavela Vargas è stata una leggenda per gran parte della sua vita rara.
Perciò Chavela mi perdonerà se nel raccontare la sua storia mi prenderò qualche libertà, se darò più importanza ad alcune cose piuttosto che ad altre, se lascerò qualche pezzo per strada. Però chissà, potrebbe anche farle piacere.
Aveva 17 anni, Chavela, quando finalmente arrivò a Città del Messico, nel 1936. Scappava dalla sua famiglia, dai suoi genitori che, quando si separarono la abbandonarono da una zia, perché nessuno dei due la voleva. Scappava dalla poliomielite, oramai completamente regredita, che da bambina la “ruppe” rendendola quasi cieca, ma che riuscì a superare anche grazie all’aiuto di uno chamano che incontrò per caso, durante una delle sue primissime fughe da casa. Scappava da quel prete che le impedì di entrare in chiesa perché rara, strana. Perché amava arrampicarsi sugli alberi, indossare i pantaloni e legare i capelli in una grossa treccia e preferiva baciare le ragazze. Scappava dalla Costa Rica perché oramai le stava stretta, perché non era più la benvenuta.

Ma adesso finalmente era in Messico e la sua capitale era in piena rivoluzione artistica e culturale. Intellettuali di e da tutto il mondo venivano attirati in questa giovane metropoli in fermento, mentre nel resto del mondo si respirava aria di guerra. Per Chavela era un sogno. Come altre prima di lei si accorse che qui le donne non dovevano chiedere il permesso di essere libere. Qui si poteva pretendere e ottenere rispetto per quello che si faceva. Tutto era possibile e tutto era consentito. Chavela voleva vedere l’alba tutti i giorni, voleva bere fumare sigari, voleva divertirsi e sentirsi libera.
Soprattutto però, Chavela voleva cantare. E aveva una gran voce, Chavela.
I primi anni in Messico si trascinarono tra lavoretti improvvisati e nottate infinite, tra alcol e canzoni d’amore. Un giorno, però, un amico pittore o un’amica modella, secondo chi racconta la storia, le disse di una festa organizzata in quella casa dalle mura blu sempre frequentata da artisti e intellettuali. Chavela non conosceva nessuno, ma che importa. Non si rinuncia mai alla possibilità di fare baldoria e a della tequila gratis. Fu così che, mentre ballava davanti a un giradischi, con un sigaro in una mano e una bottiglia piena solo a metà nell’altra, la padrona di casa la notò.
Era una donna vestita con abiti tradizionali messicani, fiori nei capelli e delle sopracciglia pronte a spiccare il volo. Frida Kahlo le chiese di ballare. Chavela non tornò a casa quella notte, nemmeno in quelle successive. Sì fermò a Casa Azul per mesi. Era il 1939. Frida stava divorziando da Diego Rivera dopo averlo trovato a letto con la sua amata sorella. Si risposarono l’anno successivo perché, nonostante scappatelle e tradimenti di entrambi non potevano vivere l’uno senza l’altra. Chavela entrò nella vita di Frida come in tutte le storie che si rispettano: al momento giusto. Furono mesi di passione travolgente e intesa perfetta, fino al giorno in cui senza preavviso Chavela prese Frida da parte e le disse «Non posso fermarmi più, devo andare». E Frida forse rimase ferita, ma la lasciò andare.

È a questo periodo in cui Chavela visse a Casa Azul che risale la mia foto preferita di lei, una di quelle che amo più in assoluto. Chavela e Frida sono sdraiate sul prato, Chavela in abiti maschili, con la chitarra al fianco, la sigaretta tra le dita di una mano. Si riesce quasi a sentire l’eco della sua risata. Con l’altra mano sfiora il seno di Frida, che si nasconde le labbra con le mani, in un sorriso quasi imbarazzato. La composizione perfetta, la gioia e la spontaneità che riesce a trasmettermi questa foto ogni volta che mi capita sotto lo sguardo mi emoziona sempre. La trovo perfetta. Leggenda vuole (e a me piace pensare che sia così) che a scattare questa foto sia stata un’altra donzella dalla vita incredibile e dal grande talento, arrivata da molto lontano: Tina Modotti. «Che trio. Che artiste. Che Messico!» mi hanno scritto di recente. Non avrei saputo dirlo meglio. Ma questa è un’altra storia.
Nel frattempo arrivarono i primi ingaggi nelle cantine, nei locali vicino a Plaza Garibaldi.
Le prime volte provò anche a seguire le regole, esibendosi in abiti femminili, indossando fiocchi e tacchi alti e a cantare le vivaci melodie della musica rancheras. Non funzionò, non si sentiva a proprio agio. Come darle torto. Come si fa a cantare con un abito che quando alzava le braccia nel mezzo della canzone mostrava tutto quello che c’era sotto? O a salire sul palco con quei maledetti tacchi che rischiavano sempre di farla cadere, davanti a tutti?
Un giorno, senza dire niente a nessuno, si presentò sul palco con i capelli legati in una treccia strettissima e il suo amato completo da mariachi sotto al poncho rosso che sarebbe diventato il suo marchio di fabbrica. Prese la chitarra, se l’appoggiò al petto e cominciò a percuoterla. Cominciò a cantare, lentamente, con serietà, con la sua voce profonda ammorbidita dalla tequila.
«Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí…»
Il pubblico ne rimase stregato. Chi è questa donna sul palco che si veste come un uomo, che canta come un uomo? Chi è questa donna che stravolge il significato di una canzone che racconta la storia di una donna simbolo di libertà, facendola diventare ambigua, erotica? Chi è questa donna con il poncho rosso? Chi è questa Chavela Vargas?
«Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí…»
Sul palco tornò moltissime volte, ma mai più con l’abito elegante e i tacchi.
Fu in questo periodo che incontrò José Alfredo Jiménez, già affermato musicista e compositore di ballate rancheras. Su questo incontro fioccano aneddoti. José Alfredo le offrì un passaggio con la macchina mentre si dirigeva ad un locale dove avrebbe dovuto suonare. Volentieri – ripose Chavela – Guido io, però. Chavela che approfittando dei suoi abiti da mariachi per confondersi con i musicisti di José Alfredo per entrare ad una festa riservatissima a cui partecipava niente meno che Pedro Infante, uno dei cantanti messicani più famosi e ammirati e amico di José Alfredo. Più realisticamente José Alfredo andò ad ascoltarla su consiglio della moglie. Ben presto nacque un’amicizia destinata a cambiare la storia della musica messicana. Era il 1948.
I testi di José Alfredo Jiménez erano scritti e pensati per essere cantati da uomini in pena da “amores y desamores”. Chavela, con il suo vestirsi da uomo, con il suo cantare senza mai cambiare pronomi, con il suo essere lesbica senza nasconderlo, senza mai nemmeno sbandierarlo prese questi testi, legati a una tradizione machista e li rese universali. Perché non c’è nulla di più universale dell’amore perduto e tradito, della nostalgia, della solitudine, il senso di vuoto e del dolore causato dall’assenza. Insieme spogliarono la musica rancheras di tutto ciò che era superfluo. La liberò dagli stereotipi folkloristici e festaioli, rivestendola di melodramma, della disperazione che segue le sbronze. A Chavela bastavano un paio di chitarre e la sua voce. Non si balla più. Ora si ascolta.
Erano una coppia amata e temuta da tutti i locali di città del Messico. José con i suoi occhi azzurri di ghiaccio e la chitarra e Chavela con un sigaro veracruzano in mano e con l’immancabile poncho rosso che nascondeva la sua pistola. Arrivavano la sera, bevevano, facevano concerti memorabili e poi riprendevano a bere, fino a svuotare la cantina. Poi recuperavano la chitarra e aspettavano l’alba cantando serenate sotto le finestre delle ragazze. E il giorno dopo tutto ricominciava. A 83 anni Chavela si sarebbe divertita a calcolare quanta tequila bevvero in quegli anni. 45’000 litri. Per forza al giorno d’oggi la tequila non è più la stessa, scherzava. Quella buona ce la siamo bevuta tutta io e José Alfredo!
Con grande sollievo di tutti i proprietari dei locali di città del Messico Chavela cominciò ad esibirsi nei teatri, dove continuò la sua vita sregolata tra alcol, donne e musica. La fama di quella donna dal poncho rosso superò i confini nazionali e arrivò ad Hollywood. Elizabeth Taylor, Clark Gable, Lana Turner. Scendevano fino ad Acapulco dove potevano passeggiare per la spiaggia senza essere fermati e passare le serate ad ascoltare la calda voce di Chavela Vargas. Anche lei fu invitata al primo leggendario matrimonio tra Elizabeth Taylor eRichard Burton. Il quella notte si narra che tutta Hollywood andò a letto con qualcuno. Il mattino dopo, al suo fianco, c’era nientemeno che Ava Gardner, che aveva un debole per lei da un po’. La grande festa finì nel 1973, con la morte di José Alfredo Jiménez, consumato dalla cirrosi epatica dovuta all’alcolismo.
Morì alla mattina. Chavela si presentò a casa sua la notte, in lacrime, con una bottiglia in mano. Si avvicinò alla tomba, si sedette e cominciò a cantare. A bere e a cantare, come ai vecchi tempi. «Bevi con me da questa bottiglia ce ne andremo dopo l’ultimo sorso. Devo sapere che sapore ha l’oblio in cui ti trovi, senza porre le mani sui tuoi occhi. Non voglio implorarti questa notte, perché questa notte te ne stai andando per davvero. È così difficile lasciarti andare, senza sapere che mi ami ancora. Non mi hanno insegnato nulla gli anni, perché ancora cado nello stesso errore. Tornerò a brindare con sconosciuti, piangendo per lo stesso dolore».
Il dolore, l’alcol, la solitudine la stavano consumando. Nel 1979 si ritirò dalle scene. Per 12 anni non diede più sue notizie. Qualcuno la vide mentre beveva birra seduta per terra con dei muratori in pausa pranzo, qualcun altro mentre insegnava ad un ragazzino a sparare ai ragni con un fucile. Pensarono tutti che fosse morta.
A El Habito, un piccolo locale di Città del Messico appena aperto e gestito da due ragazze, una serata del 1991 cominciò a correre una voce. Ma è Chavela quella! No, non è possibile, Chavela Vargas è morta anni fa. No è proprio lei ti dico. Dai Chavela, sali sul palco cantaci qualcosa! Sì, era proprio lei, Chavela Vargas, tornata dal mondo dei morti, venuta per ascoltare un po’ di musica. Com’era diversa però questa Chavela. I capelli quasi completamente bianchi, una ragnatela di rughe in faccia e il sorriso beffardo di sa di aver attraversato l’inferno ma di aver finalmente trovato la serenità. Solo il poncho rosso non era cambiato. Durante l’ultimo periodo del suo isolamento volontario aveva trovato rifugio in una comunità di chamani ed era diventata una di loro. Non toccava alcol da allora. Ma erano 12 anni che non cantava più.
Dai Chavela, canta qualcosa.
No. Il palco la terrorizzava, e poi non aveva mai cantato sobria. Ponme la mano aquí, Macorina. Ti ricordi Chavela? Sì, si ricordava bene. Si ricordava del pubblico che pendeva dalle sue labbra quando cantava, della tensione che creava con i silenzi. Si ricordava del modo in cui la voce quasi si rompeva a metà delle note lunghe, come un lamento. E della pace che trovava quando cantava. È difficile dimenticare queste.
Perciò salì sul palco, abbracciò la chitarra, cominciò a percuoterla.
«Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí».
Fu la rinascita. Riprese a fare concerti tutte le settimane, sempre a El Habito. In tutto il mondo si sparse la voce del ritorno di Chavela Vargas. Tutti volevano ancora sentir cantare quella chamana con l’abito da mariachi sotto al poncho rosso. Perché quando cantava sembrava cantare solamente per te. Hai mai commesso errori nella tua vita, nelle tue storie d’amore? Sembrava chiederti. I tuoi errori sono un bene, ne valgono sempre la pena. Sono la cosa più importante che ti sia capitato. Fanne ancora se puoi. Anche io ne ho commessi tanti. E siamo qui entrambi.
Almodovar volle conoscerla per farla cantare per i suoi film. Kika. Il fiore del mio segreto. La portò a Madrid e a Parigi. Chavela cantò nuovamente nei teatri.
E cantò ancora e ancora.
Nel 2003 interpretò la canzone che la rese famosa in tutto il mondo, una delle canzoni più conosciute e riconoscibile della tradizione messicana, La Llorona. La Llorona è lo spirito di una donna che piange la morte dei suoi figli. Nell’iconografia sudamericana rappresenta la morte. Lei che era stata creduta morta in vita ed era tornata. La cantò nel film sulla vita di Frida Kahlo. La vita a volte ha modi curiosi di incastrare tutti i pezzi.
Nel 2012, a 93 anni pubblicò il suo ultimo disco, quello dedicato a Federico Garcia Lorca, il poeta che adorava, morto troppo giovane durante la guerra civile spagnola.
Si ammalò gravemente pochi giorni prima del concerto di presentazione a Madrid. Non sembrava essere in grado di cantare. Lei volle provarci lo stesso. Cantò con un filo di voce. Sapevano tutti sarebbe stato il concerto di addio di Chavela Vargas. Lo sapeva il pubblico, lo sapeva lei.
Se quella sera non morì sul palco come avrebbe voluto forse è solo perché questa storia non è ancora stata raccontata abbastanza. O forse perché la Llorona in persona aveva deciso che Chavela sarebbe dovuta morire in Messico, nel suo Paese. Chissà.
Morì nella sua casa tra le montagne di Cuernavaca che l’avevano ospitata negli ultimi anni e che tanto aveva amato. Era il 5 agosto.
Il giorno del funerale i mariachi scesero si riunirono in Plaza Garibaldi per rendere omaggio cantando a quella bara coperta da un poncho rosso. Furono lacrime e festa, come nella migliore tradizione messicana. Tutti l’avevano ormai riconosciuta come uno di simboli della cultura messicana. Perché sì, lei era messicana, come amava ripetere. E se qualcuno le faceva notare che era nata in Costa Rica rispondeva «Noi messicani nasciamo dove cazzo ci pare».