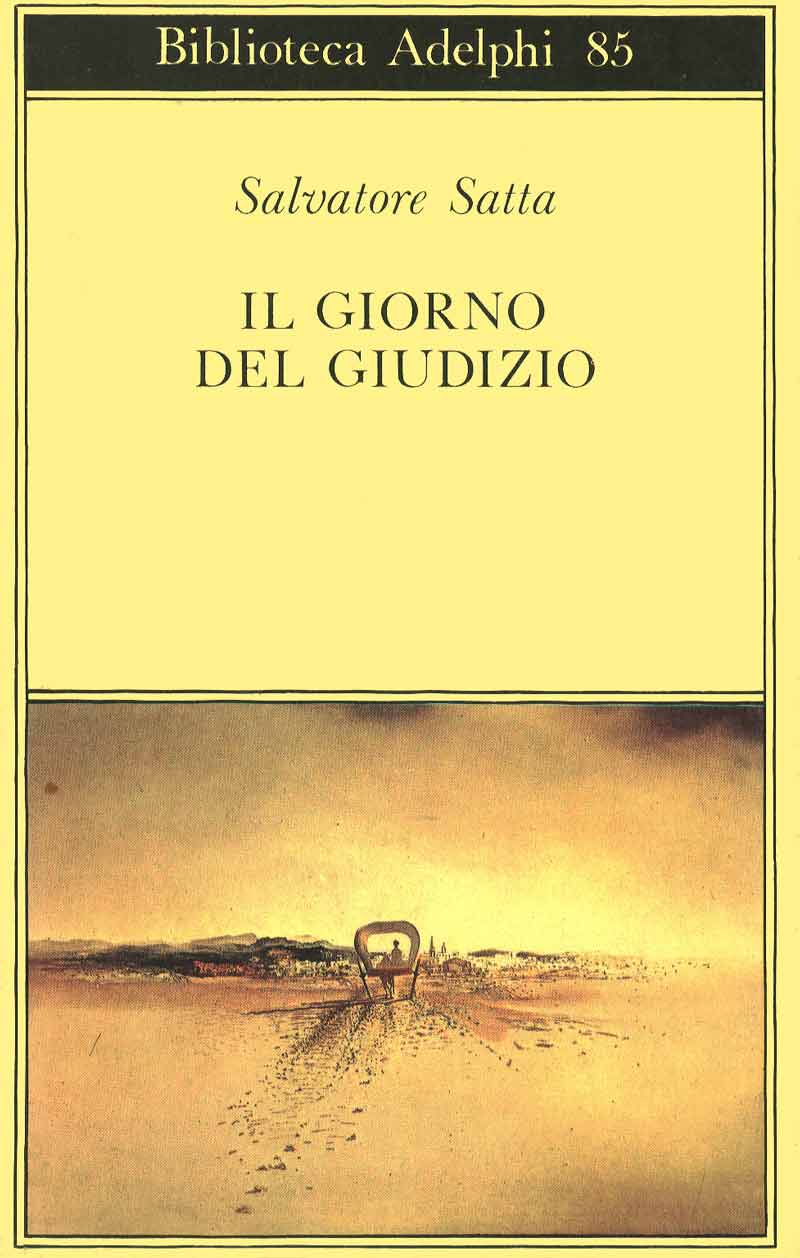Riprendo, dopo molti mesi, questo racconto che forse non avrei dovuto cominciare. Invecchio rapidamente e sento che mi preparo una triste fine, poiché non ho voluto accettare la prima condizione di una buona morte, che è l’oblio. Forse non erano Don Sebastiano, Donna Vincenza, Gonaria, Pedduzza, Giggia, Baliodda, Dirripezza, tutti gli altri che mi hanno scongiurato di liberarli dalla loro vita; sono io che li ho evocati per liberarmi dalla mia senza misurare il rischio al quale mi esponevo, di rendermi eterno.
(Salvatore Satta, Il giorno del giudizio, Milano Adelphi 1979 pag. 291)
Se vogliamo tentare di capire la scrittura di Salvatore Satta occorre, per forza, passare attraverso queste parole, consegnate ai posteri nell’explicit della sua opera letteraria (postuma) più celebre: Il giorno del giudizio. Il libro è diviso in due parti, la seconda delle quali è composta da poche righe. Il brano è tratto proprio da questa seconda parte, e si presenta come una confessione in extremis; l’autore sa che gli resta ormai poco tempo da vivere e chiude (come può? come avrebbe voluto?) l’opera a cui stava lavorando da qualche anno.
Appare chiaro che ci troviamo di fronte a una riflessione metaletteraria. I due enunciati che più colpiscono sono infatti due: l’unica buona morte coincide con l’oblio mentre la narrazione conduce all’eternità. Sono, come è evidente, due situazioni conflittuali, due modi diametralmente opposti di concepire la vita e il racconto di essa. Nello scrittore nuorese queste due forze convivono e si scontrano, e contribuiscono a dare quel fascino un po’ sinistro che caratterizza il romanzo.
Salvatore Satta è giurista di formazione e di professione, nella sua lunga carriera di professore universitario ha l’occasione di spostarsi molto (Genova, Trieste, Roma) e di farsi apprezzare quale fine conoscitore di diritto, ma anche in qualità di saggista e redattore. Attorno al 1971, all’età di 69 anni, inizia la stesura delle memorie della sua infanzia e dei personaggi che la popolarono. Da alcune lettere inviate all’amico Bernardo Albanese e dalla stessa struttura del testo si evince che Satta non avesse nessuna velleità letteraria ma fosse ossessionato dalla necessità ineluttabile del racconto.

Secondo le sue stesse affermazioni infatti la narrazione del tempo perduto ha uno scopo specifico: liberare i personaggi della vecchia Nuoro dalla loro stessa vita, atteggiarsi a giudice supremo e giudicarli. Soltanto così essi potranno morire davvero e in pace. Il guaio è che l’autore si rende conto, nell’atto stesso del narrare, che così facendo egli non solo sottrae dalla dimenticanza gli attori del suo passato ma la medesima operazione si riflette su se stesso. È, evidentemente, un circolo vizioso e da questo nodo inestricabile scaturisce la bellezza del romanzo, ma anche la sua tragicità.
I protagonisti de Il giorno del giudizio sono i familiari di Satta, la madre il padre e i suoi sei fratelli, ma a popolare e a vivificare il racconto ci sono anche i maestri di scuola, i matti del paese, i preti e i canonici, i signori del Caffè Tettamanzi, i pastori e i contadini di Nuoro. Sicché il romanzo è sì un romanzo familiare, ma è anche il grande affresco della cittadina sarda e della Sardegna tutta, immortalata in un’istantanea di inizio secolo e quindi prima delle due grandi guerre che catapultarono l’isola nella modernità.
Lo sguardo del narratore si muove talvolta in modo sicuro e netto come quello di un Dio cinico e distaccato, altre volte procede a tentoni seguendo l’ispirazione del momento, lasciando la vicenda narrata a metà per inseguire altri ragionamenti, per poi riprenderla qualche capitolo dopo. Anche in questo caso sono due atteggiamenti di natura opposta a muoversi nell’animo di chi scrive, da una parte la sicurezza del narratore onnisciente tipica dell’Ottocento (Satta è lettore accanito di Manzoni), dall’altra l’incertezza e quasi l’impossibilità di dare al racconto una struttura e una logica interne, che caratterizza la letteratura dei primi anni del Novecento (egli legge e apprezza Pirandello).
Abbiamo dunque visto come la vicenda umana e quella letteraria in Satta non presentino praticamente nessuna soluzione di continuità, sono come due facce della stessa medaglia e rivestono entrambe un’importanza capitale. A questo proposito varrà la pena accennare brevemente alla produzione giuridica del professore sardo, ché ci aiuterà a capire alcune cose. Ne Il mistero del processo egli critica il processo rivoluzionario scaturito in Francia dopo il 1789 (e con esso ogni processo rivoluzionario), mettendo in luce la sua contraddittorietà.
Il vizio di forma di tale processo sarebbe la cieca volontà di punire in modo da rovesciare la formula nulla poena sine judicio in nullum judicium sine poena, svuotando così di significato lo scopo stesso del processo. Ma, appunto, qual è lo scopo del processo? Per Satta non è la pena ma il giudizio. Quest’ultimo però non è un atto esterno al processo, ma interno, così che esso si ritrova ad avere il suo scopo in se stesso, ‹‹il che equivale a dire che non ne ha alcuno[1]››.
Certo, la materia è complessa ma a noi basterà solamente fare qualche considerazione per quello che qui ci interessa. Se pensiamo al processo come all’analisi di fatti succedutisi nel tempo, con tanto di convocazione di testimoni, possiamo facilmente accostarlo, per metafora, alla narrazione della vita. Abbiamo infatti vari personaggi (i testimoni) che interpretano un ruolo, vari punti di vista su uno stesso fatto, e abbiamo ovviamente un giudice (il narratore), il cui scopo è appunto quello di giudicare. Appare dunque chiaro come il tema della narrazione sia strettamente collegato alle speculazioni filosofiche di Satta saggista, il quale ci offre così la possibilità di capire nel profondo quali sentimenti stiano alla base della scrittura stessa. Affermare che il processo non ha scopo alcuno dunque, è come dire che è la vita stessa a non avere un significato.
Ma allora perché raccontare? Per Salvatore Satta, uomo estremamente colto e curioso, raccontare equivale a conoscere se stessi e gli altri e ‹‹per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare perché ormai non si tratta dell’altrui destino ma del mio[2]››.
Ed ecco qua dunque il drammatico paradosso. Satta è profondamente convinto che il modo migliore per abbandonare questo mondo sia il silenzio, andarsene in punta di piedi senza fare rumore. Ma con l’appressarsi della malattia e della morte la necessità di raccontare si fa prepotente, perché ‹‹non si può annullare il proprio essere nati. Per questo dico io che Pietro Catte, come tutti i miseri personaggi di questo racconto, è importante e deve interessare tutti: se egli non esiste nessuno di noi esiste[3]››. Ossessionato dal dovere di narrare, Satta inizia così una personale discesa negli inferi che lo porta sì a liberare tutti i suoi personaggi dalla loro vita, ma che lo condurrà in ultima analisi alla negazione del suo unico desiderio: cadere nell’oblio.
Leggi tutti i nostri articoli sulla letteratura
In copertina: Salvador Dalì, Mostro molle in un paesaggio angelico, 1977