Lettrici, lettori, amici e amiche e tutt* quant* (con e senza asterischi come vi pare): questo sarà un articolo un po’ diverso.
Perché? Perché, per una volta, parla di noi.
Siamo appena entrati nel 2022 e il nostro blog compie otto anni. Un’età discreta, insomma. Ne abbiamo fatte di cose in questo tempo: abbiamo pubblicato ben seicento articoli, ci siamo fatti conoscere da davvero tante e tante persone (più di quante ci aspettassimo!). Vi abbiamo ringraziato poco, però, (e ne approfittiamo adesso) e abbiamo parlato poco di noi, del nostro progetto. Sì, siamo un po’ schivi e vergognosi, scusateci. Non riusciamo molto a parlare di noi stessi, né ad avere un rapporto diretto e schietto con chi ci legge. Siamo un po’ all’antica… del resto tra noi c’è chi ama la musica barocca.
Otto anni, però, sono parecchi. E ne abbiamo viste tante. Pure un vero e proprio cambiamento storico, con l’inizio di questa pandemia. E poi abbiamo visto modi di raccontare l’arte e la letteratura sempre più nuovi e diversi. Anche noi siamo cambiati: eravamo un piccolo gruppo di studenti di Pavia, nati da una pagina di Google Plus (sì, esisteva un social che si chiamava Google Plus. Riposa in pace, piccolo. Che il cimitero di internet ti sia lieve) e adesso siamo una realtà (dis)organizzata in diverse città, da Milano a Roma, in Piemonte e fino alle sperdute montagne d’Abruzzo. È così che ci siamo resi conto che era necessario un cambio di passo: dovevamo capire quale fosse il nostro modo di scrivere, con quali intenti, con quale scopo lo facevamo.
È per questo che, per farla breve, abbiamo deciso di cambiare nome. Non troppo, però. Troppo non eravamo pronti. Abbiamo optato per un cambiamento lieve. Storie Sepolte.
Perché Storie Sepolte?
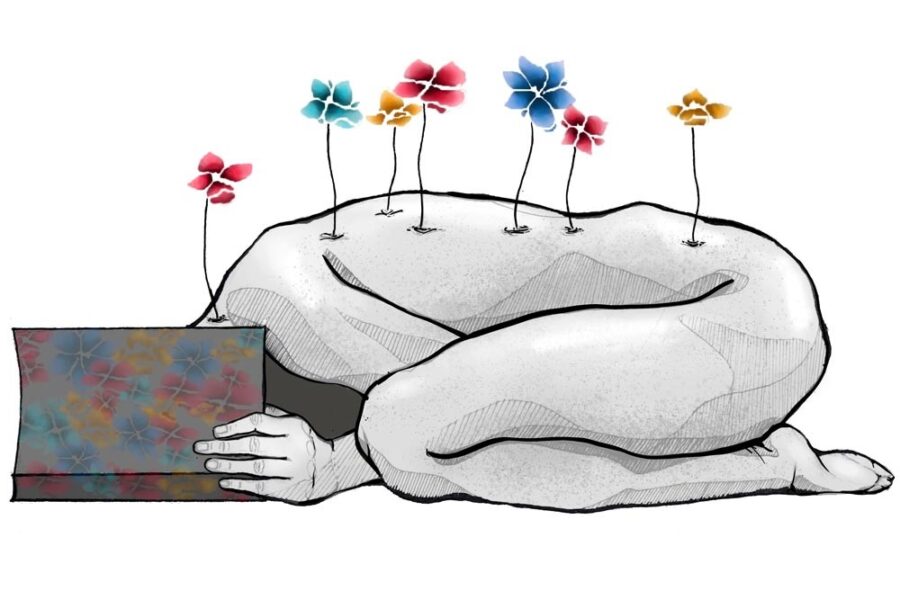
Storie, intanto, perché ci viviamo dentro. Siamo immersi nelle storie. La narratività è una dimensione fondante per l’essere umano: è il modo che abbiamo per rapportarci con il tempo. Tutto ciò che facciamo è mediato dalla narrazione. Ma, purtroppo, questa è una verità fin troppo nota, e come tutte le verità note, è stata usata e abusata fino a renderla banale: è il cosiddetto storytelling, che viene insegnato in tutte le accademie di scrittura, in tutti i corsi di copywriting, in tutte le scuole di scrittura creativa. Dalla pubblicità ai social (non a caso quelle che si fanno su Instagram vengono definite “storie”) tutto è diventato una storia, un raccontino minimo della propria esistenza. Che serva a vendere un’automobile o una stilografica, la narrativa è diventata una tecnica, un espediente quasi irrinunciabile.
Da realtà fondante per gli umani, è diventata un mezzuccio, così usato che oggi sta incominciando a stancare. Per fortuna, perché così possiamo riprendercela, e usarla in modo diverso. Un modo che non leda l’autenticità del mondo narrativo, ma anzi sia al suo servizio.
In fin dei conti, quello che abbiamo sempre fatto è raccontare, anche se non nel modo dei romanzieri, ma al modo nostro, di giornalisti culturali. Il nostro obiettivo, coi nostri articoli, non è tanto convincere, o argomentare una posizione, quanto portare alla luce un’opera o un autore meno conosciuto, oppure un punto di vista diverso su opere celebri e importanti. Ogni tanto scriviamo anche della nostra visione del mondo, ma, nel complesso del nostro lavoro, è la storia di qualcosa o qualcuno ad attrarci, e a muovere le nostre mani e le nostre tastiere.
E perché sepolte?
Ok… qui ci vuole un po’ più di calma. Portate pazienza.
Spiegone time
Viviamo in un mondo complicato, in cui si produce tantissima arte ma questa sembra rimanere ai margini della società. Ricordate Quarto Potere, il film di Orson Welles? (Se non ve lo ricordate, ricordatevi di guardarlo. Sarà banale dirlo, ma rimane il film dei film). Ordunque, la nostra realtà culturale assomiglia alla villa del Citizen Kane, il protagonista di Quarto Potere: un’enorme villa ricolma di opere, statue, oggetti, beni di ogni tipo, forma, valore, che si accumulano uno su l’altro, seppellendosi a vicenda. Un’immensa, gigantesca babele di oggetti, così tanti che nemmeno Kane può ricordarseli tutti, e di cui, in fin dei conti, non sa che farsene. Li accumula per puro desiderio di possesso, e non vi è altro motivo. Cosa cerchi esattamente attraverso tutti quei beni, non lo sa nemmeno lui.
È lo stesso nel nostro mondo: storie che si accumulano su altre storie, che si intrecciano, oggetti che si sommano ad altri oggetti, fino a creare un’immensa, gigantesca megalopoli di cui si fatica a trovare il senso. La produzione di opere d’arte non è mai stata così sterminata, e nello stesso tempo le arti non sembrano ricoprire un ruolo centrale nella vita di nessuno di noi. Non c’è né un riconoscimento professionale da parte degli artisti, e nemmeno un riconoscimento a livello culturale.
Ciò si lega alla decadenza della cosiddetta cultura umanistica, che sta venendo sempre più messa da parte: è decennale il dibattito sullo studio del latino; sempre più spesso politici e accademici si pronunciano sull’inutilità dello studio della storia o della letteratura, ed elogiano il sapere tecnico e il sapere scientifico, come se fosse realmente possibile separare questi ambiti. Come se il sapere tecnico non ponga domande umane, esistenziali (bioetica, you know?), o come se il sapere scientifico non abbisogni di un impianto filosofico, e non si nutra di domande filosofiche. È, detto tra parentesi, anche il frutto di un pensiero che da sempre separa esseri umani e natura: da una parte il sapere sull’uomo, e dall’altra quello sul resto del mondo. Ma se andiamo ad aprire un libro di storia dell’arte cinese, gli esseri umani vi compaiono di sfuggita, e invece saperi considerati “non umanistici”, come l’economia, la giurisprudenza, la medicina, si occupano quasi esclusivamente dell’uomo.
Se il mondo del sapere è strutturato in questo modo, non c’è da stupirsi che tutto ciò che funziona, che è immediatamente utile, che è spendibile nella società debba essere potenziato e accresciuto, e ciò che invece trova pochi ambiti di applicazione debba essere scartato. Ed è precisamente il caso della storia, della filosofia, della storia dell’arte e della letteratura: cioè di tutta la cultura tradizionalemnte definita “umanistica”, che si trova ad essere la più sepolta delle culture, la più bistrattata. È un non-sapere, un sapere che si studia più per amor di tradizione che non per necessità.
L’arte sembra apparentemente salvarsi, visto che se ne produce molta, ma è solo apparenza: sì, si continuano a produrre libri dischi, libri, film… ma ciò che conta è il loro essere “prodotto”, oggetto. Qualcosa di fisico che si può comprare e che si può vendere. È questa caratteristica (più difficile in un’opera filosofica, o in una ricerca storica o antropologica) che permette una rapida e ampia diffusione dell’arte, ma nello stesso tempo è ciò che la incatena. Sì, si comprano tante opere d’arte, ma si consumano. Tanto è viva produzione di opere d’arte, quanto è in crisi la riflessione sull’arte. Ciò che conta è consumare, ingurgitare: il resto è superlfuo.

In effetti, domande come «Quante serie di Netflix verranno ricordate tra cent’anni?»; «Cosa vuol dire creare un’opera d’arte?», o «Cos’è l’arte?» possono sembrare senza scopo, e ormai tanti critici e accademici le hanno abbandonate, trincerandosi dietro frasi come «Arte è tutto ciò che chiamiamo arte», o cercando di evidenziare come questi problemi siano sempre esistiti, come vi sia sempre stato un mercato dell’arte; come l’arte non abbia mai avuto una e una sola funzione, e così via.
Oggi, infatti, l’arte ricopre una funzione per lo più decorativa della nostra vita. È un accessorio che la rende migliore, ma che potrebbe non esserci. Serve a divertirci, a farci passare il tempo. A “intrattenerci”, come si dice. Venuto meno, infatti, l’uso propagandistico da parte di un potere centrale come poteva essere un re, un mecenate, un grande principe, e venuto meno, per via dello sviluppo scientifico, anche tutto l’aspetto cultuale-sacrale-religioso dell’arte, quale altra funzione può ricoprire? In effetti, non c’è nulla di male in un passatempo, o nell’intrattenimento in sé. Ognuno di legge, scrive, guarda un film per divertirsi, per distrarsi: questo è sano e umanissimo. Però.
Però, oggi, in un’epoca di profondissima crisi, rischiamo che un’idea forte di arte, di arte come atto culturale, vada a perdersi.
Cosa vuol dire atto culturale? Cosa vuol dire fare un uso culturale dell’arte? Vuol dire che l’arte può servire a definire la forma della vita di una determinata società, di un determinato popolo, i suoi pensieri, le sue credenze, la sua mentalità. Se l’arte è un appagamento, diviene un modo con cui fuggire dalla propria vita, un breve sogno per poi tornare nel grigio della propria esistenza quotidiana. Una pausa, un momento di ricarica tra una giornata di lavoro e l’altra.
All’appassionato di letteratura nulla di più è richiesto, né all’artista. Non è strettamente necessario né un pensiero critico sulla realtà, né sulla propria esistenza o sui sentimenti. Un artista che si limiti a ricoprire questo ruolo non metterà mai in discussione il mondo, non desidererà mai cambiarlo, migliorarlo, farlo vivere. Si limiterà a fare ciò che gli è stato richiesto, come un buon soldato. È anche per questo che la cultura umanistica è in crisi, in favore di un sapere tecnico: ciò che importa maggiormente, infatti, è l’adempimento di una mansione. Anche scrivere un libro o una serie tv diventa un compito tecnico: l’importante è creare storie efficaci, che piacciano.

Ma così l’arte non è più il territorio dell’ignoto, non è più l’oltrepassare il confine del conosciuto, del rassicurante, per cercare qualcosa di più, qualcosa che ancora non sapevamo di noi stessi e della realtà. Un viaggio, un’esperenza che ci renda persone diverse, in modo da riorientare il nostro sguardo. È questo che rischiamo di perderci: un grande, insostituibile strumento per trasformare la nostra vita.
Un’opera fatta solo per essere comprata e venduta, una pura merce, non ci permette questa trasformazione interiore. O meglio, se lo farà, lo farà per caso, per effetto collaterale. Ci sono grandi opere create per fini commerciali, ma sono grandi nonostante i fini commerciali, e non per via di questi.
Inoltre, se chi ama l’arte pensa solo a consumarla, e non ne fa un uso culturale, la cultura, in sé, non sparisce. La società continuerà ad avere una determinata forma, determinate credenze, determinati pensieri. Semplicemente, saranno altre entità a determinarli: sarà il mondo della televisione, sarà la comunicazione mordi e fuggi dei social, saranno le pubblicità delle grandi aziende a riorientare il nostro sguardo, a farci crescere come persone.
Ok, d’accordo, siamo un po’ all’antica (lullisti e barocchisti) ma non vogliamo fare moralsmi: semplicemente, pensiamo che una società, per crescere, abbia bisogno di atti disinteressati. Atti che, se la società è interamente orientata al guadagno personale, al successo, all’accrescimento di pubblico e di audience, diventano sempre più rari. L’arte, in quanto realtà a mezzo tra il prodotto e l’escrescenza, tra il flusso spontaneo e la ricerca razionale, è uno di quegli atti disinteressati che andrebbero protetti e amati.
Siamo fatti di ciò che incontriamo ogni giorno, e quindi anche di ciò che leggiamo, guardiamo, esploriamo: è importante curarne la dieta, sceglierle con cura, e farlo secondo un fine che non può essere solo ricaricarsi per poter affrontare il giorno successivo. Un’opera d’arte dovrebbe aprire mondi, descrivere realtà nuove e diverse, che ci facciano sì sognare ma che ci consentano poi di vivere al meglio, in modo pieno, la nostra vita.
È per questo che il nostro desiderio è portare avanti una riflessione sull’arte in tutte le sue forme. Una discussione che vada al di là delle polemiche tra fan e haters, delle polemiche tra tifoserie contrapposte e che si concentri sul senso ultimo di tutto ciò.
E quindi, eccoci qua

Queste sono le idee che hanno sempre guidato la nostra attività in questi otto anni, ma era necessario secondo noi dircele in modo esplicito, prima a noi stessi e poi anche a voi. Ne abbiamo scritto anche in quello che è diventato il nostro manifesto.
È così che l’idea che ci animava è diventata mano mano sempre più definita, sempre più precisa. Un blog che sia però un magazine multimediale, con podcast, video, e che abbia una sua forma cartacea. Un blog che affronti tutte le arti, l’arte nel suo complesso, senza fare distinzioni tra cultura “alta” e cultura “bassa”, ma valutando solo la qualità delle opere, il loro essere riuscite o meno; un blog che parli in modo semplice ma cerchi di valorizzare la singola voce di ogni redattore, e porti mescolanza tra contenuti più specialistici e altri invece più pop e mainstream. E anche un blog che non sia fatto esclusivamente da esperti, da insegnanti o ricercatori, ma da chiunque abbia passione per gli argomenti di cui parliamo. Un blog che sia anche, in un certo senso, una piccola palestra, una scuola in cui ognuno di noi possa migliorare. Un progetto per appassionati realizzato da appassionati, che parli il più possibile a tutti e tutte.
Gli aficionados dei nostri articoli sepolti avranno notato che, oltre a cambiare nome, l’anno passato abbiamo cambiato (più volte) veste grafica. (Sì non eravamo mai contenti… siamo indecisi di natura). L’ultimo logo aggiudicatosi il nostro apprezzamento, e dunque quello definitivo, è in realtà un mon, altrimenti detto kamon, e cioè uno stemma giapponese. I kamon erano infatti i simboli araldici delle famiglie nobiliari nipponiche… eh… come? No, il feudalesimo non è esattamente la soluzione alla mercificazione dell’arte… sì, ok, è un simbolo nobiliare ma non l’abbiamo scelto per quello. Anzi, il kamon non è strettamente legato alla nobiltà di sangue. L’abbiamo scelto perché il Giappone è figo per noi è fondamentale uscire dall’Europa: raccontare la letteratura araba, la musica sudamericana, le arti dell’estremo oriente. Raccontare ciò che è lontano è un modo per individuare idee di arte nuove, provare a metterle in relazione, trovare nuove storie, nuovi artisti emergenti o sepolti, aggiungere linfa a una cultura italiana ancora provinciale e asfittica.
Come in ogni logo che si rispetti, tutti i dettagli hanno un significato: il fiore di loto rappresenta la rinascita, mentre nella griglia di linee che vi sta al disopra si nascondono i caratteri (katakana, per la precisione) giapponesi che formano la parola “Storie”.
Ma c’è un’ultima cosa che ci sta a cuore. L’intreccio a griglia delle linee ci ricorda l’intreccio delle travi delle case tradizionali giapponesi, con le loro pareti in carta di riso. Quella giapponese era una casa particolarissima, di cui oggi sopravvivono poche tracce. Non erano case luminose, né ricche, ma dalla loro spoglia essenzialità emanava calore e affetto. Erano case dalle stanze mobili, che potevano essere riorganizzate e le cui pareti si aprivano e si chiudevano a piacimento, ridefinendo ogni volta gli spazi.
Ed è quello che, in fondo, ci piacerebbe fosse questo blog: una realtà che muti con il cambiare dei tempi, che lavori su nuovi spazi e nuove fondamenta. Alla villa immensa, caotica e granitica del cittadino Kane noi preferiamo la casa dalle pareti in carta di riso; all’accumulo senza fine, un’armoniosa scelta di forme, di colori; al grande palazzo di pietra, preferiamo il focolare. Una realtà intima e agile, che possa riorientare nel tempo il suo sguardo.
In copertina: Illustrazione di Miriam Spadafora










