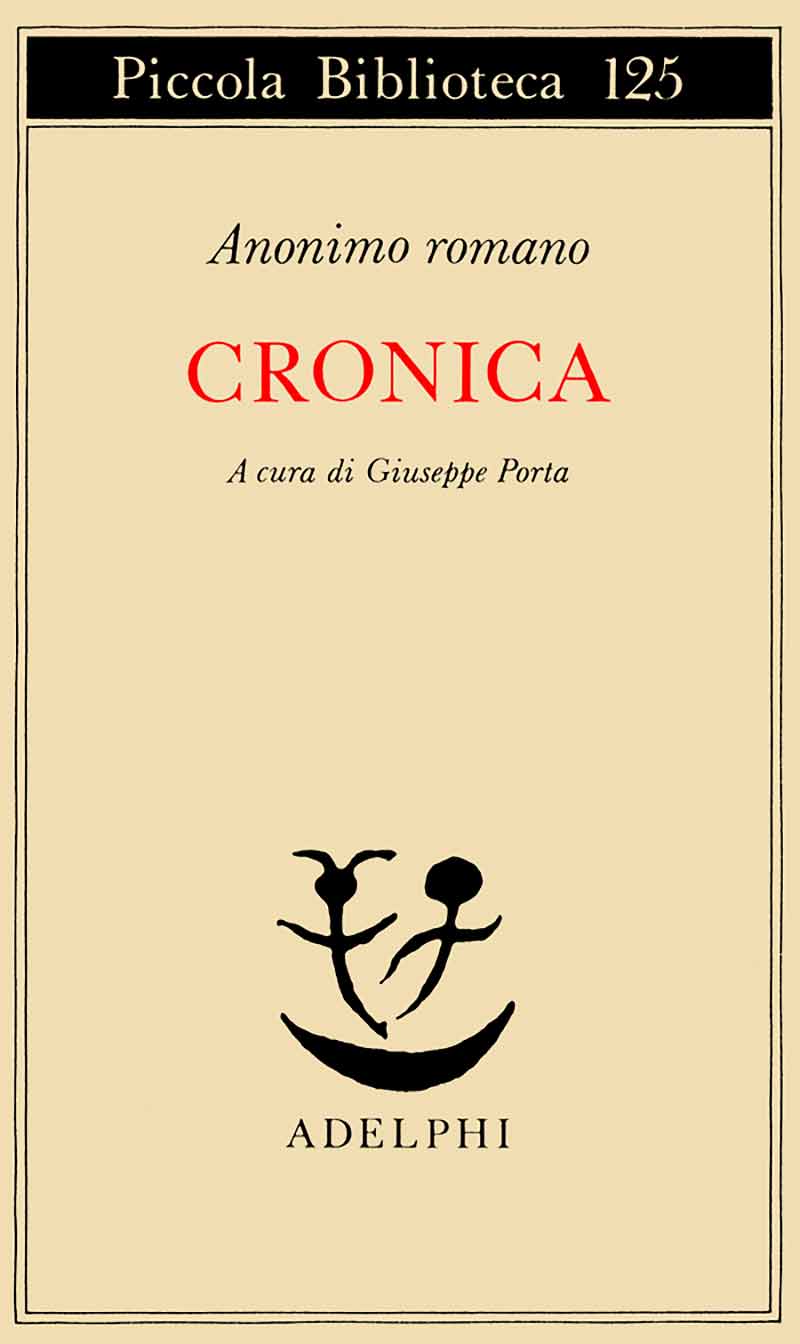Durante gli ultimi mesi del 1357 e i primi dell’anno successivo, un oscuro personaggio di origini romane di cui non conosciamo né il nome, né la condizione sociale, scrive uno dei testi tra i più importanti del nostro Medioevo,
Nel prologo, il nostro autore indica la sua opera con lo schietto nome di Cronica, un genere letterario di grande successo durante il lungo millennio medievale, un insieme di opere che ci consentono oggi di ricostruire, se presenti e affidabili, parte della nostra storia e dei nostri costumi.
Oltre che fonte storica, la nostra Cronica è un documento di singolare importanza da un punto di vista linguistico poiché testimonia il dialetto romanesco del Trecento, ovvero ci consente di studiare la lingua di Roma prima che questa venga profondamente influenzata dal fiorentino nel corso del Rinascimento.
Ma cosa ci racconta il nostro autore? Quale metodo utilizza nella scelta dei fatti da narrare?
In tal senso, come spesso capita nella storia della letteratura, è fondamentale la dichiarazione contenuta nel primo capitolo:
Quello che io scrivo sì ène fermamente vero. E de ciò me sia testimonio Dio e quelli li quali mo’ vivo con meco, ché le infrascritte cose fuoro vere. E io le viddi e sentille: massimamente alcuna cosa che fu in mio paiese intesi da perzone fidedegne, le quale concordavano ad uno.
(Anonimo Romano, Cronica, a cura di Giuseppe Porta, Milano, Adelphi 2010. Prima edizione 1979. p. 5)
Dunque il nostro autore riporta solo ciò che ha visto o ciò che gli è stato raccontato da soggetti affidabili e in questo non differisce molto da tante altre dichiarazioni di metodo proprie del genere storiografico. Ciò in cui la nostra Cronica si distingue, rispetto a quelle contemporanee, è l’oggetto della sua indagine: non si tratta infatti di una storia universale, ma si sofferma solo sulla città di Roma, e su avvenimenti recenti.

L’Anonimo Romano (così viene chiamato il nostro oscuro autore), però, pur circoscrivendo la sua attenzione solo alla città, parte da questa per abbracciare quasi tutto il Mediterraneo, raccontandoci quegli eventi che si sono intrecciati con , i destini della città: battaglie, gesta cruente, nobildonne e uomini chiusi nel ferro, ambasciate e tradimenti.
Questo fantastico intreccio di avvenimenti, però, è in gran parte scomparso: solo pochi capitoli sono arrivati fino a noi, e i brani meglio conservati ci raccontano la parabola di un personaggio davvero singolare e importante della storia medievale di Roma: Cola di Rienzo.
Cola de Rienzi fu de vasso lenaio. Lo patre fu tavernaro, abbe nome Rienzi. La matre abbe nome Matalena, la quale visse de lavare panni e acqua portare. Fu nato nello rione della Regola. Sio avitazio fu canto fiume, fra li mulinari, […]. Fu da soa ioventutine nutricato de latte de eloquenzia, buono gramatico, megliore rettorico, autorista buono.
(op. cit. p. 104)
Insomma, il nostro autore traccia il profilo di un grande personaggio al quale va tutta la sua simpatia, di cui loda o rimprovera di volta in volta gli atti.
Nicola, infatti, da semplice notaio si ritrova ad essere il perno politico di Roma durante gli anni centrali del secolo a seguito di un’intelligente campagna iconografica e dell’appoggio pontificio, allora ad Avignone. Il nostro Anonimo è proprio lì, tra la folla dei romani che idolatrano l’uomo del popolo, che con poche parole è capace di incendiare i loro animi, di rubare i loro cuori e imbrigliare i loro pensieri.
I successi di Cola sono plurimi: la proposta di diversi ordinamenti volti a migliorare la situazione del popolino, tra i quali spicca il lodevole tentativo di reprimere la violenza privata e pubblica oppure il nuovo stato di benessere che si propaga anche nelle campagne romane una volta divenuto Tribuno del popolo romano.
Certo a questi grandi risultati fanno da contraltare gli eventi di subito successivi: non solo la confusa e violenta lotta contro i baroni ma anche un cambio di rotta dello stesso Cola fecero fallire la sua proposta di governo.
La prima fase della sua parabola si conclude nel 1347 quando, linciato dalla folla aizzata dai baroni romani, tra i quali spiccano gli Orsini, una delle maggiori famiglie nobili d’Italia, si chiude in Castel Santangelo, spaventato e con la coda tra le gambe. Al comando della capitale ci sono di nuovo i baroni.
Lo iato della sua assenza si prolunga sino al 1353, gli anni subito successivi alla prima grande ondata di peste; le condizioni del popolo non sono di certo le migliori così come non lo sono, alla fatta dei conti, le intenzioni di Cola. La sua Ars oratoria infatti gli consente di riottenere un ruolo di prestigio e di guida per il popolo romano anche se solo per pochi mesi.
Perché la sua nuova impresa precipita in meno di un anno?
Come scrive il nostro autore, il vizio e la tracotanza avevano ormai rotto l’animo del tribuno, il quale sarà brutalmente ucciso, in un impeto di sconcertante violenza, proprio da quei romani che aveva certamente tanto amato ma anche irrimediabilmente tradito. A lui le ultime parole del mio intervento:
Omo (Cola) eracomo tutti li aitri, temeva dello morire. Puoi che deliverao (decise) per meglio de volere vivere per qualunche via potéo, cercao e trovao lo muodo e·lla via, muodo vituperoso e de poco animo. […] Misticaose colli aitri. Desformato desformava la favella. […] Passata la uitima porta uno se·lli affece denanti e sì·llo reaffigurao, deoli de mano e disse. «Non ire. Dove vai tu?» […] Allora l’uno, l’aitro e li aitri lo percuoto. Chi li dao, chi li promette. Nullo motto faceva. Alla prima morìo , pena non sentìo. Venne uno co con una fune e annoaoli tutti doi li piedi. Dierolo in terra, strascinavanollo, scortellavanollo. […] Per questa via fu strascinato fi’ a Santo Marciello. Là fu appeso per li piedi uno magnaniello. Capo non aveva. […] Grasso era orribilmente, bianco como latte insanguinato. Tanta era la soa grassezza, che pareva uno esmesurato bufalo overo vacca a maciello.
( op. cit. pp. 196-197).
Leggi tutti i nostri articoli sul medioevo
In copertina: Federico Faruffini, Cola di Rienzo, 1855