Quando l’ho aperta per la prima volta, ho pensato: finalmente. Avevo di fronte un’antologia poetica che non sapeva né di scuola né di biblioteca. E per questo mi è piaciuta subito. Si chiama Poesie dell’Italia contemporanea ed è l’antologia pubblicata l’anno scorso dal poeta, critico e studioso di letteratura Tommaso Di Dio. L’antologia ha questo, di particolare: non mette in fila gli autori, tipo pantheon o galleria delle vecchie glorie, ma le poesie, divise per decadi, dal 1971 al 2021, e questo dà una lettura tutta diversa. E poi c’erano tante vecchie conoscenze, e tanti poeti che non avevo ancora letto. E devo dire che non mi capitava da un po’ di tempo di leggere poeti nuovi, e appassionarmi
L’antologia poi ha generato un certo scalpore, ha fatto discutere, ed è un buon segno. Non avrei pensato di potermi entusiasmare per il dibattito attorno a una cosa così da nerd della letteratura come un’antologia. Soprattutto, era interessante capire quale fosse il percorso che ha seguito, quali i criteri, come avesse costruito un’opera che sembrava quasi un patchwork, più che un’antologia. È così che a settembre ho incontrato Tommaso Di Dio, e ne è nata una lunga chiacchierata. Dato che detesto parlare dei libri solo quando escono, per poi dimenticarli dopo qualche mese – ma soprattutto perché non so rispettare le scadenze – la nostra discussione è rimasta in cantiere per diverso tempo. Ma, alla fine, eccoci qui.
Partirei da una cosa che mi è piaciuta tantissimo, e cioè il dare la priorità ai testi rispetto agli autori. Di solito, in una qualsiasi antologia, si dà importanza agli autori, anche perché è più facile rispetto al partire da poesie singole. Perché hai fatto questa scelta?
Ti ringrazio di aver messo subito il fuoco sulla questione dei testi, che è in fondo il tema rimosso dalle critiche che ho ricevuto, anche da quelle più positive, ed è evidente che c’è una difficoltà a relazionarsi con la letteratura a partire dai testi. L’approccio che ho seguito, infatti, è un approccio che fa a meno di alcune invarianti che rassicurano e confortano il lettore, e anche il critico. Di solito infatti l’autore viene assunto a invariante, a oggetto fisso che permette di organizzare la varianza dei testi. Gli autori scrivono molti testi nel tempo, ma rimangono loro stessi, rimangono la stessa persona. Valerio Magrelli scrive un testo negli anni Ottanta, poi ne scrive un altro nel 2022, ma Magrelli è sempre lui, no? Ecco l’invariante che rassicura, di cui si può seguire il cammino.
Qui, invece, propongo una strategia diversa di approccio: una lettura della poesia contemporanea come insieme di varianti. Credo che intorno a noi ci sia un’asfissiante presenza dell’autore e del narcisismo autoriale che spesso riduce la letteratura a un puro gesto espressionistico nel senso deteriore del termine, da un lato; e dall’altro riduce il fatto letterario a sociologia, a contrasto fra io, fra gruppi, fra clan di io. E allora, proprio perché questo mi sembra l’atteggiamento dominante nel contesto in cui viviamo, mi sembrava salutare fare un esperimento diverso, un tentativo. Abbiamo la gioia di tentare in letteratura? C’è ancora veramente la letteratura come esperienza non definitiva, non definitoria? L’approccio sperimentale alla letteratura viene visto come una minaccia, perché mina proprio quella sociologia di status quo, di piccoli campi definiti che, come dire, rassicurano, perché sono l’insieme delle invarianti.

Quindi come hai costruito la raccolta?
Sono partito da alcune sensazioni. La prima è che io non riesco più a pensare la letteratura come un teatro di gesti eroici, come su un palcoscenico. Non vedo più alcun eroismo, nel senso più tradizionale, delle figure della letteratura di oggi. Oggi chi scrive e chi si occupa di letteratura, deve partire dalla propria impotenza. Dalla propria radicale inefficacia, dalla propria radicale inopportunità politica. Io parto da questa sensazione. Il gesto letterario per me è ormai privo di efficacia politica immediata. Mentre ancora Luzi poteva essere nominato senatore, non credo che oggi nessun poeta possa esserlo; e, tra poco, nemmeno nessun narratore. Quindi un percorso di poesie attraverso le figure eroiche degli autori sembrava incoerente.
La seconda sensazione forte che avevo è che non credo nel progresso. Credo nell’evoluzione. Sono cresciuto negli ultimi dieci anni con la filosofia di Darwin e la filosofia di chi Darwin lo ha studiato e promosso, come Stephen Jay Gould. Ecco, sono un evoluzionista, non sono un progressista. Mi sembra che tutte le storie della letteratura, tutte le antologie della poesia contemporanea, in qualche modo tradissero un’idea di progressività, o tradissero l’idea che c’è stata un’epoca gloriosa e progressiva e che oggi non lo sia più. E quindi sia un’epoca di decadenza — perché, si badi, chi pensa che ci sia una decadenza è colui che pensa che c’è stato un progresso.
Io percepivo il mio tempo come pieno, fradicio di questa ideologia progressista decadente: Gli ultimi poeti, per esempio, il libro di Ferroni su Giudici e Zanzotto, come se esistessero gli ultimi grandi. Ecco, io non volevo avere un approccio decadente-progressista, ma uno sguardo di metamorfosi, di trasformazione continua; ecco, quello che per Darwin è il corallo, la ramificazione a corallo dell’evoluzione.
Come rappresentare, dunque, questa esperienza? Ecco, nel leggere i testi, io continuavo a vedere che gli autori, anche molto lontani tra loro, erano in una sorta di dialogo, di filiazione, di contatto, anche inavvertitamente. In altre parole, ho maturato una visione del panorama letterario come un intreccio ricco di forme in continua evoluzione: un approccio ecosistemico, dunque. Un ecosistema in cui sono presenti dialoghi, contatti, ma anche scontri, perché come sai l’evoluzione nasce attraverso lo scontro: se nella stessa nicchia le risorse sono limitate, nasce una lotta, una differenziazione.
Venendo nello specifico alla tua domanda, negli ultimi quindici anni ho girato molto l’Italia da poeta, quando iniziava ad esserci la possibilità di incontrare coetanei anche fuori dalla propria cerchia fisica. Questa cosa l’ho vissuta con grande fervore: per me era bellissimo a conoscere, leggere, viaggiare. Quindi ho potuto costruirmi negli anni una serie di persone intorno a me che stimavo e che seguivano come me la poesia contemporanea, con cui c’era un confronto costante, a prescindere dalle poetiche di appartenenza. E ogni volta che qualcuno mi diceva: «ho letto un libro pazzesco», io lo leggevo.
A un certo punto però ho dovuto sistematizzare questa conoscenza, e ho seguito due criteri diversi per i primi trent’anni dell’antologia e per i successivi venti. Per i primi trent’anni ho potuto appoggiarmi a una forte presenza storiografica, quindi non ho fatto altro che basarmi sulle storicizzazioni già assodate, e arricchirla di tutti quei libri che mi sono stati consigliati, come per esempio il libro di Gino Scartaghiande, I sonetti d’amore a King Kong, che è un grandissimo libro, ma sicuramente non è un libro che è stato letto dalla Storia, diciamo così.
Anche Alessandro Ricci, per esempio, è un grandissimo poeta romano, Stranissimo, isolato, poeta che lavora sul tema della Storia: le sue poesie sono basate sulla storia antica, cioè sulla rievocazione di fatti della storia antica. È una figura certamente marginale, grande, che ha scritto di poesie bellissime e le ho potute inserire. Quindi ho corretto, diciamo così la storiografia affermata in quegli anni, con una serie di autori che in quegli anni che erano sfuggiti alle storiografie più importanti, ma che mi sembra abbiano una potenzialità di parlare al nostro tempo.

Se da un lato mettere in rilevo i testi porta a trovare delle interconnessioni, e quindi a privilegiare l’aspetto collettvo, è difficile poi rappresentare gli autori più marginali. Come sei riuscito a trovare un equilibrio?
Ho cercato di inserirli e soprattutto di farli dialogare con quello che avveniva nel loro contemporaneo, perché spesso alcuni autori che erano marginali sono stati riscoperti, per esempio Salvatore Toma, grande poeta, matto, che ha avuto anche un culto negli anni dopo la sua morte. Dopo la sua morte, però: ecco, la mia idea era di restituirlo al suo tempo, negli anni in cui scriveva, anche se non lo leggeva nessuno; gli anni in cui ha scritto i suoi capolavori erano sfasati rispetto al suo successo. Anche un altro grandissimo, che in quegli anni era letto pochissimo era Luigi di Ruscio. Metterlo negli anni ‘80 cambia tutto; dà una lettura diversa degli anni ‘80. Tutte le storie della poesia degli anni ‘80 si aprono con Magrelli. Io apro con Blackout di Nanni Balestrini e Istruzioni per l’uso della repressione di Luigi di Ruscio proprio a smentire una lettura adagiata sullo stereotipo degli anni ‘80 come anni di disimpegno.
Partire dai testi, inoltre, vuol dire energizzarne il dialogo: non mettere tutte le poesie simili insieme, ma evidenziare i contrasti, le differenze. E quindi trovare dei giochi di scarti, di avvicinamenti che portino una diversa percezione. Per esempio, ho messo un poema di Mariano Baino che racconta il male tecnologico, il crepitìo tecnologico, con un pastiche ricco di parole inventate, di giochi di parole, e che racconta lo spegnersi, come dire, dell’anima critica nel ticchettìo delle macchine. E subito dopo ci ho messo una poesia di Raboni, un sonetto classico, di settenari, che racconta il decomporsi nel cervello. È lo stesso tema di Mariano Baino, ma è completamente diverso. Io vorrei che il lettore prendesse questo libro come un inno alle infinite possibilità della poesia. L’io poetico si può dire in molti modi. E non è un male.
Cioè, io vorrei che il lettore si immergesse, ma poi avesse anche degli shock che lo estraniano, che, in senso brechtiano, lo portano a distanziarsi dal testo, da metterlo in discussione. Io non volevo un lettore che sia prono e drogato dalla bellezza di questi testi poetici. E questo è un rischio dell’omogeneità.
Qui tocchiamo un argomento importante, e cioè il valore del testo poetico. Perché spesso l’antologia che cos’è? È uno scegliere i testi migliori, o considerati migliori dal curatore. Per te, invece, questi non sono i testi migliori, ma quelli più efficaci per raccontare un’epoca.
Sì, o meglio: è l’incrocio di due fattori. I testi vengono scelti perché più rappresentativi di una mia lettura, di una lettura autoriale, di un’epoca. E, secondariamente, anche la sequenza mi interessava, e mi vincolava: io vorrei che chi legge questo libro lo legga come un romanzo; e le varie decadi come dei libri di poesia, e quindi io uso lo stesso criterio che io uso quando costruisco i miei libri di poesia: una poesia bella se non sta bene in quella posizione non finisce nel libro. La singola poesia doveva anche incastrarsi bene in quel contesto, nella sequenza che stavo creando.
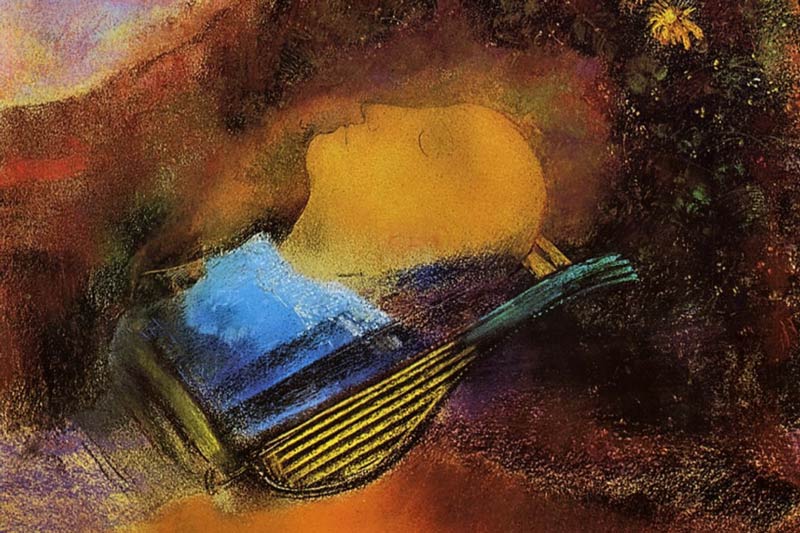
Apparentemente, dunque, chi legge pensa di trovarsi davanti a dei testi singoli, svincolati dal loro autore, ma in realtà costruisci una trama che diventa più importante dei testi singoli. È il paesaggio che conta, non l’albero.
Fin da quando ero giovane, per me il tempo di costruzione della trama del libro è molto maggiore di quello che spendo nella scrittura effettiva: e infatti alcuni mi hanno detto che questo è un libro mio, perché conoscono la mia storia di autore, e come ragiono. Pensa alle Bucoliche di Virgilio: ogni testo ha una serie di rifrangenze perfette, simmetriche con tutti gli altri. Per me è il libro più bello che l’uomo ha creato, quantomeno in Occidente. Il libro perfetto di poesia. E io mi ispiro a quel tipo di libro poetico, in cui quando tu sei in un punto, gli altri punti sono presenti come virtualità.
Quindi possiamo dire che questo è una sorta di canzoniere collettivo della letteratura italiana, no?
Sì, però attenzione, ci tengo a dire che di cui io sono l’autore: questo è un atto di onestà e ovviamente il suo limite. È il suo limite, anche se secondo me è un atto importante: l’autore si mette in scena come autore, quindi non fa più finta di non esserci. Sono io, sono il curatore di questa grande opera concettuale fatta di brani di opere altrui, collegate fra loro in maniera da corrispondersi, da dialogare, nei libri e all’interno del corpus generale del libro: la prima e l’ultima poesia, per esempio, sono in dialogo. Ecco, io non volevo nascondermi dietro un assoluto.
Concordo, è un esercizio per toglierci l’oggettivismo inconsapevole che permea la nostra cultura, per cui le cose sono così come sono, quando in realtà le cose sono un’interpretazione, sono come noi le vediamo.
Eh sì, il prospettivismo l’abbiamo studiato, ma non esiste ancora nella cultura generale, anche perché bisognerebbe fare un passo avanti: se l’oggettività è una costruzione, pure la soggettività è una costruzione. Perché poi si cade anche in questo: non è che basta dichiarare la propria soggettività e va tutto bene. Anzi, il rischio è di essere altrettanto assoluti. Invece io sono comunque la somma dei miei incontri, delle mie condivisioni, delle mie spartizioni. Questo è il mio libro ma anche il libro del mio nemico, per dire. È un libro pieno di cose che non mi appartengono, ma che ho inserito perché io non sono solo io, sono una pluralità, una costruzione Per esempio c’è una grande enfasi sull’area di ricerca: tu sai che io non vengo da quell’area ma ho lavorato a un libro che rappresentasse l’area di ricerca al pari dell’area lirica.
Infatti quello che mi ha stupito è che diversi poeti che sono più vicini al tuo sentire qui manchino o siano meno rappresentati. Tra l’altro, la famosa “area di ricerca”, secondo me è un’espressione orrenda: io sono convinto che uno dei maggiori poeti lirici della nostra letteratura sia Edoardo Sanguineti. Postkarten, per esempio, è un testo lirico, condotto con strumenti lontani da quella che chiamiamo lirica, ma percorso da un afflato assolutamente lirico.
Condivido pienamente. Tra l’altro farei anche un passo in più: tutti i poeti che noi amiamo, e che consideriamo grandi, sono grandi perché non erano solo di un’area, ma attraversavano le correnti, se ne facevano influenzare. Tu dici che Postkarten è un testo lirico ovviamente perché noi lo assumiamo come testo sperimentale, ma la verità è che Postkarten c’è la tensione fra elementi lirici e antilirici. Ed è la cosa bella di quel libro. Come in Mario Benedetti, che è uno dei più grandi autori degli ultimi vent’anni, c’è una forte compresenza di elementi lirici, ma anche di frammentazione, della distruzione dell’io lirico che appartengono tradizionalmente ad altre esperienze di scrittura. O Giuliano Mesa.
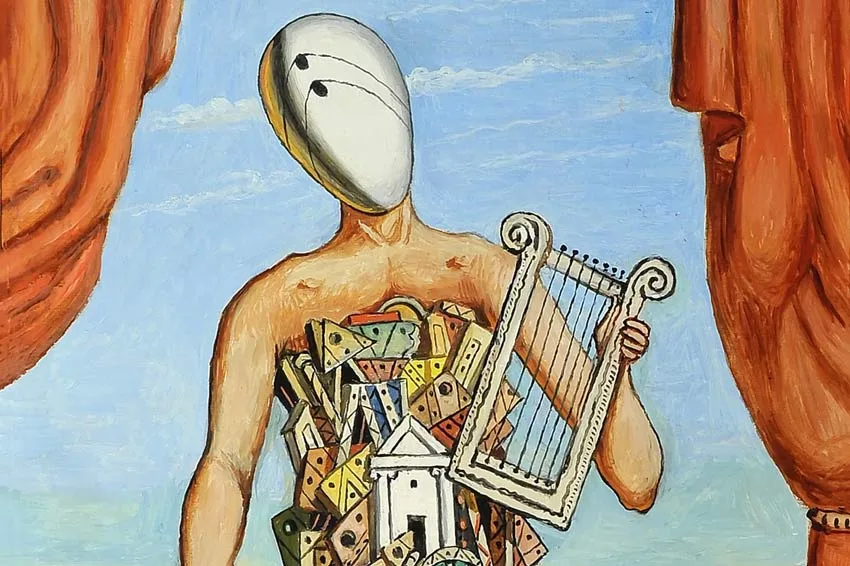
Dicevi che avevi usato due criteri per l’antologia. Abbiamo parlato dei primi trent’anni, ma non degli ultimi venti.
Nella seconda parte ho usato un metodo un po’ diverso, perché appunto, la storia non c’era, e io stesso ho dovuto anche affrontare delle letture più sistematiche. Ho dovuto fare un recupero storico dei testi, ed è stato per me veramente bello: è la parte che mi è piaciuta di più scrivere, perché sono usciti fuori degli anni pazzeschi, tra i più belli della nostra letteratura. Mi sono letto gli esordi di autori come Ceni, Mussapi, o anche più giovani, come Andrea Inglese, che avevo conosciuto come poeti già maturi, e ho recuperato quegli autori che erano usciti dai radar, come Franco Berisso, Tommaso Ottonieri, e poi dei poeti che ho amato molto, come Simone Cattaneo, che secondo me racconta molto bene certo esistenzialismo tragico, espressivo, negli anni Duemila.
Ho escluso quei testi che non presentavano delle spiccate differenze formali rispetto agli altri: libri dalla lingua più tradizionale spiccavano meno sulla pagina, e allora ho preferito valorizzare forme di scrittura più estreme, più contrastanti. Ecco, il mio non è stato un movimento deduttivo, dalla collana all’autore al testo, ma induttivo: sono partito dalla poesia per ricostruire tutto il resto. Questa è un’antologia di individui, di singolarità. Certo, escludere voci meno forti di altre è un limite di una raccolta che vuole essere una proposta, un esperimento, e non un canone.
Ecco, il canone: è possibile non definire un canone? Qualsiasi tipo di proposta che uno fa non è implicitamente una canonizzazione?
Sicuramente bisogna distinguere fra tentativi canonizzanti, espliciti, e canonizzazioni implicite allora. Partiamo dal presupposto che stiamo parlando della letteratura e che quindi qualsiasi persona intelligente che sa conosce la letteratura, sa che un canone esiste sempre, ma che canone è sempre variabile. Dobbiamo proprio partire da questo presupposto: ogni epoca ha un canone implicito. Un canone che che fa parte dei gusti di un’epoca, dell’egemonia culturale di certi gruppi, di certe persone… ma bisogna saper dire contemporaneamente che nessun canone è eterno. Una cosa interessante oggi è che questi due presupposti, che erano scontati, oggi diventano presupposti militanti. Hai capito?
Mentre Sanguineti faceva la sua antologia nel ‘69, La poesia italiana del Novecento, sapeva benissimo questa cosa, però rimaneva sullo sfondo, lui voleva imporre il suo canone, nella nostra epoca queste due dimensioni implicite sono diventate l’obiettivo da raggiungere. Questa forma antologica è fatta in maniera tale che fosse due cose assieme: un canone non può che esserci; eccolo, ma d’altro canto non bisogna prendere sul serio questo canone, perché è una proposta. Cioè: non credere mai che esista un gesto neutro, perché ogni gesto ideologico; e d’altro canto non essere così ingenui da credere che la propria ideologia sia un assoluto che si può bellamente imporre alla Storia. Certo, tra i molti limiti di quest’opera, c’è il fatto che alcuni percorsi autoriali vengono sacrificati, che le personalità degli autori vengono penalizzate: però è anche una caratteristica del libro, come mi ha detto Gabriele Frasca, un “effetto Spotify”: ho preso un highlight di ogni poeta, e li ho messi insieme.

Beh, in effetti è il modo con cui si costruiscono le playlist, non ci avevo pensato.
È quello che ha ribadito, da tutt’altra parte critica, anche Andrea Cortellessa. È un libro che assume contemporaneo nella sua medialità senza volerne fare una critica decadente. Noi già leggiamo così. Ognuno di noi ha nella testa questo: una serie di poesie fighe, che uno ha letto, magari sul cellulare… però poi quando facciamo storia allora vestiamo la toga. E, come diceva Cortellessa, un altro limite, ma caratteristica di questo libro, è che percepisce l’insieme solo come viaggio di una soggettività.
Ed è una cosa che diceva dolore, che in questo libro c’è un soggetto che deve portare dentro il suo mondo, e noi concepiamo la storicità solo come viaggio di una singolarità. E questo lo faceva soffrire, era ideologicamente contrario a questo, però, come mi ha detto, questo è esattamente il mondo in cui viviamo, e il libro rappresenta questa contemporaneità. È il libro che più di altri rappresenta come noi percepiamo nel contemporaneo la letteratura, e in questo senso dunque è un libro contemporaneo. Non va letto dalla prima pagina all’ultima, ma ha tante entrate e uscite: ognuno si fa il suo libro. Il libro che hai letto tu non è il libro che leggerà un altro.
Un ulteriore tema, secondo me, è la tensione tra la storicità della poesia e, come dire, la sua evocatività. Personalmente, ho sempre avuto un po di dubbi riguardo la critica storiografica. Nel senso che la la critica, soprattutto a livello accademico, rischia di essere una specie di entomologia, in cui si prendono in considerazione tutti a prescindere dal loro valore artistico o espressivo, e quindi alla fine ci si ritrova con dei testi che sì, magari saranno anche espressione di un’epoca, ma non si capisce perché uno li debba leggere adesso, quale sia la loro effettiva forza poetica.
È un tema che ho sentito moltissimo: è una questione importante, va espressa bene perché c’è dietro una filosofia della storia. Questo libro, Poesie dell’Italia contemporanea, ha questo aggettivo, contemporanea, bello grande, evidente, perché questo è il punto di riferimento. Il tentativo è quello di attraversare il tempo, ma il punto di vista sono io; il punto zero è l’oggi, è il momento in cui stai leggendo. Tutto quello che rievochiamo del passato non è rievocato in senso storicistico, assoluto, per dire la verità di quell’epoca. Non è un saggio di storia.
Il passato è attraversato per giungere al presente, che non è un caso che infatti, come nei paesaggi, accade a mano a mano che ci avviciniamo alla fine – che poi è l’inizio, è il punto zero – la quantità di testi aumenta. E aumenta perché aumenta la definizione: tu, a mano a mano che ti avvicini all’oggi hai una quantità maggiore di di di date a disposizione, di dettagli da vedere, di sfumature da cogliere. Quindi questa non è una storia della poesia contemporanea, è un viaggio dentro i tempi della poesia, che mirano sempre a enfatizzare il contemporaneo, cioè l’esperienza che possiamo fare oggi di quei testi.

Un ultimo aspetto su cui volevo soffermarmi è che nel libro commenti diverse poesie. Secondo me si è persa la pratica del commento ai testi: si pensa sempre che “la poesia non si spiega”. Però in realtà io credo che la poesia si spieghi eccome, anzi, sia uno dei testi più commentabili proprio perché la poesia è una sintesi estrema di concetti, e quindi per comprenderla va esplicata, va dipanata.
Diciamo che è interessante questo aspetto nella sua duplice versione: la poesia è inspiegabile e quindi va spiegata. La conseguenza della sua inspiegabilità è che si spiega. Capire questo è decisivo, cioè: è il nucleo inspiegabile della poesia che fa spazio alla spiegazione, fa quel vuoto che permette che qualcosa entri. Se la poesia fosse tutta spiegabile, una volta spiegata dovremmo solo tacere. E invece, proprio grazie al fatto che è inspiegabile, cioè che conserva un nocciolo infinito di inspiegabilità, noi possiamo sempre spiegarla ed esistono spiegazioni differenti nel tempo della poesia.
Ecco, io ci credo tantissimo, a patto che sia però chiaro che la poesia e la spiegazione siano due momenti diversi. Infatti questo libro è la materializzazione formale di questa visione della poesia: per me esiste l’esperienza del testo che deve essere un’esperienza anarchica, nuda, libera, ed esiste poi, poi, l’esperienza della spiegazione del testo, ma quando il testo è soffocato dalla spiegazione, come nel classico commento scolastico tendiamo a dare importanza alla spiegazione e non al testo, ed è un fenomeno tipico di questo tempo, secondo me. Che vive due ingenuità. Da un lato quella neo-romantica: c’è solo il testo; e dall’altro quella neo intellettualistica, cioè la spiegazione è più importante del testo, la sociologia è più importante del testo.
Secondo me invece hanno entrambi dignità e autonomia: io leggo un testo non perché c’è stata una spiegazione, leggo un testo e voglio vivere un confronto mio, con il testo. Voglio essere poi libero di cercare una spiegazione, un commento, un qualcuno che apra e mi illumini altro di quel testo. Ma i due momenti devono stare separati. Questa antologia è fatta perché questo avvenga. Deve avvenire la lettura del testo. Nuda casta, libera, e può avvenire anche il commento del testo. Prima e dopo. Ma io devo poter fare esperienza del testo, perché la gente non sa più leggere i testi.
Quest’antologia voleva lottare polemicamente contro queste due cose: il narcisismo estremo e l’egemonia della sociologia in cui tutto è intellettualismo e commento intellettuale. Prima di tutto leggiamoli, facciamo l’esperienza del testo, e poi vediamo che cosa ne possiamo imparare da dei percorsi intorno e attraverso di loro. Ma prima devi vivere lo shock, anche linguistico, di una poesia senza spiegazioni.
Devi viverla, la poesia, non puoi tapparla con una spiegazione. Se no diventa consolante, diventa un modo per consolarsi intellettualmente. Ma la poesia non deve consolare, deve spiazzarti, deve lasciarti nel buio, nel pericolo. Devi dire: ma che cazz… cos’è? È questa l’esperienza della poesia, un de-placement, uno spiazzamento, un non so cosa, un non sapere come muoversi dentro il testo. È questa la violenza dell’esperienza letteraria, ed era fondamentale che rimanesse preservata.
Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche: Perché in poesia si va a capo spesso?









