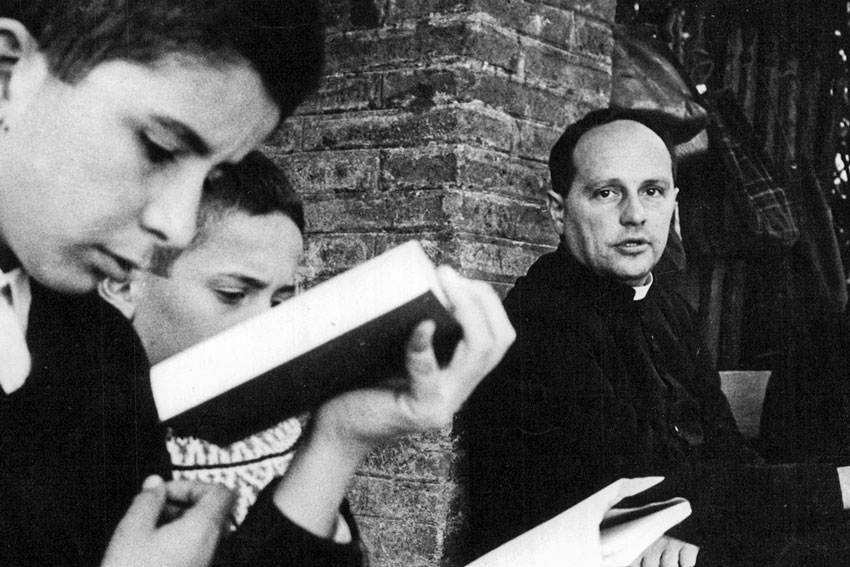Benvenuti a Saltsea
Una volta c’era tutto per tutti. Ma agli hoarders, gli accaparratori, tutto non bastava e hanno preso ad accumulare quanto potevano.
Il mare si è arrabbiato e ha iniziato ad alzarsi, e loro hanno risposto costruendo immense torri.
Il sole offeso si è alleato col mare e assieme hanno portato al Flood, all’Alluvione, distruggendo l’operato degli hoarders.
E ora siamo qui tra queste isole, in un tempo imprecisato dopo l’Alluvione, in un mondo fatto di comunità. Ognuna col suo carattere, bisogni, visioni. E con una persona da ritrovare.
Saltsea Chronicles è un videogioco narrativo ricco di anomalie. La principale: non viviamo la storia attraverso lo sguardo e le azioni di un protagonista, ma di una ciurma. Di isola in isola e di capitolo in capitolo ci sposteremo con coppie diverse di personaggi, compiendo scelte e portando avanti conversazioni come parte di un gruppo, non come singoli avventurieri.
E in un medium solitamente viziato da uno sguardo eroistico, machista e colonialista, questa è una dichiarazione di intenti coraggiosa che delinea tutti gli aspetti del gioco. Spoils (Bottino), il minigame di carte che attraversa il Saltsea, ha regole che puniscono la prevaricazione dell’altro. Ogni isola che incontriamo è approcciata con apertura e curiosità, come uno spazio da ascoltare (anche quando non lo capiamo) e non un luogo su cui intervenire, da modificare o, peggio, “salvare”. E il nuovo grande rischio che si profila all’orizzonte viene dal lone hero della situazione, da chi ha deciso che, da solo, può capirne e saperne più degli altri.
Per Hannah Nicklin, narrative designer del gioco, Saltsea non è un’utopia perfetta, ma una possibilità. Ci sono problemi, litigi e incomprensioni, ma c’è anche il tempo e lo spazio mentale per affrontarli, perché assente è la paura costante e congelante per la sopravvivenza, elemento che caratterizza sia quell’esplosione di distopie che ci bombarda quando parliamo di futuro, sia il nostro quotidiano sempre più soffocante tra tripli lavori, affitti astronomici, guerre e crisi ecologica.
Se questa scarsità indotta in cui vi viviamo ci viole spingere a trattare l’altro come un nemico, nel Saltsea tutti vivono di quel di cui hanno bisogno, hanno una casa, del cibo. Hanno spazio per esprimere attitudini e volontà, compresa quella di non fare. Ed è possibile restare nel conflitto, nella complessità, perché c’è il tempo per comprendere e quando necessario, cambiare.
Per immaginare questo mondo lɜ designer di Die Gute Fabrik sono partitɜ chiedendosi: cosa accade se eliminiamo dalla formula il capitalismo? Nel Saltsea il capitalismo è assente ed è visto come il colpevole del Flood (facile vedere negli hoarders Elon Musk, Jeff Bezos e compagnia brutta), il denaro pure (e quando compare viene malvisto). Il lavoro è solo uno tra gli aspetti della vita, tanto importante quanto giocare a Spoils tutte assieme o osservare gatti che dormono o prendersi il tempo per elaborare un lutto.
Il rapporto tra persone umane e persone non umane è di ascolto, mutualismo e con-creazione, una collaborazione che renderebbe felice Donna Haraway. Nell’isola di partenza, i njar (una specie di uccello) sono alla base della sopravvivenza dell’isola tutta, e lo scambio/dialogo con gli uccelli permea i costumi locali, le rappresentazioni sociali, le attività sportive. In Fort Alcazar, una comune di artistɜ, le ritualità della locale comunità di granchi scandiscono i ritmi di mostre ed eventi. E quando questa conversazione con l’ambiente viene meno, il risultato è un disastro che colpisce persone umane e non.
Saltsea Chronicles parte da un rifiuto dell’idea che domina gli scenari post-apocalittici: non è vero che cane mangia cane, che se la società collassa ci distruggeremo in guerre tra bande rivali. The Last of Us o The Walking Dead non sono l’esito che ci aspetta se il sistema crolla, ma sono narrazioni funzionali al sistema che ci governa, come ci mostrerà tra poco Rebecca Solnit. Anche per questo Nicklin e Solnit ribadiscono: il modo in cui narriamo le cose (pure negli scenari inventati) è un atto politico.
Rebecca Solnit e il Saltsea tra noi
A Paradise Built in Hell è un saggio di Rebecca Solnit che dimostra come nei momenti di crisi il nostro istinto sia quello di fare comunità. Partendo da grandi catastrofi (come la devastazione dell’uragano Katrina a New Orleans o il terremoto di San Francisco del 1906), Solnit accumula fonti, testimonianze e riflessioni per mostrarci l’emergere di utopie sociali, azioni di aiuto, supporto che vanno a tamponare non solo i danni del cataclisma, ma anche quelli fatti dall’intervento dello Stato, spesso più interessato a difendere la proprietà privata che non i cittadini (e non casualmente nel Saltsea non c’è Stato né nazione).
L’abbiamo visto di recente anche con le alluvioni nelle Marche, in Romagna, in Toscana: ondate di volontari partite per dare una mano, per aiutare persone che non conoscevano a recuperare le loro case, pulirle, dare supporto emotivo. O durante il Covid, dalla vicina che ha fatto la spesa per chi non poteva uscire ai collettivi che hanno creato collette alimentari per chi ha perso il lavoro.
Solnit fa una divisione netta tra ciò che accade e ciò che viene narrato, e recupera l’idea di elite panic coniata da Caron Chess e Lee Clarke per spiegare come media e politica narrino le situazioni di crisi in modo così distante dalla realtà. L’elite panic nasce dalla convinzione delle élite che, se non sono loro al potere, la società tutta andrà distrutta. È una convinzione generata dalla paura dei poveri, delle minoranze, dei migranti. Da qui viene ad esempio l’ossessione terrorizzata per il saccheggio, presente tanto nelle narrazioni giornalistiche quanto in film e telefilm.
Ma la narrazione dettata dall’elite panic è, per l’appunto, sganciata da una realtà che è fatta di supporto, aiuto, tutela. Ed è qui che il saggio di Solnit si collega a Saltsea Chronicles: l’unica situazione di puro antagonismo, di me contro te nel videogioco, è posta dall’unico personaggio che ha deciso di essere unico, il lone hero della situazione, colui che potrà salvare tutti. Ma la ciurma non accoglierà questa visione binaria perché nel mondo post-apocalittico di Saltsea non c’è élite, ma l’esperienza diretta del quotidiano, e la generosità che porta con sé.
Home is where art is
Home is where art is è una frase che incontriamo a Fort Alcazar. L’arte ci fa sentire a casa, ma in quale casa? Con Saltsea Chronicles, Die Gute Fabrik ha costruito una casa che è spazio per le comunità, per un’esplorazione collettiva e personale del mondo e del futuro. Ed è la collettività ad offrirci sprazzi di positività in quel presente, e nel nostro futuro.
Nel suo blog Cosmic Anarchy, Ayesha Khan si chiede come sia possibile che in Palestina, nelle settimane terribili dall’inizio del genocidio, la speranza sia ancora presente mentre nei movimenti occidentali questo sentimento fatichi a sopravvivere. La risposta che trova è nella permanente presenza dell’idea individualista di obiettivo, di achievement (termine pervasivo nel mondo videoludico e nella gamification) personale e a breve termine. Idea che l’attivismo bianco e liberale ha importato dalla società che critica nel suo modo di agire, rispetto alla visione comunitaria e collettiva dei movimenti di liberazione palestinese.
L’individualismo delle narrazioni post-apocalittiche come nell’attivismo occidentale spinge a raggiungimenti immediati, una dimostrazione rapida ed evidente del nostro successo. Nessuna grande causa però si risolve in pochi mesi di lotta, e questo ci può portare alla delusione, alla frustrazione, alla convinzione che tutto sia perduto. E cediamo allora al fascino dell’apocalisse invece di accogliere quella visione comunitaria dell’agire che Khan ritrova nell’attivismo palestinese, quell’agire con l’idea che forse non si vedranno nella propria vita i risultati di tale impegno, ma la comunità tutta ne uscirà arricchita, forte.
La speranza resiste nella collettività, e resiste lontano dal fascino di distopie e apocalissi perché, citando Chthulucene di Donna Haraway, l’apocalisse è uno spazio autoindulgente. Continuare a narrare che siamo spacciati, che non c’è futuro, spinge alla non azione, oltre ad offrire una sponda alla deresponsabilizzazione politica (esempio rapido: dopo l’alluvione in Romagna la politica ha messo l’accento quasi esclusivamente sulla catastrofe climatica, e non sulla terrificante cementificazione che ha esasperato gli effetti delle piogge anomale).
Per questo come facciamo arte e come narriamo, conta. Solnit sin dall’inizio del suo libro ci dice: «Ciò in cui credi forma il modo in cui agisci». Se crediamo che il futuro sarà una lotta costante tra poveracci per la sopravvivenza in un mondo distrutto dalla crisi climatica, continueremo a trattare l’altro come un’avversario, ad affidarci a forme di governo sempre più autoritarie. E scriveremo storie che rafforzeranno questi futuri validando ancora di più gli isolamenti e le repressioni del presente.
Se decidiamo di immaginare e raccontare storie che guardano al reale, e non alle paure delle élite, allora avremo davanti un memento costante di quanto siamo comunitari, supportivi nei momenti di difficoltà. Di come l’istinto non sia lupo mangia lupo, ma un intrecciarsi di mani e storie, di voci. E come nel Saltsea, nel disastro sarà l’attuale sistema a crollare, e a riemergerne, la nostra umanità.
Leggi tutti i nostri articoli sui videogame