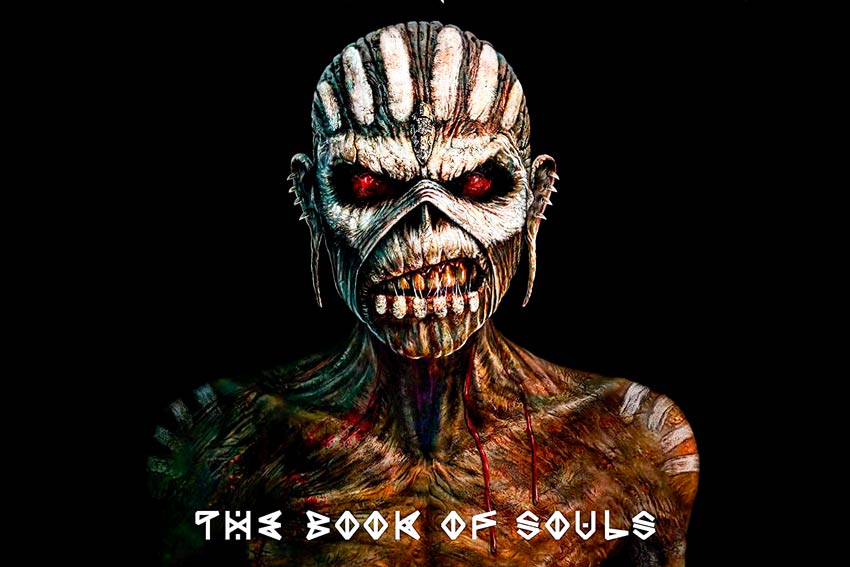Il vecchio dizionario della lingua italiana che mi ritrovo in casa[1] riporta la seguente definizione della parola “serendipità”: «Lo scoprire qualcosa di inatteso e importante che non ha nulla a vedere con quanto ci si proponeva di trovare o con i presupposti teorici sui quali ci si basava.» In un mondo migliore di questo, un dizionario potrebbe con altrettanta efficacia adottare la semplice e brillante definizione di serendipità coniata dal medico Julius Comroe: «Serendipità è cercare un ago in un pagliaio e trovarci dentro la figlia del contadino». È la stessa cosa, ma detta meglio.
Ora, da un po’ di tempo “serendipità” è una parola che ha rotto le palle.
Inserita in improbabili slogan che vogliono puzzare di alternativo senza averne la sostanza, è usata ovunque e spesso a sproposito, nell’errata e semplicistica accezione di “piacevole scoperta” che, sebbene sia parte integrante della definizione originaria, non ne copre però tutto lo spettro semantico. Cercare un bar che faccia degli strepitosi cornetti alla ciliegia e, finalmente, trovarlo non è serendipità; uscire di casa per andare dal parrucchiere, trovarlo chiuso, entrare nel bar di fianco per chiedere perché il parrucchiere sia chiuso e, in quel momento, scoprire che il bar vende degli strepitosi cornetti alla ciliegia è serendipità.
Nel primo caso si sta cercando una cosa e la si trova, nel secondo caso si sta cercando qualcosa di ben preciso e, mentre lo si sta cercando, si scopre tutt’altra cosa. Entrare in quel bar il giorno successivo con l’intenzione di spararsi un altro cornetto alla ciliegia e trovarlo, caldo e fumante, ad aspettarti al bancone non è serendipità. Entrare in quel bar per spararsi un altro cornetto alla ciliegia e finire col pomiciarsi la cameriera è serendipità.
Il termine italiano “serendipità” è una parola d’importazione, che trasporta quasi alla lettera nella nostra lingua l’originale inglese “serendipity”. Fu coniato dallo scrittore Horace Walpole in una lettera datata 28 gennaio 1754, e per evitare che il destinatario della lettera non ne capisse il significato – c’è sempre un po’ questo rischio, con le parole che non esistono – il provvido Walpole si sentì in dovere di spiegarglielo in breve con queste parole:

Questa scoperta, invero, è quasi di quel tipo che io definisco “serendipità”, una parola molto espressiva che, non avendo niente di meglio da raccontarti, ora mi proverò a spiegarti: la comprenderai meglio conoscendone la derivazione piuttosto che la definizione. Una volta lessi una sciocca favola intitolata “I tre principi di Serendippo”. Mentre le loro altezze reali erano in viaggio facevano sempre nuove scoperte, grazie a vari accidenti e alla loro sagacia, di cose che non stavano cercando: uno di loro, per esempio, scoprì che un mulo orbo di un occhio aveva percorso la loro stessa strada poco tempo prima solamente perché l’erba [che cresceva sui due lati della strada] era stata mangiata solo sul lato sinistro […][2].
Walpole scelse uno strano esempio per spiegare la sua nuova parola: oggi saremmo più portati a far rientrare un episodio del genere nell’ambito della deduzione piuttosto che in quello della serendipità. Qualche riga più avanti, tuttavia, lo scrittore precisava che “nessuna scoperta di un qualcosa che stai già cercando può rientrare in questa definizione”, ed è da questa affermazione che facciamo derivare il moderno significato della parola. C’era però, in questa simpatica invenzione fresca di conio, qualcosa che sfuggiva al suo stesso inventore, e cioè la complessa storia che sta alla base della sua origine: quella storia dei tre principi di Serendippo[3] che, con buona pace di Horace Walpole, tutto era tranne che una “sciocca favola”.
Con un brusco salto temporale trasferiamoci al 1557, allorché un misterioso personaggio consegnò allo stampatore veneziano Michele Tramezzino un manoscritto affinché ne giudicasse il valore letterario in vista di un’eventuale pubblicazione. Presentandosi ai suoi lettori come Cristoforo l’Armeno, il personaggio in questione aveva aggiunto al manoscritto una prefazione in cui spiegava che, avendo fatto tappa a Venezia lungo il cammino per la Francia, era rimasto a tal punto affascinato dalla bellezza della città da decidere di fermarsi a soggiornarvi per qualche anno.
Cristoforo di sicuro non era ricco; aveva trovato alloggio in quello che probabilmente era all’epoca una specie di ostello gratuito per pellegrini, ed era stato tra quelle mura che, “come per via di diporto”, si era messo a tradurre in italiano con l’aiuto di un anonimo amico un’antica favola del suo paese; pochi mesi dopo, nella sua edizione a stampa, Tramezzino vi avrebbe apposto il titolo di Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo[4].
Null’altro sappiamo dell’autore[5], ma molto di più possiamo dire sulla sua bellissima favola. Quel che Cristoforo definiva un racconto tradizionale del suo paese era in realtà un pot-pourri di storie di varia provenienza, che i cantastorie d’Armenia avevano forse cominciato a intrecciare tra loro dopo averle udite raccontare dai loro colleghi persiani: dato che ai tempi l’Armenia era soggetta all’autorità della Persia dei Safavidi, una simile forma di contaminazione letteraria non deve stupirci.
Protagonisti della nostra storia sono tre principi indiani figli di Giaffer, re di Serendippo, che per metterli alla prova in vista della loro futura ascesa al trono, finge di sdegnarsi con loro esiliandoli dal proprio regno. Senza perdersi in futili piagnistei, i tre saggi giovani prendono la via dell’esilio, giungendo entro i confini di un vasto impero governato dal saggio re Beramo.
Costui altri non è che Bahram Gor, potentissimo imperatore che regalò alla Persia uno dei suoi momenti di splendore nel V secolo d.C., lasciando nei secoli successivi una memoria di sé che, al pari di quanto accaduto con Alessandro Magno, si mescolava spesso e volentieri con leggende, aneddoti e dicerie tanto avvincenti quanto fantasiose. Torneremo tra poco sulla sua figura, ma per ora restiamo con i nostri principi indiani che “abbattutisi un giorno in uno gambelliere, a cui era fuggito uno gambello, furono da lui dimandati, se per aventura quello nel camino veduto havessero”.
I principi non l’avevano visto, il cammello. Ma erano persone intelligenti e sagaci, e lungo la strada appena percorsa avevano notato nel paesaggio alcuni segni dai quali avevano capito che non solo il cammello era passato di lì, ma che il suddetto animale era anche zoppo, sdentato e cieco di un occhio, oltre ad essere carico d’una giara di burro, di una di miele e di un insolito passeggero: una donna incinta. Quanto dedotto dai principi riguardo all’animale era tutto vero[6], ma percorrendo la strada a ritroso il gambelliere non l’aveva potuto ritrovare, e aveva denunciato alle autorità i tre piccoli saccentoni perché si era fatto persuaso che gliel’avessero fregato.
Da questo buffo equivoco hanno origine le avventure dei principi, che una volta liberi dalla falsa accusa diverranno gli uomini di fiducia dell’imperatore in persona. A loro Beramo affiderà la delicata missione di andare a recuperare uno specchio magico appartenuto ai suoi antenati, finito nelle mani di una bellissima regina indiana che a sua volta si avvarrà della consulenza dei principi in un frangente di estrema gravità. L’episodio in questione è esemplare della varietà delle fonti cui questa lunga favola deve la sua origine, ed è troppo bizzarro perché lo si possa tralasciare in questa pur breve sinossi.

Il regno della giovane sovrana è flagellato da una terribile piaga, che non le usa nemmeno la cortesia di risultarle comprensibile: si tratta di una mano gigante che ogni anno sorge dall’acqua del mare e che, dopo esser rimasta ferma lì con le cinque dita alzate per l’arco di un giorno intero, torna a inabissarsi portando con sé il primo uomo che le capiti a tiro. Nessuno, logicamente, ci capisce una fava. Nessuno tranne uno dei nostri tre principi, che invece si presenta davanti alla mano mettendo bene in vista la propria mano destra con indice e medio alzati: a quel punto la mano si inabissa definitivamente.
Perché? Perché le cinque dita della mano altro non significavano se non che “ove cinque huomini d’uno medesimo volere si fussero ritrovati, serebbeno a prendere il mondo tutto stati bastevoli.” Il principe non era della stessa idea, e alzando due dita aveva invece voluto risponderle che, per conquistare il mondo intero, sarebbero bastati gli sforzi congiunti di due soli uomini concordi in opere e in pensieri[7].
Questo episodio, per quanto mi risulta, non ha paralleli nella letteratura occidentale, ma non è stato inventato né da Cristoforo né da chiunque Cristoforo abbia sentito raccontare la sua favola. Si ritrova invece in un antico poema in sanscrito, il Kathāsaritsāgara (Oceano dei fiumi delle storie) scritto dal brahmano Somadeva circa sei secoli prima della nascita del nostro sfuggente armeno. La sua versione è meno cruenta: la mano è una mano umana di normali dimensioni che sbuca fuori dal Gange attirando l’attenzione del re dell’India, e l’enigma della sua apparizione viene risolto dal geniale consigliere Vararuci.
La risposta data da Vararuci alla mano, tuttavia, è la stessa[8]. Questo non significa, naturalmente, che nella Persia del XVI secolo qualcuno si ricordasse ancora del poema di Somadeva, ma mostra come le storie intrecciate da Cristoforo attingessero a un patrimonio narrativo eterogeneo e, in casi come questo, assai più antico.
Che dire, poi, della seconda parte della favola? In essa, con un repentino cambio di prospettiva, i principi di Serendippo – che pure danno il titolo all’intero libro – spariscono completamente dalla scena. L’attenzione dell’autore si focalizza invece sull’imperatore Beramo che, disperato per la perdita della sua favorita Diliramma, da lui a torto creduta morta, fa costruire sette magnifici padiglioni le cui meraviglie possano distrarlo dal suo dolore. Ognuno dei padiglioni è di un diverso colore, ognuno è consacrato a un diverso pianeta e ognuno ospita al suo interno un valente musico e una bella figliola esperta di antiche storie: le novelle raccontate da queste fanciulle all’imperatore riempiono una buona metà del libro di Cristoforo, eclissando del tutto le vicende dei tre protagonisti.
Anche questa idea, il nostro armeno non la partorì da solo. La storia di Bahram Gor e dei sette padiglioni, infatti, era già stata nei secoli precedenti al centro di diverse narrazioni in lingua persiana. La più famosa di tutte era stata quella splendidamente elaborata da un poeta del XII secolo, Nizami di Ganja[9], che aveva fatto di questa vicenda il fulcro del suo Haft Paykar (Le sette bellezze)[10]. Le novelle raccontate dalle fanciulle nelle due versioni della storia erano completamente diverse, e diverse erano anche le stesse fanciulle: nella versione di Nizami esse erano le sette spose di Bahram, non le prezzolate etére portate in scena dal libro di Cristoforo. L’idea tuttavia era la stessa, perfettamente riconoscibile perché, nella sostanza, quasi del tutto identica.
Non c’è uno solo, in realtà, tra gli episodi della storia dei tre principi di Serendippo che non abbia precisi parallelismi nella letteratura di altri tempi o di altri paesi[11], ma questa caratteristica è ben lungi dall’essere un difetto. La favola di Cristoforo viene così ad essere per noi una sorta di compendio, una di quelle storie che i poeti persiani avrebbero certo paragonato a una collana di perle intrecciate tra loro con gusto squisito. Non certo a un volgare miscuglio di storielle da trivio, comunque. Non certo alla “sciocca favola” che, ai suoi tempi, Walpole non aveva ancora gli strumenti culturali per apprezzare.
Ma fermiamoci qui, sperando che questa antica favola sia stata per voi motivo d’interesse, cortesi lettori. Chissà come avete fatto a scovare questo articolo, poi. Magari avete aperto la homepage della Sepoltura della Letteratura perché speravate di trovarci un articolo nuovo, e siete stati accontentati. O magari stavate vagando per l’internet cercando tutt’altro, quando siete incappati in questa pagina. Mi viene quasi da sperare che l’abbiate trovato in questo secondo modo, però. Dopotutto, credo che l’idea di aver trovato la serendipità grazie alla serendipità potrebbe risultarvi molto più divertente.