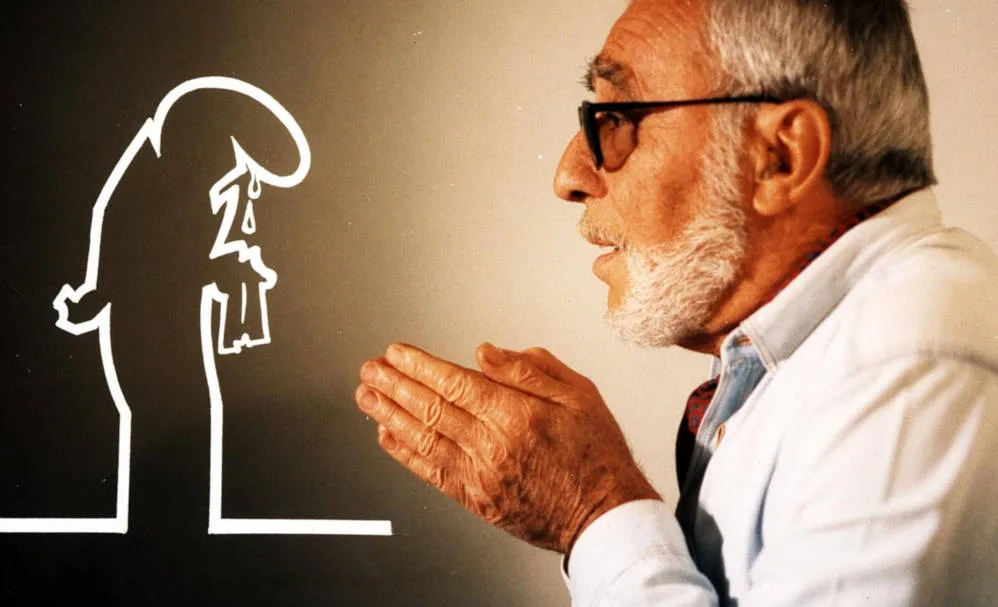«Ci sono tre tipi di persone: quelli di sopra, quelli di sotto, e quelli che cadono»: si apre con quest’affermazione a metà tra il criptico e il didascalico El Hoyo, film del 2019 diretto dal regista basco Galder Gaztelu Urrutia, fruibile in questi giorni sulla piattaforma di film in streaming Netflix.
Tutto il film ruota attorno a un’idea squisitamente semplice, lineare, e coerente con se stessa: quella di una prigione all’interno di un mondo distopico, dalle coordinate temporali indefinite, che oltre ed entro la simbologia potremmo leggere come appendice del nostro stesso presente, con un struttura verticale a piani e due persone a popolare ogni piano.
Fino a qui la metafora sospinge a una prima (verrà poi meglio dispiegata e portata a compimento durante l’arco del film) attualizzazione di concetti in correlazione quali gerarchia, controllo, ordine, che sembra avere un antenato filosofico ben preciso nel Panopticon: modello di carcere ideale teorizzato nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham, dotato di una torre centrale con all’interno un guardiano e di una serie di celle disposte tutte a cerchio, di modo che una finestra delle due finestre della cella si affacci sempre sul guardiano.
Il Panopticon diventerà, grazie ad approfondimenti teorici successivi, potente metafora di un potere capace di imporre un controllo subdolo anche quando assente. Uno degli assunti di Bentham formula che, anche qualora il guardiano si assentasse, i prigionieri per norma interiorizzata continuerebbero ad agire come se posti ancora sotto sorveglianza e così anche in questo film, dove sembra venir ripresa e ampliata la carica simbolica e ideologica del modello benthamiano.
Questa prigione ha infatti un’ulteriore caratteristica, straniante al punto da potersi considerare a ragione quasi Al di là del Bene e del Male: a distribuire il cibo ai carcerati è una piattaforma mobile che, una volta al giorno, partendo dal piano 0 discende dall’alto verso il basso sostando due minuti a piano. I carcerati possono mangiare solo durante questo spazio di tempo senza poter detenere oltre il cibo (pena il morire per il troppo caldo o troppo freddo, condizioni attivate nella cella quando un prigioniero cerca di trattenere qualcosa) e una volta al mese sono assegnati randomicamente a un piano differente; piani che il protagonista scoprirà solo alla fine essere 333, che moltiplicati per la coppia di prigionieri ad ogni piano ci restituiscono nel numero risultante 666 una metafora di sapore dantesco.
Ma c’è un inghippo: il cibo non basta mai per tutti. I prigionieri ai piani superiori infatti fagocitano voracemente quanto più riescono ad accaparrarsi non lasciando niente ai piani inferiori, che sembrano stagliarsi sotto di loro aprendo una voragine di profondità infinita. E a nulla servono la memoria della fame e la consapevolezza che al giro successivo potrebbe essere riassegnato un numero basso: quando i prigionieri si trovano ai piani superiori la loro unica preoccupazione sembra essere quella di abbuffarsi rinvenendo dai morsi della fame patiti, secondo uno schema quasi irrazionale ricalcato e riassunto dai dialoghi dei personaggi.
Come quello tra il protagonista Goreng (interpretato dall’attore Ivan Massagué) e il suo primo compagno di cella che ai suoi tentativi di comprendere perché nessuno nella prigione tenti di instaurare un sistema equo di distribuzione a porzioni, che permetta di mangiare a tutti, risponde cinico che è ovvio: perché quelli che stanno sopra stanno sopra e quelli che stanno sotto stanno sotto. Una logica al di fuori di questa non è contemplata, come non è contemplata la possibilità di un’azione alternativa, e anzi tutta la natura del male, compresi gli atti di cannibalismo, di stupro e violento assassinio e di deturpazione del cibo, viene scorporata e trasferita al Buco e alla sua essenza, in una deresponsabilizzazione totalizzante.
Homo homini lupus d’ascendenza hobbesiana o ottusità morale cagionata da (a leggere tra le righe) consumismo sfrenato e gerarchie date per buone perché ossificate, calcificate, grazie all’azione di un sistema apparentemente compiacente ma in realtà inesorabile nel suo perpetrare orrende iniquità sociali?
Ci addentriamo ancor più nella metafora a notare i contrasti, i chiaroscuri presenti in questa pellicola; come quello generato dalla sontuosità del banchetto, dalla sovrabbondante ricchezza prodotta da uno staff d’élite non meglio definito che con l’epiteto di “L’Amministrazione”, che si coordina internamente come un’equipe di chef stellati nella cui cucina è bandito il seppur minimo errore.
Come bravi cadetti dell’alta cucina si preoccupano persino di cucinare i piatti preferiti dei carcerati, che verificano grazie a un sondaggio che sottopongono loro all’ingresso nella prigione. Piatti i cui rimasugli si vanno irrimediabilmente a mescere con sangue e carne umana, con piatti rotti per fungere da armi, con sputi e feci in segno di denigrazione verso gli altri compagni di prigione. In una parabola al contrario in cui il tuo vicino più è vicino e più nemico, e la fatidica “Amministrazione” non riceve menzioni se non per essere invocata a mo’ di amuleto apotropaico che avrà l’onere ma anche il merito alla fine della prigionia, di consegnare loro un cosiddetto “attestato di permanenza” che sembra essere più che oggetto reale un oggetto-simbolo, un signum dalla natura grottesca.
Solo alcuni personaggi manifestano moti di ribellione: una madre che ha perso la sua bambina ed è intenta a ritrovarla salendo sulla piattaforma e scendendo di piano in piano, fronteggiando gli assalti e la fame (in modo spesso più brutale degli assalitori stessi, come quando sventra un cane), un’ex dipendente dell’”Amministrazione” che si è risolta per un auto-confinamento, in quanto malata terminale disposta a sacrificare gli ultimi mesi della sua vita per provare a invertire le dinamiche della prigione, e infine l’ultimo compagno di cella di Goreng che prova a risalire i piani con una corda.
L’ex dipendente, Imoguiri, è colei che tenta più tenacemente, e si spinge a rivelare al protagonista che l’instaurazione di un “sistema di solidarietà spontanea” è la ragione stessa e lo scopo ultimo dell’esistenza della prigione. Tutti i tentativi saranno destinati a fallire e a cadere nella disillusione e nella morte, e soltanto un ultimo signum, questa volta salvifico e catartico potrà lanciare una breccia dall’altra parte dell’abisso: l’innocenza della bambina dispersa, ritrovata da Goreng e Baharat all’ultimo piano, il numero 333. A dirci che forse soltanto il volto di un bambino è immune dalle brutture dell’essere umano.
Un film, El Hoyo, in grado di stare entro i confini di un genere – l’horror – eppure di travalicarlo per lanciarci un messaggio dissacrante, e quanto mai attuale, sul nostro vivere comune.