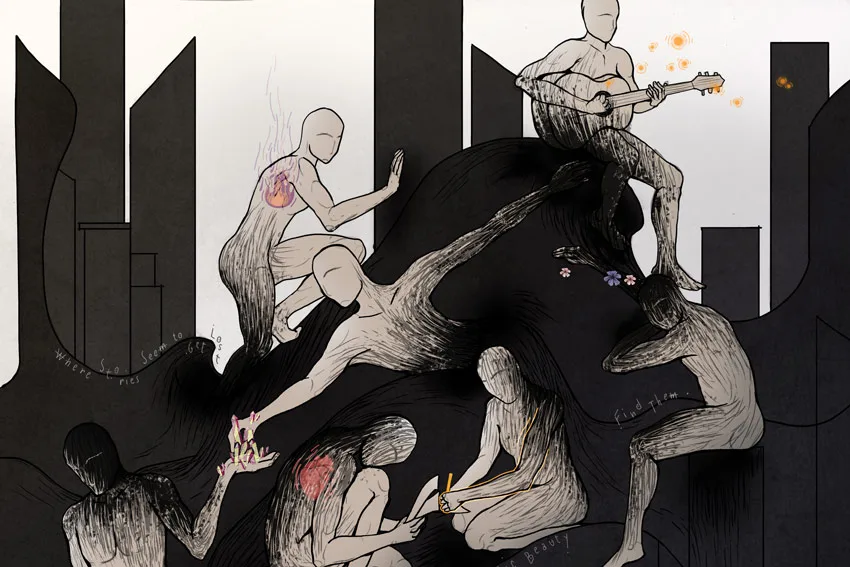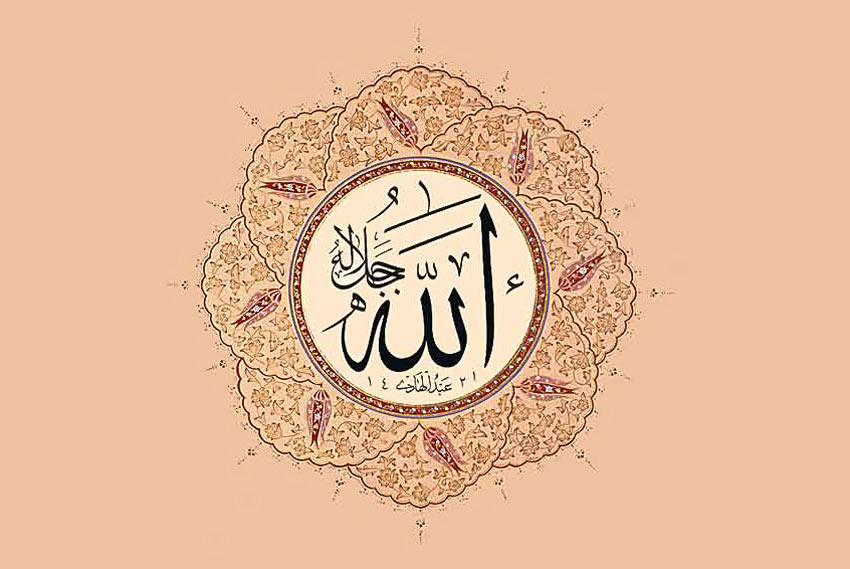Noi europei abbiamo un rapporto peculiare con il vuoto. Un rapporto conflittuale, potremmo dire, al punto che, per descrivere alcune tendenze che appaiono a macchia di leopardo nella nostra storia dell’arte, il critico Mario Praz coniò il termine horror vacui, terrore per il vuoto. Dai libri miniati, come quello irlandese di Kells, all’arte longobarda, così come nella scultura gotica di Giovanni e Nicola Pisano, per non parlare poi dell’esuberanza barocca e rococò, l’arte europea è infatti costellata dal tentativo incessante di riempire tutti gli spazi possibili, tutti gli interstizi, senza lasciare alcun margine di respiro.
Si potrebbe ipotizzare che alla tendenza cristiana nel concepire il mondo e la materia come corrotti dal peccato si sia affiancata invece una tendenza totalmente opposta: la tendenza a ricoprire ogni cosa di materia, a rifuggire la vacuità, il vuoto. Anche la lotta del cattolicesimo contro l’iconoclastia ha avuto l’effetto di riempire chiese e altari di figure, croci, immagini votive. Così come il culto dei santi, che rende il cattolicesimo un monoteismo alquanto singolare, se visto dagli austeri occhi di un ebreo o di un musulmano.
È per queste ragioni che il rapporto tra le filosofie orientali e il vuoto ci risulta alquanto nuovo ed esotico: noi siamo figli dell’horror vacui, siamo figli di una cultura che ha sempre tentato di riempire ogni spazio, che ha fatto dell’abbondanza un culto. L’idea invece che il vuoto sia una risorsa, qualcosa di prezioso, è per noi un concetto controintuitivo, affascinante ma difficile da accettare: la nostra cultura ha avuto terrore, non amore per il vuoto.
Sarebbe erroneo pensare all’estremo oriente come a una totalità omogenea, e infatti nella scultura e nell’architettura della penisola indiana e nel sud est troviamo un grande rigoglio di statue, raffigurazioni, decorazioni, rilievi e inserti che potremmo accostare al nostro concetto di horror vacui, ma è un dato che la maggior parte delle grandi filosofie orientali invece sviluppa un concetto alquanto positivo del vuoto, che in Giappone diventa addirittura una forma di amore.
Ad aiutarci nel comprendere questo rapporto c’è un libretto, contenuto nelle dimensioni ma piuttosto denso, di Giangiorgio Pasqualotto, Estetica del vuoto, che ripercorre l’idea del vuoto dall’India al Giappone, soffermandosi sul concetto di vacuità per i taoisti e per le mille forme del Buddhismo. Queste religioni sono infatti imperniate su questo concetto. Il capitolo XI del Tao Tê Ching dice, infatti:

Si ha un bel riunire trenta raggi in un mozzo, l’utilità della vettura dipende da ciò che non c’è.
Si ha un bel lavorare l’argilla per fare vasellame, l’utilità del vasellame dipende da ciò che non c’è.
Si ha un bell’aprire porte e finestre per fare una casa, l’utilità della casa dipende da ciò che non c’è.
Così, traendo partito da ciò che è, si utilizza quello che non c’è[1].
Come al solito il significato è abbastanza criptico, ma lo possiamo facilmente sciogliere: il significato letterale del testo è l’inutilità del lavoro umano senza il vuoto. Se il vaso non fosse cavo, non servirebbe a nulla; se una casa non fosse vuota non ci si potrebbe vivere. Vediamo subito come il vuoto non coincida con il non-essere: non è il nulla assoluto.
La nostra filosofia, nata con il filosofo della Magna Grecia Parmenide, divide strettamente tra essere e non-essere: l’essere è, il non essere non è. Il passaggio dall’essere al non-essere, e viceversa, è uno dei nodi più problematici e fecondi della filosofia greca. Invece qui non abbiamo nulla di tutto questo: si tratta di una concezione spaziale del vuoto, molto più simile all’idea di vuoto della fisica di Democrito, per esempio. Il vuoto non è il nulla: è semplice spazio vuoto.
Ma c’è un passaggio ulteriore: nel taoismo il vuoto e il pieno instaurano un rapporto dialettico: sono anch’essi gli opposti che si parlano e interagiscono tra loro. Un vaso è tale sia grazie all’argilla che ne delimita una forma, sia grazie al vuoto che è dentro di esso e che lo rende utile: il vuoto è concepito in una relazione funzionale. Ed è un pensiero di una modernità sconcertante per uno scritto di circa mille e cinquecento anni fa: in Europa per questo periodo di tempo si penserà allo spazio come un’entità a se stante, geometrica, fino alla perfezione della fisica newtoniana. Lao Tzu aveva intuito già da molto tempo la parzialità di queste posizioni: non si può dare importanza solo a «ciò che è», ma anche a ciò che non è, al wu, e questi si devono concatenare l’uno all’altro, in un mutuo rapporto.
Di diverso tenore, ma non di inferiore importanza, è il vuoto nel Buddhismo. La religione Buddhista si è sviluppata nei secoli in mille forme e in mille modi, ma nessuna ha rinunciato all’idea che il buddismo sia vacuità. Ma cosa intendono i buddhisti con vacuità? Non è esattamente il vuoto spaziale, è un vuoto costitutivo, molto più simile al nulla assoluto, ma non assimilabile al nulla del nichilismo europeo. C’è un testo, il Sutra del Cuore, che ne parla esplicitamente, e con una bellezza e un’attenzione per la parola che lo rendono uno dei mantra più affascinanti del Buddhismo:

Iha Sāriputra rūpam śūnyatā śūnyataiva rūpam.
Qui, o Sāriputra, la forma è vacuità e proprio la vacuità è forma[2].
Ritorna qui il rapporto dialettico: la forma è caratterizzata dalla vacuità e viceversa. Ma qui il discorso è molto più complesso e articolato, in quanto vuoto e pieno, nel taoismo, sono uno dei tanti opposti, sono uno dei tanti modi di chiamare le infinite vie del Tao: qui invece l’alternanza dialettica indica un’intrinseca vacuità della materia: siamo molto più vicini alla celebre formula del Qoelet «havel havalim, hakol havel» (che potrebbe essere tradotta con: tutto è vapore, fuggevolissimo vapore) e si lega a doppio filo al concetto buddhista di «impermanenza».
Il mondo, infatti, è in continua evoluzione, in continuo cambiamento e ciò provoca dolore nell’uomo. L’essenza, quella chimera che la filosofia occidentale ha ricercato per secoli, per i buddhisti semplicemente non esiste. La materia, che ci sembra tanto concreta, è vuota al suo interno, perché ogni cosa muta e si trasforma. Le cose non esistono, esistono solo le relazioni tra le cose. E questo, tra l’altro, è l’approdo a cui arrivarono, alla fine, anche pensatori occidentali antitetici come Hegel e Nietzsche, e a cui sta arrivando anche la fisica contemporanea, come ha mostrato Carlo Rovelli, tra l’altro citando proprio un filosofo indiano, Nagarjuna.
L’essere umano, dunque, non può arrivare al fondo delle cose, non può concepirle come essenze, come oggetti fermi e stabili. Dunque, cosa può fare? Secondo il Buddhismo, la via è la contemplazione. Attraverso di essa, il saggio supera l’impermanenza, la paura del cambiamento e anche del supremo cambiamento, la morte. Il Buddhismo dunque in questa analisi acquista un carattere soterico di cui il Taoismo è privo: per il taoista la contemplazione è infatti semplicemente parte dell’esistenza, o il modo più bello e proficuo per noi di condurre l’esistenza. Per i buddhisti, invece, si tratta di salvarsi dal dolore del mondo. Pasqualotto, a questo proposito, segnala un passo del Sutta Nipāta, altro fondamentale testo buddista, estremamente interessante da questo punto di vista:
«Contempla il mondo come vacuità, o Mogharajan, sempre restando rammemorante» – così disse il Beato. Avendo distrutto la teoria di se stesso si giungerà a superare la morte; il dio della morte non vedrà colui che in tal modo contempli il mondo[3].

E qui abbiamo l’ultimo passaggio fondamentale, quello che a noi occidentali, impregnati di riflessione e pensiero, proprio non va giù: l’idea della distruzione della teoria in se stessi. La religione buddhista ha infatti come suo centro la diffidenza nei confronti dei desideri. I desideri sono sì degli strumenti potenti, che permettono agli esseri umani di raggiungere obiettivi e traguardi, ma i desideri imprigionano a sé: chi desidera è schiavo del suo desiderio. E anche il sapere è un desiderio, un desiderio potente e accecante.
Il buddhismo, e il buddhismo zen in particolare, mostra con una radicalità impressionante (e per noi difficile da accettare del tutto) che conoscere, in senso intellettuale, razionalistico, si rivela illusorio e pernicioso per l’essere umano. Eppure lo zen parla di illuminazione, il famoso satori: uno stato in cui si conosce, si comprende davvero l’esistenza. Ma è qualcosa di molto diverso da un sapere intellettuale.
C’è una famosa storia zen a riguardo. I buddhisti zen, infatti, preferiscono lasciare alle storie le loro idee, che non a trattati e spiegazioni: il linguaggio è uno strumento povero e spuntato, e basarsi su di esso, secondo lo zen, non porta a soluzioni. Quello che si può fare, invece, è trasmettere quel qualcosa, quel quid che va oltre il linguaggio stesso, che va oltre le parole. E questo è qualcosa che solo l’arte e le storie possono fare.
C’era una volta uno studente, uno studente di quelli brillanti, capaci, di grande intelletto. Uno studente che aveva un solo obiettivo e un solo desiderio: raggiungere l’illuminazione. Fu così che questo studente lesse tantissimo, lesse e lesse tutti i sutra, e li comprese e li fissò nel proprio cuore. Ma non ricevette l’illuminazione. Allora andò in un monastero, e pregò i monaci di prenderlo con sé, e lavò il monastero, e lo pulì, e servì per anni il monastero in tutto e per tutto, con obbedienza e dedizione. Ma non ricevette l’illuminazione.
Allora divenne un eremita, e andò a vivere su una montagna. All’inizio leggeva i sutra e ripeteva i mantra, e si sforzava di contemplare la natura meglio che potesse, con tutte le sue forze. Poi, con il passare degli anni, perdette d’interesse per i sutra, che sbiadirono nella sua mente, e dimenticò la dedizione con cui aveva servito il monastero, e dimenticò gli sforzi nel contemplare la natura, e dimenticò, alla fine, il motivo stesso per cui era diventato un eremita. Ed ecco che, un giorno qualunque, in un’ora qualunque, quando il sole faceva vibrare l’erba come in tutti gli altri giorni, passeggiando, l’eremita urtò per caso un sasso, che colpì una canna di bambù. E fu così che ebbe l’illuminazione.
Aveva fatto il vuoto nella sua mente.
Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche Lo haiku: racchiudere il mondo in un solo verso
In copertina: Michael Kenna, Torii, dalla serie Visions of Japan. Michael Kenna è uno dei più grandi fotografi inglesi, noto per le sue lunghe esposizioni (anche dieci ore) e per le foto eteree e in bianco e nero. Il suo intento, soprattutto nelle opere scattate in Cina e in Giappone è scattare degli “haiku fotografici”, che esprimano la vacuità dei suoi soggetti.