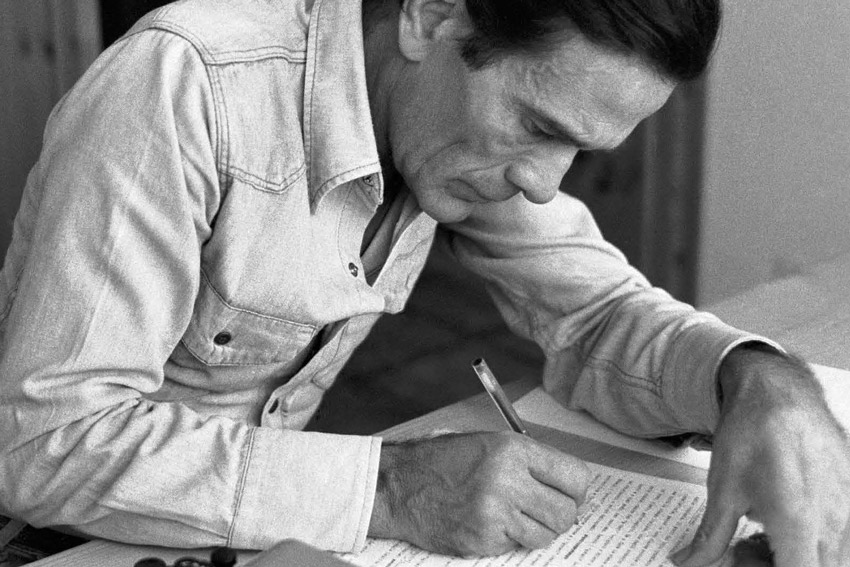Immaginiamo di avere un bel piatto di pasta rosseggiante di sugo di pomodoro. Ce l’abbiamo lì davanti agli occhi, con il fumo caldo che si alza dalla tavola, e la mamma, appena uscita dalla cucina, dice con voce ferma: «Ecco caro, ora mi fai l’elenco degli ingredienti».
È precisamente quanto avviene a ogni ragazzino che a scuola si trovi davanti a una poesia. La richiesta può prendere sfumature differenti, da «Fammi la parafrasi» (richiesta base, senza fronzoli) a «Fammi l’elenco delle figure retoriche» (richiesta livello pro, per intenditori) ma la sostanza è questa: invece di mangiare, si analizza, si seziona, si scompone. Tutte operazioni lodevoli, se si vuole imparare a cucinare, un po’ meno se non sappiamo nemmeno come si mangia, e se valga la pena ingollarsi proprio L’infinito di Leopardi.
La poesia è un oggetto difficile da afferrare, in effetti. Assomiglia alla nebbia, che da lontano è compatta, ma quando ci sei dentro si dirada talmente tanto da non notarla quasi più. Ha la stessa consistenza del vento, delle cose minute e labili.
È sì un discorso, come tutti gli altri in apparenza; eppure c’è qualcosa di non immediato. Non basta leggerla, una poesia. Né una, né due, a volte nemmeno tre volte. Prendiamo proprio l’Infinito, che conosciamo quasi tutti, è la Gioconda della poesia: leggendolo così, superficialmente, non è che ci dica molto. Leopardi se ne sta seduto su una collina, dietro una siepe e pensa all’infinità del tempo, dello spazio, e i suoi pensieri si perdono nell’infinità delle cose. Tutto qui, fine. Non è una lettura che ci arricchisca in qualche modo di informazioni, di dati. Non è un saggio sull’ultima guerra o un libro su un qualche popolo antico, e non è nemmeno un discorso sull’infinito: se uno volesse capire cos’è l’infinito troverebbe risposte molto più precise leggendo Cantor, per esempio, che non Leopadi.

La poesia, infatti, non ha il compito di comunicarci qualcosa, ma di farcelo provare. Come tutte le arti, non è riducibile al suo mero contenuto, ai dati che contiene, e in questo caso è ancora più evidente. A rendere L’infinito così perfetta, così inarrivabile, è proprio questa capacità di farci immedesimare nelle parole del poeta. Se ci facciamo cullare dai suoi versi lo sentiamo anche noi, l’infinito. Non sappiamo spiegarlo, magari; non sappiamo cosa sia, ma lo sentiamo, e sentiamo cosa poteva provare Leopardi in quel momento.
Ecco, la poesia (e questo vale per tutte le arti, in realtà) non è un comunicare nel senso di trasferire informazioni, ma un trasferire impulsi emotivi: è un telegramma, non una lettera. Come il telegrafo muta le lettere dell’alfabeto in segnali Morse, così le sensazioni del poeta sono tramutate in parole, in versi e strofe, e tocca a noi decodificarli.
Per questo la poesia è tanto difficile: ne abbiamo smarrito il codice.
I versi, le figure retoriche, gli accenti, le rime e le assonanze non sono un modo per arricchire un testo che andrebbe benissimo anche se fosse scritto in prosa, senza andare a capo: sono come i colori e le ombre per un pittore, come i campi e i controcampi per un regista. Sono la tecnica, il codice che serve a trasmettere il messaggio: un messaggio che si differenzia rispetto a quello di un saggio, di un articolo di giornale per essere un messaggio emotivo. Sono le sensazioni il vero messaggio, in poesia, non i contenuti razionali.
Ed è per questo che la poesia si avvale di un codice diverso da quello della prosa; per questo è scritta in versi, e va a capo tanto spesso. Questo codice ha la funzione (o forse la pretesa) di stabilire delle connessioni sensoriali con chi fruisce della poesia. E queste connessioni sono date dai suoni delle parole. L’impasto delle vocali e delle consonanti, il loro suonare insieme, dà un’altra luce e un altro significato al testo.
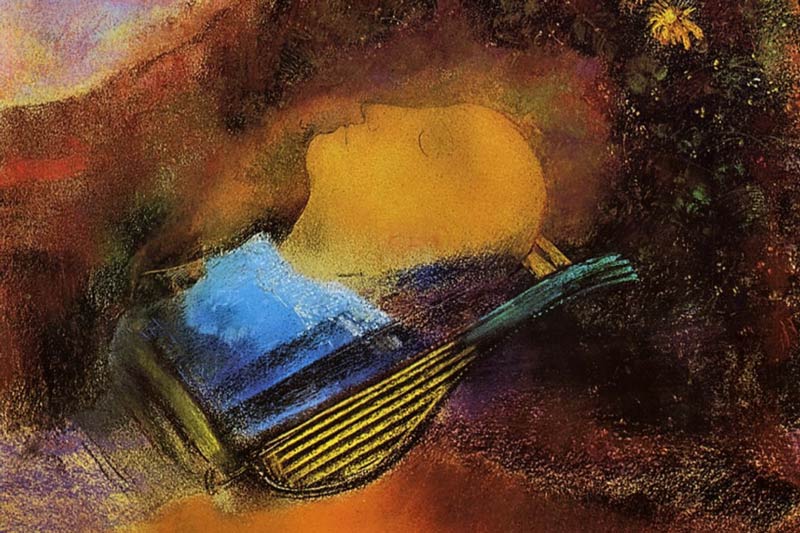
«Sempre caro mi fu quest’ermo colle» non è la stesso di «Mi è sempre piaciuta questa collina solitaria» e nemmeno «Questo colle solitario mi è sempre stato caro». Nel primo caso è abbastanza semplice capire la differenza: la frase è diventata colloquiale, quasi infantile, detta con noncuranza.
Nel secondo caso, invece, le parole sono quasi le stesse, ma ci rendiamo conto che non funziona: suona malissimo. “Solitario” è troppo lungo; le a e le o si ripetono ma in modo casuale, con un effetto sgradevole. Togliendo “solitario” la frase sembra quasi uguale, eppure nel verso di Leopardi le parole vibrano in modo molto diverso: “fu” non è semplicemente antico, è solenne; le parole risuonano come prese singolarmente, ad una ad una. La lettura è molto più lenta, scandita, meditata. Proprio perché ci porta in quel mondo di pensieri inafferrabili di cui è fatta la poesia.
Ecco quindi che la poesia, intesa come componimento poetico, come arte della parola (e non in senso lato, come potremmo dire: “la poesia di un film”) è un’opera linguistica che unisce suono e parola, attraverso dei versi. Esistono poi anche delle vie di mezzo, come le poesie in prosa, ma questa divisione, questa opposizione tra verso e prosa è fondamentale per comprendere la specificità del parlare poetico.
Si dice che si ha un verso quando in un discorso c’è un ritmo riconoscibile, e quando invece non c’è si ha una prosa. Ma è impreciso: il linguaggio ha sempre ritmo, in tutte le sue manifestazioni. Questo articolo ha un suo ritmo, una conversazione ha un suo ritmo, o persino un documento giuridico, una circolare. Dove sta la differenza? Nel fatto che il verso mostra sempre delle regolarità, dei pattern che ritornano e si succedono in modo riconoscibile: per esempio le rime, le sillabe, gli accenti.

Nella prosa, invece, questi pattern sono più mutevoli, più variegati. Versus, infatti, deriva da “vertere”, cioè tornare sempre su se stessi; prorsus, invece, significa “scorrere, procedere in avanti”, come il corso di un fiume.
La prosa di un romanzo può avere un andamento molto veloce, o molto lento; può essere più o meno strutturata, con richiami, ripetizioni, divisioni in blocchi che ricordino le strofe: è il caso, per esempio, dell’incipit del Mio Carso di Slataper:
Vorrei dirvi: Sono nato in carso, in una casupola col tetto di paglia annerita dalle piove e dal fumo. C’era un cane spelacchiato e rauco, due oche infanghite sotto il ventre, una zappa, una vanga, e dal mucchio di concio quasi senza strame scolavano, dopo la piova, canaletti di succo brunastro. Vorrei dirvi: Sono nato in Croazia, nella grande foresta di roveri. D’inverno tutto era bianco di neve, la porta non si poteva aprire che a pertugio, e la notte sentivo urlare i lupi. Mamma m’infagottava con cenci le mani gonfie e rosse, e io mi buttavo sul focolaio frignando per il freddo.
Vorrei dirvi: Sono nato nella pianura morava e correvo come una lepre per i lunghi solchi, levando le cornacchie crocidanti. Mi buttavo a pancia a terra, sradicavo una barbabietola e la rosicavo terrosa. Poi son venuto qui, ho tentato di addomesticarmi, ho imparato l’italiano, ho scelto gli amici fra i giovani piú colti; ma presto devo tornare in patria perché qui sto molto male.
Vorrei ingannarvi, ma non mi credereste. Voi siete scaltri e sagaci. Voi capireste subito che sono un povero italiano che cerca d’imbarbarire le sue solitarie preoccupazioni. È meglio ch’io confessi d’esservi fratello, anche se talvolta io vi guardi trasognato e lontano e mi senta timido davanti alla vostra coltura e ai vostri ragionamenti. Io ho, forse, paura di voi.
Nonostante un ritmo, una cadenza riconoscibile, rimane prosa, sia perché inserita in un contesto più ampio, sia perché la struttura è aperta e suscettibile di variazioni. Non c’è un ordine interno necessario, inevitabile, in cui ogni elemento è legato indissolubilmente agli altri, e che rende ogni parola insostituibile. Siamo molto vicini, ma non c’è ancora un grado di strutturazione ritmica tale da determinare ogni singola parte del discorso, come avviene invece nella migliore poesia.
Leggiamo, per esempio, Barche amorrate, dai Canti Orfici di Dino Campana:
…………………………………….
Le vele le vele le vele
Che schioccano e frustano al vento
Che gonfia di vane sequele
Le vele le vele le vele!
Che tesson e tesson: lamento
Volubil che l’onda che ammorza
Ne l’onda volubile smorza………
Ne l’ultimo schianto crudele……….
Le vele le vele le vele
È una poesia particolarissima, ma nella sua particolarità esprime estremamente bene la possibilità della poesia di farsi suono, musica. Parte con un silenzio, come se fosse uno spartito con una battuta vuota. È un frammento: qualcosa che si ritrova per caso, e che sembra quasi si sia fatto da solo. Non c’è un io che parla: non è un discorso. C’è un suono: «Le vele le vele le vele».
Proviamo a immaginare questo suono, a dirlo ad alta voce: «Le vele le vele le vele le vele le vele…». Nella ripetizione c’è qualcosa di magico e ammaliante. A un certo punto ci rendiamo conto che questo suono richiama il muoversi del vento, le folate ripetitive del vento. Nel secondo verso lo esplicita: «che schioccano e frustano al vento». E il vento cosa fa? Gonfia di vane sequele, di vani lamenti, quelle stesse vele. Le vele sono sia soggetto, sia complemento oggetto: c’è una circolarità assoluta. In questi quattro versi c’è un andamento progrediente (“le vele le vele le vele) poi smentito da un andamento recalcitrante, con «che schioccano e frustano», che, essendo parole sdrucciole, danno un senso opposto, di ripiegamento, come quando il vento si ritira. E di nuovo un proseguire in avanti, con il vento che gonfia le vele.
Questo avanzamento prosegue nella seconda parte: le vele tessono un lamento volubile, mutevole smorzato dalle onde. Sembrerebbe una situazione placida, in cui le vele vengono smosse dal vento e creano una nenia, triste magari, ma dolce. Invece Dino Campana inserisce parole come “ammorza” (cioè “spegne”) e “smorza” e poi un concetto nuovo: lo “schianto crudele”. E a questo punto la poesia prende tutt’altra strada, si carica d’inquietudine.
Cos’è questo schianto crudele? Non lo sappiamo. La poesia, invece di dare informazioni, spesso ce le toglie. E lavorando per sottrazione di informazioni, ci spinge a immaginare, a interrogarci, a cercare di capire. Il poeta gioca con la nostra immaginazione lasciandoci in sospeso, senza rivelare troppo. Non sappiamo se sia il vento, se siano le onde, se le barche si siano schiantate contro la riva o se siano state lasciate lì dai pescatori. Non sappiamo nulla, eppure l’immagine riverbera in noi grazie alle consonanti aspre usate dall’autore.

In pochissimi versi c’è un incredibile dinamismo: si parte con un acuto, con un suono alto e veloce: «le vele le vele le vele», per poi arrivare allo schianto crudele, cupo, grave, lento. E allora anche l’ultimo verso, apparentemente identico al primo, bisognerà leggerlo più lentamente, come se vi fossero delle virgole, o dei puntini di sospensione: «le vele, le vele, le vele…». Pause che non vengono inserite graficamente, è probabile, per rendere meglio la circolarità della poesia, da un lato, e per non rendere troppo didascalico il discorso, per lasciare una certa ambiguità interpretativa, una sospensione.
Ma ascoltandola interiormente, vocalizzandola, ci si rende conto di come siano diverse queste ultime vele dalle prime. Se le prime erano puro suono e fascinazione (anche con il punto esclamativo, nel quarto verso) le ultime sono cariche dell’inquietudine di questo schianto. Le vele, le vele, le vele. E ci rendiamo conto di quanto siano simili alla nostra vita. Anche noi, in un volgersi rapidissimo, volubile degli eventi. ci guardiamo indietro con l’angoscia di scorgere il nostro naufragio. Sarà stato un fallimento oppure no, la nostra vita? Ecco il motivo dell’ambiguità, della mancanza di informazioni di questa poesia: sono le stesse informazioni che mancano sempre a noi. Le vele, così fresche e baldanzose, ora sono percosse da un brivido, sono più cupe, più gravi, venate da una silenziosa domanda.
E ci possiamo rendere conto di tutto ciò solo leggendo ad alta voce, vocalizzando, interpretando questa poesia come fosse uno spartito. Possiamo discutere se leggerla più veloce o più piano, se prenderla più in alto o più in basso. Ma è molto chiauro che l’inizio è veloce e la fine è lenta. E non è per una regola metrica precisa e astraibile dal contesto. I versi sono tutti novenari: ma non c’è un novenario uguale all’altro. Anche quando gli accenti sono gli stessi, il contenuto della poesia ci induce a ripensarli in un altro modo.
Ecco allora che impariamo due cose: che il suono della poesia è fonte di significato ulteriore per la poesia, e che a sua volta questo suono è intrinsecamente legato al contenuto: nasce dal contenuto, e lo porta a un livello superiore di complessità. Non ci sono due livelli separati, il suono della poesia da un lato, la forma, e il contenuto dall’altro: sono un’unica cosa. Le rime, la scelta delle consonanti, la scelta del metro, non sono un bel modo di vestire un discorso, ma sono il modo per realizzarlo compiutamente.
Se l’articolo ti è piaciuto, leggi anche: La poesia come smarrimento