Anni, lustri, secoli, millenni fa qualcuno inventò la tragedia. La tragedia. L’arte di vestire con parole meravigliose le più inenarrabili perversioni dell’agire umano. Un’arte sottile e delicatissima, tanto difficile da padroneggiare quanto semplice da rovinare, in quelli che sono da sempre i suoi due più grandi punti di forza e, allo stesso tempo, i suoi più grandi punti deboli.
Il primo è rappresentato dalla violenza; e la violenza, fisica o psicologica che sia, è uno degli elementi più difficili da gestire sulla scena. La violenza da palcoscenico può far inorridire o commuovere, ma se gestita in modo grossolano può anche – e in modo del tutto involontario – fare davvero, davvero ridere. Il secondo elemento è il linguaggio. Quel linguaggio che nella tragedia antica aspirava al sublime, a una grandezza che si traduceva di solito in una retorica complessa e ricercata.
Se il tragediografo era bravo, questa ricercatezza poteva guadagnargli l’amore incondizionato degli spettatori, indipendentemente persino dal fatto che fossero o meno in grado di comprenderla: già nelle Rane di Aristofane, in fondo, una commedia rappresentata ad Atene nel 405 avanti Cristo, il dio Dioniso confessava con candore di aver “vegliato lungamente di notte a meditare che razza di uccello fosse un ippogallo rosso[1]” , la strana bestia che compariva in un verso del grande tragediografo Eschilo.
Se invece il tragediografo non era bravo, questa ricercatezza poteva produrre nel pubblico un’orchite letteraria di proporzioni cosmiche o, peggio ancora, incontrollabili accessi di riso, perché poche cose al mondo possono far ridere come quelle che, nell’intenzione di chi scrive, vorrebbero far piangere.
Nel corso dei secoli, a voler generalizzare, la tragedia ha attraversato nei vari paesi alterne fasi di splendore e decadenza. Di questo l’Inghilterra è un caso esemplare. L’epoca elisabettiana prima e quella giacomiana poi avevano regalato al regno d’Albione i nomi di Shakespeare, Marlowe, Webster, Middleton e compagnia briscola, autori che sapevano compensare le frequenti debolezze e – diciamolo – le indubbie pacchianate insite nelle loro trame con una versificazione intelligente, dinamica e originalissima. Nel corso del XVII secolo, poi, un cambio di gusto aveva portato gli autori a moderare le quantità di sangue versato nel corso dell’azione: nella tragedia inglese di epoca barocca si faceva poco, si parlava molto, si moriva con parsimonia e sempre in modo violento ma non troppo. I grandi autori, primo fra tutti l’immortale John Dryden, sapevano tirar fuori il meglio da questa staticità mettendo in bocca ai loro personaggi veri e propri gioielli di poesia che, anche in questo caso, servivano a far passare in secondo piano le loro eventuali faiblesse drammaturgiche. All’autore di versi come
Amore è un fiato che l’occhio non vede:
L’afferra sol chi d’afferrarlo crede;
Lo crea la Fantasia, poi la Speranza
Gli dà un corpo e lo veste di sostanza.
Sembra un incanto, poi, goduto, fugge:
Il sogno gli dà vita, e un tocco lo distrugge.
si sarebbe potuta perdonare qualsiasi cosa[2].

Questo precario equilibrio tra qualità dei versi e qualità della trama andò – come dire? Ecco, sì: andò completamente a puttane nel secolo successivo. Saranno le trame, ormai standardizzate fino allo stremo, saranno i versi, tanto artificiosi e magniloquenti quanto insipidi, ma sta di fatto che per chi si è avvicinato alla tragedia inglese con gli elisabettiani la lettura di una tragedia del ‘700 diventa un qualcosa da augurare all’uomo che durante l’ora di punta vede un parcheggio libero dieci secondi prima di te.
Questo tipo di teatro tragico continuava, è vero, a riempire le sale, ma spesso più che l’effettiva qualità del dramma era ormai la presenza di questo o quell’attore a determinarne il successo. Per i più sensibili tra gli autori era ormai lapalissiano che ci fosse un qualcosa di marcio in questo modo di fare teatro, in questo squallido sistema per colpa del quale lo spettatore “perde il suo tempo e il suo denaro sciala, / poi, senza giovamento, alfin lascia la sala[3]”. Alcuni di loro, quelli secondo i quali il pubblico aveva sempre e comunque ragione, tacevano e scribacchiavano. Altri, come l’arguto commediografo Henry Carey, decidevano invece di passare al contrattacco.
Che Henry Carey, un simpatico gentiluomo che aveva passato tutta la sua vita nel mondo del teatro comico e delle pantomime, potesse voltar pagina e presentarsi al suo pubblico calzando il coturno era cosa che pareva incredibile. E infatti non ci credeva nessuno. Nemmeno lui, che reclamizzando il suo nuovo parto letterario del 1734 come “la più tragica tragedia che mai sia stata tragedizzata da una compagnia di tragedianti” già sembrava dirla lunga su quanto vi sarebbe stato di veramente tragico in questa sua ultima fatica. All’alzarsi del sipario, invero, la scenografia non prometteva nulla di originale: l’anticamera di un palazzo reale, del solito palazzo reale da tragedia. Subito dopo due cortigiani, i soliti cortigiani da tragedia, entravano in scena. Poi iniziava il dialogo, che a rigor di logica avrebbe dovuto essere un po’ il solito dialogo da tragedia. E invece no.
RIGDUM-FUNNIDOS:
Aldiborontiphoscophornio!
Dove hai lasciato Chrononhotonthologos?ALDIBORONTIPHOSCOPHORNIO:
Stremato dagli strazi della guerra,
Nella regia sua tenda, abbandonato
Sul soffice divano, egli nel sonno
Va cercando ristoro alla fatica: […] Eppur non posso dire che sia sonno,
Ma una sorta di lieve assopimento,
Un dolce sonnecchiar che annebbia i sensi:
Ora muove la testa, ora lo vedi
Che russa, ora si desta all’improvviso;
Poi muove ancor la testa, e poi ancora
Ricomincia a russar. Se questo è sonno
– Parlate, o dèi! – chi tra i mortali è sveglio?
Tu che ne dici, amico?RIGDUM-FUNNIDOS:
Che dico! Dico che dorme da cani, che accidenti vuoi che ti dica?(Carey, Chrononhotonthologos – atto unico, scena 1)
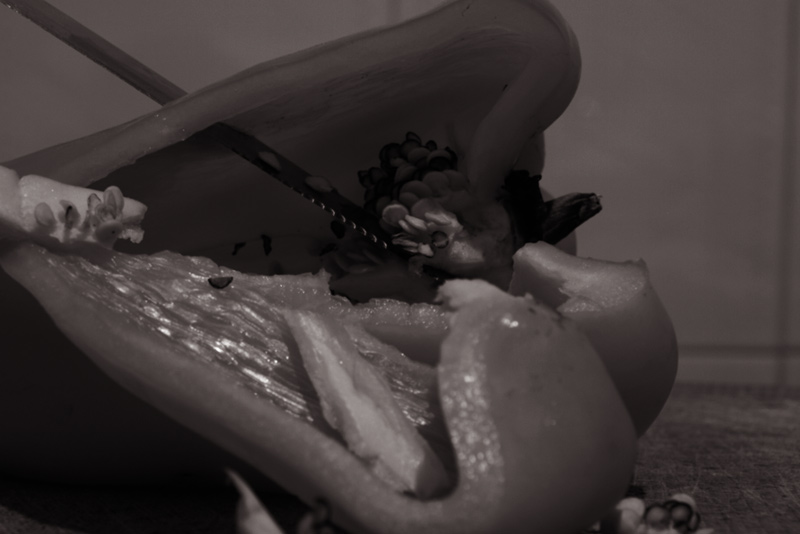
L’ilarità degli spettatori, a questo punto, si può solo immaginare. In una dozzina di versi Carey aveva già toccato e volto in ridicolo quasi tutti i più triti meccanismi del tragico. I nomi dei cortigiani e quello del loro signore, Chrononhotonthologos re di Queerummania, facevano il verso alla mania per l’esotico e l’altisonante degli autori delle moderne tragedie; il nome di Aldiborontiphoscophornio, poi, era un vero colpo di genio: era lungo quanto un intero pentametro, il verso prediletto dai tragediografi inglesi. Per immaginarne l’effetto sul pubblico dell’epoca, pensate al personaggio di una tragedia di Vittorio Alfieri il cui nome occupi tutto un verso endecasillabo dall’inizio alla fine, una cosa tipo Alessandrogualtierdamiancostanzo.
L’intento dell’opera, già a questo punto, era chiarissimo: mostrare al pubblico, esagerandole e distorcendole, tutte le pecche del tipo di tragedia che in quegli ultimi anni aveva spadroneggiato sulla scena inglese. Aldiborontiphoscophornio, in soli trenta secondi, aveva già messo a nudo tutta la vuotezza di quelle tirate che facevano uso di termini aulici e roboanti per descrivere anche la più banale delle situazioni. Rigdum-Funnidos, invece, qui rappresentava la voce di chi, con un po’ di sano buonsenso, aveva il coraggio di replicare a un simile sproloquio con quella che nel mondo reale sarebbe stata l’unica risposta possibile: “che cazzo stai dicendo?”.
La storia, in breve, prosegue così. Il regno di Queerummania viene invaso dagli Antipodiani, gli abitanti dell’altra parte del mondo che, com’è logico, camminano a testa in giù poggiando le palme delle mani a terra. Dopo una sanguinosa battaglia i nemici vengono messi in fuga, ma il loro sovrano viene fatto prigioniero da re Chrononhotonthologos. La faccenda si complica quando entra in scena Fadladinida, la giovane regina di Queerummania, accompagnata dall’onnipresente damigella Tatlanthe. La moglie di Chrononhotonthologos è bellissima, e il suo ingresso nella storia porge a Carey il destro per mettere in ridicolo un’altra consuetudine drammaturgica, quella che vuole l’eroina costantemente coperta di lodi iperboliche.
PRIMA DAMIGELLA:
Certo è la prima volta che cammina
Su questa terra una sì gran regina!SECONDA DAMIGELLA:
Ma che regina, è un angelo!PRIMA DAMIGELLA:
Una dea!TATLANTHE:
Di tutte e tre le cose è viva idea! […]FADLADINIDA:
Qui un ventaglio; arrossisco come un pomo.PRIMA DAMIGELLA:
Ma quel rosso vi dona!TATLANTHE:
Ah, fossi un uomo!(Carey, op. cit. – scena 2)

Fadladinida, che incoraggiata da Tatlanthe nutre una segreta passione per il re degli Antipodiani, decide di recarsi nottetempo nella sua cella per consegnargli un anello come pegno d’amore. La regina trova il re prigioniero addormentato, ma nonostante cerchi in tutti i modi di svegliarlo con dolci parole, le sue appassionate dichiarazioni d’amore ottengono l’unico effetto di farlo russare ancora più forte. Confusa e smarrita, la regina rivolge un’accorata preghiera a Venere perché giunga in suo soccorso. In mezzo alla cella appare dunque in tutto il suo splendore la dea della bellezza che, cantando con la grazia di una pescivendola, predice a Fadladinida un roseo futuro pieno di gioie amorose:
VENERE:
Scende Venere, dea dell’amore,
Trallallero, lallero, lallero,
Che t’è amica con tutto il suo cuore,
Trallallero, lallero, lallà.
Ella guarda con occhio pietoso,
Trallallero, lallero, lallero,
Il tuo dolce trasporto amoroso,
Trallallero, lallero, lallà.(Carey, op. cit. – scena 4)
L’intreccio del breve quanto avvincente dramma comincia ad avviarsi verso la sua conclusione allorché, il giorno successivo, Chrononhotonthologos viene invitato dal prode generale Bombardinian a passare la notte nella sua tenda in compagnia di due procaci schiave poco vestite. Il re, evidentemente ignaro di cosa la Musa tragica tenga di solito in serbo per i suoi protagonisti nell’ultima scena, accetta volentieri.
Nella tenda di Bombardinian il re viene ricevuto con tutti gli onori: ad attenderlo, oltre al generale e alle due schiave, trova anche un cuoco pronto ad ammannire un succulento banchetto. I piaceri del sovrano sono tuttavia destinati a durare ben poco, e infatti vengono guastati dopo solo quattordici versi da un’inopportuna richiesta di danaro da parte del cuoco, che non ha di che comprare la carne da arrostire. L’audacia di quel gesto è più di quanto il superbo sire di Queerummania possa tollerare da un suo suddito: in un impeto d’ira, Chrononhotonthologos infilza il pover’uomo con la sua spada e, non pago, rivolta con un ceffone la faccia di Bombardinian che ha cercato di minimizzare l’accaduto con una battuta. Anche il generale, però, non è uomo da sopportare un simile affronto.
BOMBARDINIAN:
E Bombardinian soffrirà uno schiaffo?
Sole, arrossisci! Ritirati, Oceano!
Si disgreghino i colli, i monti, i mari,
E il mondo torni polvere nel Caos!
Bombardinian è stato schiaffeggiato,
E Chrononhotonthologos morrà!(Carey, op. cit. – scena 5)
Bombardinian sfodera la spada e trafigge il re, salvo poi pentirsi subito dopo e affannarsi a cercare aiuto tuonando quello che è probabilmente l’ordine più circostanziato che un uomo abbia mai proferito:
BOMBARDINIAN:
Si chiami un cocchio, un cocchio sia chiamato;
E chi lo chiama il chiamante ne sia,
E che, nel suo chiamar, costui non chiami
Che un cocchio! Un cocchio! Un cocchio, per gli dèi!(Carey, op. cit. – scena 5)

Giunge trafelato un dottore, messo in allarme dalle grida, ma è troppo tardi: il buon cerusico non può far altro che constatare il decesso del re. Il che è un gravissimo errore, perché subito dopo averlo fatto si vede assestare un fendente in petto dall’esasperato Bombardinian che poi, finalmente, volge la spada contro se stesso liberandoci della sua chiassosa presenza. L’ingresso di tutti i personaggi sulla scena marca a questo punto l’inizio del gran finale dell’opera. La scena che, nella tenda del defunto generale, si presenta agli occhi dei cortigiani e della regina Fadladinida è agghiacciante:
ALDIBORONTIPHOSCOPHORNIO:
Orrore! Ah, più che orrendo, orrido orrore!
Il re, il cuoco, il dottore, il generale!
Morti, stramorti, morti senza scampo!(Carey, op. cit. – scena 5)
Tutti si lasciano sfuggire un gemito d’orrore – un tragico gemito d’orrore, come la didascalia si premura di puntualizzare. Epperò, dopo che Fadladinida ha espresso tutto il suo dolore inconsolabile in un lungo e sincero piagnisteo di quattro versi, la furba Tatlanthe suggerisce alla sua signora di accomodare le cose nel migliore dei modi sposando il prestante Rigdum-Funnidos. La proposta suscita le ire di Vattelapescophornio, che aspira alla corona reale e si dice pronto a uccidere il collega qualora provi anche solo a pensare di scavalcarlo. La compassionevole Fadladinida però ha già pronto il piano B: il doppio matrimonio della regina con Rigdum-Funnidos e, contemporaneamente, con Aldiboroneccetera chiude felicemente la tragedia.
Il Chrononhotonthologos di Henry Carey non salvò la tragedia inglese. Gli spettatori vi assistettero ridendo di gusto, ma la sera dopo tornarono tutti a far la fila davanti a un altro teatro per l’ennesima messa in scena della morte di Giulio Cesare, di Regolo, di Semiramide. Lo stesso Carey, probabilmente, non si aspettava nulla di diverso. Eppure questa parodia, questo puro divertissement la cui durata non supera neanche un’ora, riuscì nell’intento in cui dieci, cinquanta, cento tragedie dello stesso periodo fallirono miseramente: farsi ricordare. Il testo a stampa conobbe un successo enorme, e ancora nell’ ‘800 si poteva far riferimento al nome di Chrononhotonthologos senza timore che la citazione non venisse compresa: valga per tutti l’esempio di Walter Scott, il celebre autore di Ivanhoe, che affibbiò ai suoi editori John e James Ballantyne i soprannomi, rispettivamente, di Rigdum-Funnidos e Aldiborontiphoscophornio.
A nessuno dei tragediografi del primo ‘700 fu concesso il medesimo onore, ma via, in fondo c’è poco da stupirsi. Qualcuno di loro sarà stato sicuramente animato dalle migliori intenzioni. Qualcuno di loro ce l’avrà anche messa tutta. Qualcuno di loro, non ne dubito, avrà anche aspirato a una gloria più duratura di quella data dall’applauso di una sera. Ma non c’è niente da fare. Davanti a una tragedia che comincia con due versi come “Aldiborontiphoscophornio! / Dove hai lasciato Chrononhotonthologos?” puoi solo star zitto e nasconderti.
Immagini: progetto fotografico di Martina Trotta, Scena del crimine.
Le citazioni sono tratte da un testo a stampa del Chrononhotonthologos pubblicato a Edimburgo nel 1734, consultabile su Google Books a questo link. Per rendere l’articolo più accessibile ai lettori che non hanno familiarità con la lingua inglese dell’epoca, ho scelto di tradurre alcuni passi dell’opera trasportandone la metrica e le rime in italiano. In alcuni casi, la mia decisione ha comportato qualche rimaneggiamento – spero non troppo marcato – del contenuto del testo.

